“Al rombo del cannon” / La Grande guerra cantata
Il 4 novembre 1918, l'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno prima da Italia e Austria-Ungheria, poneva fine alle ostilità fra i due Paesi. Una settimana dopo, la Prima Guerra Mondiale era finita. Evento cardine della modernità novecentesca, la Grande guerra gettava le basi di un equilibrio fragile, destinato a sfociare in un altro e ancora più sanguinoso conflitto. A un secolo esatto di distanza, che cosa rimane di quella terribile esperienza? Siamo stati davvero capaci di elaborare il trauma, o stiamo nuovamente cadendo preda di pulsioni revansciste, militariste e xenofobe? Con l'aiuto di storici, scrittori e studiosi, attraverso una serie di interventi – qui e qui i primi due contributi - cerchiamo di ricostruire l'impatto del primo conflitto mondiale sulla coscienza collettiva. Un modo per ripensare la memoria della Grande guerra, con un occhio al futuro.
Tutte le mattine, alle elementari, negli anni intorno al primo centenario dell’unità d’Italia, il maestro ci faceva alzare e ci faceva intonare “Il Piave mormorava”, come tanti soldatini con il grembiulino nero e con il fiocco tricolore. Era il 1961, ma nei colori sfumati del ricordo quel “non passa lo straniero, zum zum” mi pare di averlo cantato per tutte le elementari, ogni mattina. La leggenda del Piave era stata scritta nel giugno 1918 dopo una vittoriosa e sanguinosa offensiva dell’esercito italiano da un musicista napoletano, E.A. Mario (Giovanni Ermete Gaeta), autore di altri motivi popolari come Santa Lucia luntana e, dopo l’altra guerra, Tammurriata nera. Era perfino stata proposta come inno italiano al posto di quello di Mameli, ed era penetrata profondamente nella nostra società.
La Grande guerra ha prodotto molte canzoni, o ne ha riadattate di antiche, trasmesse spesso attraverso i cori alpini o altri tipi di cori e cantori. Le più note sono patriottiche, ma troviamo anche famosi motivi napoletani come Ninì Tirabusciò e ‘O surdato ‘nnamorato. Già qualche anno dopo la fine del conflitto venivano pubblicate raccolte di canti intonati nelle trincee, come quelle compilate da padre Agostino Gemelli, da Pietro Jahier e da Cesare Caravaglios, un folklorista che diede alle stampe l’opera più completa, I canti delle trincee. Contributo al folklore di guerra (1930 e poi, in edizione fortemente ridotta, 1935).
In quei libri rintracciamo i canti ufficiali. Perché si potessero ascoltare le altre canzoni, quelle che narravano il massacro, il macello, o anche solo quelle che dichiaravano la poco marziale nostalgia di casa, degli affetti cui si era stati strappati per essere precipitati nel freddo, nel fango, nell’insopportabile fragore perenne delle granate e delle bombe, bisognò aspettare. Poco dopo il 1918 arrivò il fascismo, che narrò il conflitto solo dal punto di vista dell’arditismo e della vittoria mutilata, riutilizzando a modo proprio canzoni più vecchie come Giovinezza. Fu steso un velo sulla memoria e furono perfino abbattute statue e lapidi ai caduti che mostravano soldati reclinati nel dolore, nell’abbandono, nella malinconia, nella morte. Tanti cippi e monumenti avevano invaso l’Italia, a ricordare un’immane tragedia cui avevano partecipato sei milioni di italiani e alcune decine di milioni di europei: molti di essi durante il fascismo furono demoliti e ricostruiti con pose più eroiche.

“O Gorizia tu sei maledetta” e le altre
La memoria sembra riemergere tardi dalla rimozione del primo dopoguerra e da quella della nuova Italia democristiana del secondo dopoguerra che, messo tra parentesi il fascismo, puntava a una narrazione dell’unità nazionale e dell’identità italiana che si compiva con la Grande guerra e si rinnovava con la Resistenza. Una storia patriottica che dal Risorgimento arrivava alla nuova repubblica interclassista. Per scoperchiare il rimosso bisogna aspettare gli anni sessanta e quello spettacolo, Bella ciao, che nel 1964 al festival di Spoleto scandalizzò i buoni borghesi soprattutto con “O Gorizia tu sei maledetta” (qui una sintesi dello spettacolo da un filmino a 8 mm girato nell’occasione). Erano iniziate da qualche anno le indagini etnomusicologiche, grazie a ricercatori come Alan Lomax o Roberto Leydi che, armati di magnetofono, battevano le campagne e le montagne in cerca delle memorie delle classi subalterne. Nel 1963 Leydi aveva pubblicato Canti sociali italiani con le Edizioni Avanti! del Partito socialista. A Torino agiva da qualche anno il gruppo Cantacronache e nel 1963 si forma il Nuovo Canzoniere Italiano animato da Gianni Bosio e dallo stesso Leydi, intorno a cui si riuniscono intellettuali e cantanti, colti e popolari, da Sandra Mantovani alla ex mondina Giovanna Daffini, da Giovanna Marini al Duo di Piadena.
Lo spettacolo di Spoleto lo hanno raccontato in tanti. Ricordo un brano dell’articolo scritto cinquant’anni dopo, per Doppiozero, da Jacopo Tomatis (chi lo voglia leggere integralmente lo trova qui):
La ricca aneddotica sulle prime repliche riporta, ad esempio, di quella “signora impellicciata” che, in risposta al verso “E nelle stalle più non vogliam morir” (dal canto “E per la strada gridava i scioperanti”) si alzò dalla platea ed esclamò a gran voce “Io possiedo trecentotrenta contadini e nessuno dorme nelle stalle!”, richiamando a una rapida reazione Giorgio Bocca, da uno dei palchi (“Va’ fuori, carampana”). In una situazione già tesa, il momento decisivo si verificò quando, il 21 giugno, complice un abbassamento di voce della Mantovani, Michele Straniero si trovò a cantare la canzone antimilitarista “O Gorizia tu sei maledetta”. Per incidente, o per deliberata provocazione, ne cantò la versione che conosceva, compresa una strofa – “Traditori signori ufficiali / che la guerra l’avete voluta / scannatori di carne venduta / e rovina della gioventù” – che non era in copione. Il risultato fu una denuncia per vilipendio alle forze armate, e una pubblicità incredibile. Non fu tanto il testo in sé a scatenare le reazioni – “O Gorizia” era nota da tempo, e già pubblicata su disco – ma la sfida, l’idea stessa di portare quella visione del popolare come altro – radicale e per nulla accondiscendente – in un contesto borghese e aristocratico. In questo senso, e proprio per la sua eco polemica, Bella ciao fu decisivo.
Dopo quello spettacolo altri ne seguirono, che indagavano e riproponevano la voce degli ultimi, quella di un’altra Italia di volta in volta rassegnata o pronta all’invettiva o alla ribellione. Come i vari Ci ragiono e canto animati da Dario Fo, come il cabaret antimilitarista dei Gufi o spettacoli come Gorizia 1916 - Documentario per il teatro sulla prima Guerra Mondiale di Vittorio Franceschi e tanti, tanti altri.
Le ricerche e gli spettacoli continuano fino ai primi anni ottanta, indagando un’Italia subalterna e spesso antagonista, incapace di rassegnarsi all’ingiustizia, una cultura altra rispetto a quella dominante, in cui si pensava di trovare voci e modelli per il futuro. Ma erano altri tempi da questi nostri.
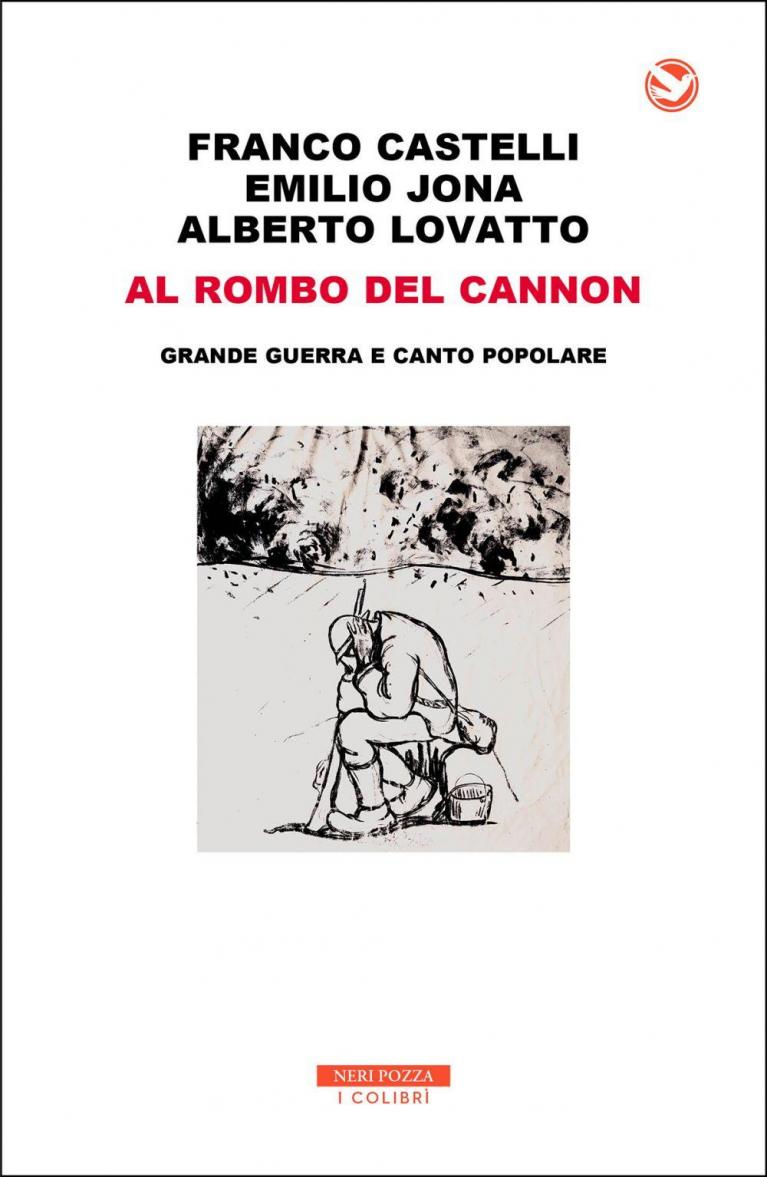
Canzonieri di guerra
Di recente, Al rombo del cannon. Grande guerra e canto popolare di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto, pubblicato da Neri Pozza, un librone di più di ottocento pagine con due CD allegati, ha riproposto la questione delle canzoni di guerra e soprattutto quella dei brani rimossi e delle strade attraverso la quali è stata trasmessa e conservata la memoria. I due CD contengono rispettivamente 83 e 78 tracce: frammenti in genere inferiori al minuto di registrazioni di anziani effettuate per lo più negli anni sessanta e settanta. I “cantanti” (ma molte volte raccontano, iniziano un motivo e poi non ricordano come va avanti il testo…) spesso sono nati prima del 1900: la guerra l’hanno vissuta direttamente o attraverso le lettere e soprattutto le cartoline dal fronte, per quanto censurate, e poi nel racconto dei reduci.
Si ricompone così, innanzitutto, una memoria acustica, con voci malferme, con intonazioni diverse da quelle patinate dello showbiz, e si evoca un intero mondo: l’arditismo e l’apocalisse, le strofette contro il general Cadorna, Cecco Beppe o gli imboscati; contro il macello, il sangue versato dei giovani, classe 1899 o 1900, che “fa ancor pipì nel letto” e vengono mandati a morte certa. Si ascoltano le canzoni note, degli alpini, dei bersaglieri, magari con qualche variante locale, dialettale, di gruppo; strofette satiriche del Sor Capanna che, nel solco del più becero maschilismo patriarcale, irride alle donne usate al posto degli uomini in guerra per guidare i tram; e di quel genere definito Bombacè, che si chiudeva col ritornello “Bim bam bom, al rombo del cannon”. Si sente imperversare frastornante quel fragore di bombe e mitraglia, nelle teste, e quel massacro, nelle parole riadattate da vecchie canzoni risorgimentali, come quella del matrimonio di Venezia (“O Venezia che sei la più bella”), che a un certo punto fa: “Un bel giorno entrando in Venezia / tuto il sangue scorreva per terra / i soldati in tempo di guerra / tutto il popolo gridava pietà”.

Coro di soldati con accompagnamento di chitarra (collezione Brian-Zamboni, dal libro “Al rombo del cannon”).
Il libro fa il punto sulla trasmissione dei motivi dall’Ottocento al crogiolo della trincea, dove si incontrano sei milioni di italiani, in buona parte analfabeti, parlanti dialetti differenti. In quei gironi danteschi del primo massacro tecnologico mondiale si metteranno a punto la lingua nazionale e nuovi modi di comunicare, con canzoni di tutti i tipi, fogli volanti di cantastorie, cartoline postali alla famiglia, propaganda bellicista e antibellicista firmata molte volte da poeti e intellettuali, pellicole di guerra; una nuova funzione assumeranno naturalmente l’uso del telefono e del telegrafo per trasmettere ordini da retrovie lontane dai teatri delle operazioni, in una prima proiezione virtuale e globale del mondo. Si formerà anche una memoria resistente e alternativa. Bisognerà forare la rimozione di più di quarant’anni per arrivare, a partire dagli anni sessanta, a riscoprire non solo la resistenza e l’opposizione popolare attraverso il canto ma anche a rendersi conto dell’insubordinazione, della renitenza e della fuga dalla leva, e dei livelli feroci di repressione conseguenti.
Gli autori di Al rombo del cannon si interrogano anche sulla valenza di opposizione che ricoprono motivi apparentemente non ostili alla guerra, rivisitazioni di formule tradizionali di canzoni che esprimono lontananza, struggimento, voglia di non essere in quel posto. Ed elencano le strofette che, più o meno accettate dai comandi, deridono il nemico, spesso senza fare sconti neppure agli stati maggiori: ma tanto, si sa, la satira spesso è solo una valvola di sfogo. Allora, sul ritmo del Bombacè, leggiamo vari couplet sulla moglie di Francesco Giuseppe (per altro risalenti probabilmente alle guerre risorgimentali), tra le quali: “La moglie di Cecco Beppe l’andava ‘ns l’altalena / l’andava tanto forte ch’la mustrava la filumena”; poi ne esiste una serie dedicata al generale supremo, Luigi Cadorna, responsabile dei massacri inutili e infine della disfatta di Caporetto, l’uomo che teneva insieme l’esercito con una disciplina vicina al terrore: “Il general Cadorna ha scritto alla regina / se vuoi veder Trieste te lo mando in cartolina”; oppure: “Il general Cadorna si mangia le bistecche / e ai poveri soldati dà le castagne secche”, tutti conclusi dal solito ritornello o da qualcuna delle sue molte varianti: “Bim bam bom, al rombo del cannon”.
Gli autori del volume recensiscono anche testimonianze di intellettuali che parteciparono alla guerra, da Omodeo a Calamandrei, da Mussolini a Emilio Lussu, a Comisso, agli autori delle raccolte di canti già citati. La maggior parte sono favorevoli al conflitto, spinti dal mito del compimento del Risorgimento, del cimento per formare veramente l’Italia. Eppure da qualche descrizione traspare il rimosso, l’apocalisse della modernità che si manifestò nelle trincee.
E poi spiccano vari testi, come “O Gorizia tu sei maledetta”, come Monte Nero:
Monte Nero Monte Nero / traditor della vita mia
ho lasciato la casa mia / per venirti a conquistar.
Per venirti a conquistare / abbiam perduto molti compagni
tutti giovani sui vent’anni / la loro vita non torna più.
Con subito una ripresa che allontana il “disfattismo”:
Il colonnello che piangeva / a vedere tanto macello
fatti coraggio alpino / bello che l’onore sarà bello.
Ma intanto il bagno di sangue, il macello, era stato nominato. E altre canzoni, spingevano le cose più avanti, al sogno di una riscossa sociale che abbattesse i padroni e scongiurasse guerre future:
[…] Basta e basta / massacratori dell’umanità
basta e basta / Lenin vi pagherà.
Maledizione la guerra e il cannone / la munizione che uso vi dà
o santo giusto verrà quell’ora / chi non lavora non deve mangiar.
[Da una registrazione del 1963 di Cesare Bermani nel ferrarese.]

“Die Glückliche Hand”, bozzetto di Arnold Schönberg.
La perdita dell’innocenza
In La Grande guerra e la memoria moderna, volume pubblicato in Italia dal Mulino nel 1984 (ma l’originale è del 1975), proprio nel periodo in cui si moltiplicano gli studi, Paul Fussell racconta la “perdita dell’innocenza” dei letterati inglesi nella guerra di trincea, l’irrompere dell’orrore su una produzione spesso segnata dal disimpegno ovattato e perfino dall’arcadia. In quegli anni, tra i Sessanta e gli Ottanta del Novecento, si disseppelliscono dagli archivi i documenti e si revisiona la storiografia sulla Grande guerra, per esempio con le opere di Mario Isnenghi.
Lo studio citato di Castelli, Jona, Lovatto, è segno di una fase di approfondimenti, o di ritorni, su argomenti specifici, non indagati ancora in modo complessivo. Il suo merito, tra gli altri, è quello di scavare in un grande repertorio che costituisce per la prima volta un canzoniere italiano. Si legge:
Sei milioni di soldati […] prelevati dalle loro piccole patrie e gettati nella fornace della guerra, tutti portatori di una Babele di linguaggi dialettali […] per la prima volta si incontravano e si scontrarono in un immenso rimescolamento di culture locali e di alfabetizzazione forzata […]. La concentrazione di queste masse di soldati privilegiò […] un canto non più dialettale ma italico, prodotto da soldati che in genere non sapevano per chi e per cosa combattevano e non avevano in testa l’Italia, ma il casolare, il paese, la madre, la moglie e i figli, e a quei luoghi e a quegli affetti era rivolta la maggior parte dei loro pensieri.
Forse, però, la parte più interessante, quella che ci riguarda più da vicino, è dove si evidenzia la rimozione e si mostrano, attraverso le registrazioni dei testimoni, i canali sotterranei che la memoria contro, o anche semplicemente una precisa memoria, ha dovuto scavare per riemergere alla luce. In tal modo, in controluce, si può leggere come continuamente, in Italia, quella che vien sbandierata come memoria, come identità nazionale da condividere, intorno a cui ricompattarsi, sia qualcosa di parziale, che nasconde sotto il tappeto la terra insanguinata della guerra continua agli ultimi, ai miti, ai senza potere. Le celebrazioni del centenario avrebbero dovuto riprendere e diffondere alcune di queste canzoni contro.
O anche, cambiando ambito, questo anniversario avrebbe dovuto ricordare meglio, ribadire, che la fine della musica classica risale a quegli anni, ai presagi della deflagrazione o al macello in corso o avvenuto. La Nona sinfonia di Mahler – composta tra il 1909 e il 1910 a Toblach, quella che dopo la guerra si chiamò Dobbiaco, oggi vicino a un allucinante piccolo cimitero di guerra austro-ungarico, fitto di croci con nomi di soldati slavi, croati, non lontano dai camminamenti delle trincee in quota, chilometri e chilometri di cunicoli in parte riciclati come attrazioni turistiche – la Nona sinfonia inizia solenne e struggente, percorre molte strade fino all’esplosione e alla calma del requiem. Alban Berg di essa scriveva: “Il primo movimento è la cosa più splendida che Mahler abbia scritto. È l’espressione di un amore inaudito per questa terra, del desiderio di vivere in pace con la natura e di poterla godere fino in fondo, in tutta la sua profondità, prima che giunga la morte. Perché essa arriva senza scampo. L’intero movimento è permeato dal presentimento della morte”. In Schönberg è scritto in note dissonanti il protocollo dell’orrore già dalle allucinate Erwartung (1909) e Die Glückliche Hand (1910-1913).
La Grande guerra, con il martellare dei suoi discorsi interventisti e patriottardi, con la sua stentorea propaganda che imbelletta una realtà orribile, con i suoi massacri seriali spiegati o imposti al popolo, con i suoi lucrosi affari e i suoi parassiti e pescicani travestiti da benefattori della patria, con la sua sproporzione inusitata delle dimensioni di un boato infinito, costituisce l’oggetto esclusivo di un “dramma, la cui mole occuperebbe, secondo le misure terrestri, circa dieci serate”, quegli Ultimi giorni dell’umanità (1922), tragedia dal titolo emblematico in cinque atti e circa 800 pagine di deliri verbali e cacofonie, concepita secondo il suo autore, Karl Kraus, “per un teatro di Marte”. Dell’opera di Kaus si ricordano un adattamento di Luca Ronconi del 1990, al Lingotto di Torino e uno spettacolo del 2014 di Archivio Zeta ambientato nel Cimitero militare germanico del Passo della Futa, che ospita le tombe di più di 35.000 soldati morti nella Seconda guerra mondiale.

“Gli ultimi giorni dell’umanità – Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus” di Archivio Zeta (E. Sangiovanni, G. Guidotti), 2014-16
Ma pochi brani, citando una canzone, raccontano la perdita dell’innocenza come le pagine finali della Montagna magica di Thomas Mann, pubblicato nel 1924: lo sgretolarsi di un’innocenza forzata, sospesa, un rifugio alle tempeste di un mondo avvertito in turbinosa trasformazione. Hans Castorp, che ha provato a rimandare l’ingresso nella vita chiudendosi in un sanatorio tra le montagne svizzere, ultimo fannullone romantico, tra i primi inetti novecenteschi, viene alla fine precipitato nella guerra, all’assalto. E lo vediamo, nell’explicit del romanzo, avanzare con la baionetta spianata tra le granate che cadono, tra i corpi di compagni che esplodono, tra il fango e il sangue strisciare cantando tra sé e sé un vecchio Lied romantico di Schubert, Der Lindenbaum, il tiglio:
“Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort”
(nella corteccia incidevo tante dolci parole)
Il canto è spezzato dall’azione della battaglia:
“Cade. No, si è gettato a pancia sotto perché un latrato di cane si avvicina, un grosso proiettile dirompente, uno schifoso pan di zucchero che sale dall’abisso. […]”
E poi canta, ancora, con le parole che si spezzano:
“Und sei-ne Zweige rau-uschen
Als rie-fen sie mir zu…
(e i suoi rami mormoravano, / come per dirmi…)
E così via, nel trambusto, nella pioggia, nel crepuscolo scompare alla nostra vista.”
Il Lied (leggi la traduzione del testo intero qui) era stato citato molte pagine prima, quando Castorp aveva trovato nel sanatorio un grammofono e alcuni dischi. È il quinto del Winterreise di Schubert, la fuga di un viandante desolato per un amore finito in una campagna congelata come il suo cuore. Nel partire, i rami spogli di un tiglio gli ricordano l’estate, quando si stendeva sotto la loro ombra rinfrescante, protettrice, e lo invitano ancora a fermarsi per dormire sotto la loro protezione. Ma, lo capiamo subito, giacere ora vorrebbe dire ghiacciare tra le braccia della morte.
Il richiamo della sirena della pace estiva è forte per il viandante, ma nasconde in sé l’inganno della morte. Eppure il ricordo dei rami verdi è vivo e indistruttibile, come quei motivi popolari che abbiamo ripercorso, come questa cantilena senza speranza di un secolo prima della Grande guerra che Castorp biascica mentre va all’assalto, da tenere stretta come il vecchio mondo che esplode senza un domani, come tutte le fragili musiche che abbiamo ricordato, intonate per provare a contrastare il rombo mortale del cannon.
Crediti bibliografici
Grazie alla storica libreria Laterza di Bari per alcuni libri e suggerimenti.
I testi citati sono: Paul Fussell, La Grande guerra e la memoria moderna, il Mulino, 1984; Thomas Mann La montagna magica, nella traduzione di Renata Colorni per i Meridiani Mondadori, 2010; Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell’umanità, Adelphi, 1980. Le immagini dell'allestimento di Archivio Zeta sono di Franco Guardascione.
Al rombo del cannon, di Franco Castelli, Emilio Jona, Alberto Lovatto è stato pubblicato nel settembre del 2018 da Neri Pozza (pp. 832, euro 60).









