La scuola è un sogno
Anna Stefi: «Quando si entra a scuola si ha una doppia impressione: da una parte, sembra che il tempo si sia fermato, nulla sia cambiato […], il quadro nostalgico lascia però immediatamente il posto alla constatazione che invece nulla è più come prima»: Scuola. Filosofia di un mondo è un libro a più voci, sulla scuola, scritto da insegnanti universitari – Matteo Bonazzi, Federico Leoni, Alessandra Pantano, Gianluca Solla, Silvia Vizzardelli – e esito di un incontro tra mondo della scuola e mondo della filosofia e della psicoanalisi.
Partirei – ascoltando Alessandra Pantano, docente di Didattica della Filosofia all'Università degli Studi di Verona e di filosofia in un liceo, e Matteo Bonazzi, psicoanalista e docente di Filosofia della storia e Fenomenologia della cura all’Università di Verona – dalle esperienze da cui questo libro nasce, e da un elemento che mi pare attraversare i diversi contributi: l’essere attenti a un rischio che corriamo, in questo tanto occuparci e preoccuparci di scuola, ovvero quello di ridurla a un oggetto da studiare, scomporre, risolvere. Mi pare invece che in questo libro la scuola sia un soggetto: con una sua domanda, suoi desideri, suoi fantasmi.
Alessandra Pantano: Iniziamo dal concreto: il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona ha risposto a una domanda nata da docenti di filosofia della scuola secondaria e da alcuni dirigenti scolastici. Due sono state le tipologie di esperienze che abbiamo avviato. La prima è più didattica: la richiesta era di corsi di aggiornamento, tenuti da docenti universitari, su questioni filosofiche. Un’altra richiesta invece è stata di lavorare su un diverso tipo di ascolto dell’insegnante, sono state proposte delle lezioni su alcuni temi e si è avviata una discussione, in piccoli gruppi, tra insegnanti, alla presenza di uno psicoanalista, a partire da quello che è emerso nella lezione. Le parole circolavano, portando anche storie particolari, situazioni vissute in aula, singolari, rispetto a cui si sentiva l’esigenza di un confronto plurale. Quello che abbiamo potuto vedere è che in entrambe le situazioni, anche nei più canonici corsi di formazione legati a contenuti filosofici, emergeva nel dibattito, sempre, il desiderio di parlare della scuola, dei docenti, degli studenti. La domanda dei docenti c’è: a volte più esplicita, altre meno. Aggiungo, rispetto a quello che dicevi sul tanto parlar di scuola, che è stata anche una nostra preoccupazione, un tema di riflessione. Tuttavia non ci ha fermato dal desiderio di provare a lanciare una proposta, una lettura, una visione – in mezzo a tante altre – con l’idea di captare chi si sente un po’ in sintonia con la domanda che poniamo nei diversi interventi del libro. Abbiamo provato a identificare delle parole capaci di far leva sulla domanda interna alla scuola, in questo senso il nostro modo è stato quello di considerarla un soggetto, un interlocutore con propri linguaggi.
Matteo Bonazzi: il titolo vuole dire qualcosa di questo, e anche il modo in cui abbiamo costruito il libro: lo abbiamo davvero scritto insieme, tornando sui testi l’uno dell’altro. Le introduzioni ai diversi interventi sono state scritte non dall’autore dell’intervento, ma da qualcun altro tra noi: un tentativo di scrittura plurale teso a desoggettivare noi e a soggettivare “scuola”, che è volutamente, nel titolo, senza articolo: farne un nome proprio. In quanto soggetto, “Scuola” è portatrice di una filosofia, di un sogno in cui è presa: non è un oggetto da curare, non è un oggetto in crisi da cambiare, ma, piuttosto, come ogni soggetto, ha dei sogni, dei desideri e delle frustrazioni. Questo è un po’ lo spostamento che abbiamo cercato di fare. Scuola senza articolo cosa significa? In questo pensare la scuola come soggetto mi tornavano in mente gli anni in cui ho insegnato al Liceo Majorana di Desio: “Majorana” per gli studenti era un nome proprio, i ragazzi nominano sempre la scuola con un nome che si porta dietro la storia di quella scuola come soggetto.

Anna Stefi: «Davanti alla domanda su come sia possibile accedere a una nuova cultura dell’attenzione non come prestazione, ma come capacità di prendersi cura, il primo riferimento proveniva dalla sentenza benjaminiana che recita “ogni epoca non solo sogna la successiva, ma sognando urge al risveglio”. […] Ci dice che è solo sognando che si trova la strada d’uscita verso una nuova epoca». In questo considerare la scuola come soggetto emerge in diversi contributi il tema del sogno e del futuro. Vi vorrei chiedere qualcosa di questo e al tempo stesso mi pare che questo ci consenta di aprire a una riflessione su tre dimensioni che attraversano la scuola: l’idea di veicolare un sapere, quindi la scuola come trasmissione, i contenuti nel loro rapporto con il passato; l’idea di formare, la scuola delle competenze; e la scuola come educazione affettiva, il grande appello che, con sempre maggiore urgenza, viene dal discorso sociale: due dimensioni, queste ultime, che dicono di uno sguardo al futuro e di una libertà rispetto al passato.
Matteo Bonazzi: possiamo pensare il sognare in due diverse accezioni: da un lato “sognare il futuro” come anticipare, immaginarsi. Questa è una possibilità: pensare cioè che gli adolescenti, oggi, sappiano immaginarsi futuri possibili. Ma nel libro abbiamo insistito su un’altra declinazione, che mi sembra molto radicata e che ci riguarda dal momento che siamo immersi in un tempo storico che ha a che fare con una idea di futuro cupa, angosciante. Sintonizzarci su questo ci è sembrato laicamente molto corretto nel modo di rapportarsi con i ragazzi. Non tanto iniettare motivazioni e speranze, anche perché, a mio avviso, serve a poco: lo sguardo degli studenti è fortemente realistico, ti aspettano davanti a questa questione, al prendere atto della complessità e difficoltà del tempo che viviamo. Cosa significa in questo scenario non abdicare al sogno? Il senso non è il sogno come fantasticheria, ma avere molto chiaro che non c’è futuro se non sognandolo: bisogna prima sognarlo perché poi possa anche avvenire. Questa altra funzione del sogno è molto realistica, non è una fantasia, è un intercettare la potenza interna alla trasformazione a cui è sospesa l’adolescenza. Il sogno, dunque, non è da intendersi come evasione. Si tratta di arrivare a sognare più vero, come diceva Nietzsche. Credo che questo sia un punto attuale che chiede una posizione diversa.
Alessandra Pantano: il sogno è davvero trasversale ai nostri testi, taglia ogni intervento. Probabilmente anche questa è un’esigenza che emerge ascoltando la scuola, ascoltando il linguaggio dell’insegnante che da un lato è messo in forma da una tradizione, da un sapere, ma che, dall’altro, deve essere fatto vivere. Questo chiede un’apertura al sogno. È curioso come la parola “sogno” non sia nelle parole di un’insegnante, anzi, è, in fondo, il risveglio che invochiamo: quando chiediamo di stare attenti, per esempio, o quando ci interroghiamo su come risvegliare l’attenzione e la motivazione. Questo risveglio sembra tenere il sogno fuori dall’aula, tenerlo a bada. Il nostro tentativo è tutt’altro: occorre una parola che non solo istruisca, ma anche sogni. Questo mi pare legarsi all’altro tema che suggerivi, quello della trasmissione dei saperi e dell’educazione affettiva. Mi sono resa conto che la parola educazione e la parola formazione sono parole molto presenti, e il mio invito è a tenerle un po’ più lontane da noi, per vedere che cosa accade. In fondo quando l’insegnante insegna, insegna un sapere: è in rapporto con quel sapere che ha scelto di insegnare; non si pone quindi l’obiettivo di educare e formare. Ho l’impressione che inserire l’insegnamento solo all’interno di una cornice educativa possa spegnere l’insegnamento, lo fa svanire, toglie la sua potenza. Cosa succede se lo liberiamo da quella cornice? Per quanto uno possa dare un senso di educazione che sia il più aperto possibile, l’educazione sembra sempre una briglia, ha a che fare con un “condurre” gli studenti.
Matteo Bonazzi: Userei una parola che ereditiamo dalla filosofia e dalla psicoanalisi: soggettivazione. Si nasce come individui, soggetti si diventa a partire dal lavoro che si fa su di sé, tenendo conto del fatto che, e questo è il paradosso con cui si tratta di fare i conti, il soggetto di cui siamo portatori viene dall’Altro, precede la nostra nascita, ha inizio nei desideri e nelle parole dei genitori. Filosoficamente mi sembra che la questione sia quella di recuperare un presupposto e cioè che il sapere abbia una funzione decisiva per la soggettivazione. Dunque, non è al servizio di formazione e educazione, ma prima di tutto del lavoro con cui diveniamo soggetti. Questo, nell’esperienza di ciascuno di noi, credo sia stato decisivo. Il mio atteggiamento sprezzante nei confronti della scuola, se penso a me adolescente, è cambiato quando sono stato colpito dal sapere, ma non nel senso che qualcosa mi ha illuminato dal punto di vista del contenuto, ma qualcosa si è innestato in me e ha avviato un processo di soggettivazione (nel mio caso è avvenuto con la letteratura). Questo credo che riguardi il sapere in generale e non solo il sapere filosofico, e che valga a condizione di tenerlo “nel suo”, cioè di non intenderlo “al servizio di” (educazione, formazione, etc.). In questo senso, tornando a quanto dicevamo, è importante il sogno, il sogno non è una prerogativa umanistica: anche i numeri si sognano, anche la matematica è una questione di visione. Il punto è, però, che il sapere è soggettivante, questo ritorna negli interventi del libro, se, nella trasmissione, fa esistere un elemento di non sapere: questa non è una competenza che si può sommare alle altre, tocca il rapporto dell’insegnante con il proprio di sapere, che è un rapporto che implica una perdita, ed è questa perdita che deve essere resa desiderabile nel discorso scolastico. Il discorso scolastico chiede di padroneggiare il sapere, offre titoli e abilitazioni, è nella direzione di un accumulo. Scoprire qualcosa di generativo nel non sapere mi pare che sia un punto vitale, e mi pare che sia essenziale togliere questo punto dalla specificità dell’ambito filosofico. Del resto anche l’ambito filosofico – che nelle scuole è sempre più storico filosofico – non offre più alcuna garanzia di fare esperienza di questo. Non si incontra nel sapere, nei contenuti, in Socrate, ma in un modo di trasmissione di quel sapere. Quel modo è incarnato, ecco perché c’è un punto che è difficile rendere sistematico.

Anna Stefi: A un certo punto, nel libro, scrivete di questa scoperta che possono fare gli adolescenti, una scoperta che ha a che fare con l’abbandonare un’idea di accumulo e di padronanza, ed è che quello che ascoltano, che leggono, «li riguarda».
Alessandra Pantano: Il “riguardare” è sicuramente una delle questioni più importanti per un docente, e mi è venuto in mente un aspetto che propongo in modo anche provocatorio: perché quel che dico riguardi gli studenti, deve prima riguardare me. Quando si trasmette un sapere accade qualcosa in cui è coinvolto l’insegnante stesso: innanzitutto l’insegnante. E questo gli studenti lo avvertono. È questo “accadere” che apre alla classe una differenza; chiaramente le risposte sono diverse, non tutti vengono toccati. Se il docente sta più vicino al proprio essere toccato, a quello che riguarda lui stesso, senza direzionare la parola perché riguardi loro, mi pare che ci risparmi dal rischio di invaderli con “parole per loro” che sembrano una forma di violenza. Se vogliamo che valorizzino quel che noi valorizziamo rischiamo delle forzature. L’insegnante lavora con sé stesso, e qui si gioca la trasmissione: accade qualcosa in chi sta ascoltando.
Matteo Bonazzi: questo è un punto di inattualità in cui anche io credo molto. Il discorso attuale chiede di parlare a loro. È inefficace: se parli a loro non vieni ascoltato, anche perché bisognerebbe domandarsi chi sono questi “loro”. Parlare “a loro” significa supporre che sappiamo chi siano. È l’elemento narcisistico della scuola, in cui ne va di sé, in cui si parla dalla posizione di chi sa cosa l’altro desidera. Forse va davvero recuperato, coltivato, il tratto un po’ solitario dell’insegnamento: è qualcosa che ha a che fare con il rapporto di ogni insegnante con la soddisfazione, e credo che sia esattamente questo a essere contagioso nella trasmissione del sapere. I bravi insegnanti sono quelli che fanno uso della propria soddisfazione. Credo che la sfida attuale sia sganciare questo elemento dall’involucro narcisistico: in passato questo aspetto è stato piegato al servizio di un altro padrone, che è il riconoscimento – pensiamo alla generazione dei “maestri” che sono stati il prodotto di un’epoca precedente la nostra. Compito attuale credo sia fare un altro uso di questo elemento di soddisfazione, al di là del narcisismo del riconoscimento.
Anna Stefi: Mi domando se il narcisismo degli insegnanti non si giochi su una postura di padronanza, un “insegno meglio” che si misura sul “risultato”. Mi pare che questo abbia a che fare anche con la difesa dietro il programma. Liberarci, insomma, dall’idea che abbiamo insegnato bene se i nostri studenti conoscono la disciplina: se abbiamo insegnato bene, come è detto in uno dei testi, si vedrà, nel tempo. Tutto questo emerge nel vostro libro con quella necessaria “fedeltà alla curiosità”: “non sono le manovre sofisticate a dare spessore all’insegnamento. È invece l’istante in cui quelle manovre sofisticate vengono lasciate. L’insegnante si fa curioso. Intuisce che quell’incontro non può essere inteso come una perdita di tempo”.
Alessandra Pantano: Questo “accadere” credo sia qualcosa su cui riflettere: è l’insegnante che fa accadere o “qualcosa accade”? Io non so se sia l’insegnante che fa accadere qualcosa, mi pare che qualcosa accada e coinvolga la classe. Il programma è un problema certamente che l’insegnante si pone, spesso è anche qualcosa dietro cui ci si nasconde. Sappiamo che non è un’imposizione che impedisce di fare lezione, ma certo si usa come un riparo. Uscire dal programma ha a che fare con un vuoto, con un’esposizione. Questa forse è una ginnastica cui dobbiamo abituarci, come insegnanti: stare in questo bordo dove ci si espone a un vuoto: in questo senso nel libro abbiamo parlato, nei diversi interventi, di curiosità e di atmosfere. Si tratta di stare dove si trema, mi pare che sia necessario insistere su questo. Ci sono degli effetti che eccedono il contenuto che li ha causati, ed è lì che succede qualcosa. Il contenuto è essenziale: è il contenuto che produce questa eccedenza.
Anna Stefi: A proposito di questo “accadere” in uno degli interventi si parla delle discipline come entità terze, studenti e insegnanti sarebbero testimoni di una estraneità: «con Pitagora ero a mio agio perché il filosofico veniva a prendermi da un altrove, mi trascinava in un luogo estraniante ma dal volto inconfondibile, in un luogo che mi riguardava pur facendo a meno di me».
Matteo Bonazzi: Che cosa ci dice che siamo dei buoni insegnanti? Il sistema scolastico tende ad alimentare la verificabilità dei risultati. Siamo un po’ presi da questa idea: buoni risultati dovrebbero garantire di una buona trasmissione. Credo che sia necessario accettare che, invece, c’è un inverificabile, lo si potrà sapere soltanto a posteriori. Bisognerebbe restare su una logica degli effetti, più che su una logica di padronanza. La “supposizione di sapere” di cui spesso parliamo è quella che dobbiamo fare noi insegnanti rispetto agli studenti: dobbiamo pensarli portatori di un sapere. Se non facciamo questo non li pensiamo come soggetti. C’è un rovesciamento che deve essere attuato: siamo in balia di soggetti che fanno di noi quel che serve loro per poter elaborare un sapere di cui sono portatori, senza saperlo ancora. Quando ci restituiscono qualcosa? Non sulla base dei risultati di apprendimento dimostrati, ma a posteriori, retroattivamente: scopriamo così, grazie a loro, quel che sarà stato trasmesso. Questo ci dirà se avremo fatto un “buon” lavoro, se la lezione avrà reso possibile un processo di soggettivazione. Credo che lo sforzo sia provare a portare tutto questo fuori dal linguaggio della filosofia. Che il sapere sia la linfa della soggettivazione riguarda l’insegnante di filosofia, come quello di matematica, di scienze o di informatica. Dal punto di vista dell’esperienza reale credo che questo sia un elemento tangibile, riconoscibile: ognuno di noi, come insegnante, sa qualcosa di questo. Il punto è portarlo a parola, dentro e fuori la scuola, per contrastare il portato superegoico e difensivo dei programmi. Certo, ci sono elementi oggettivi: bisogna offrire agli studenti gli strumenti per poter affrontare la prova di matematica all’esame di Stato. Ma i programmi, a ben vedere, esistono sempre meno, sono evocati come una difesa, mentre andrebbero presi come un’occasione per favorire il potere di soggettivazione del sapere che, come dicevo, necessita di una certa esposizione al non sapere. E questo un po’ angoscia.
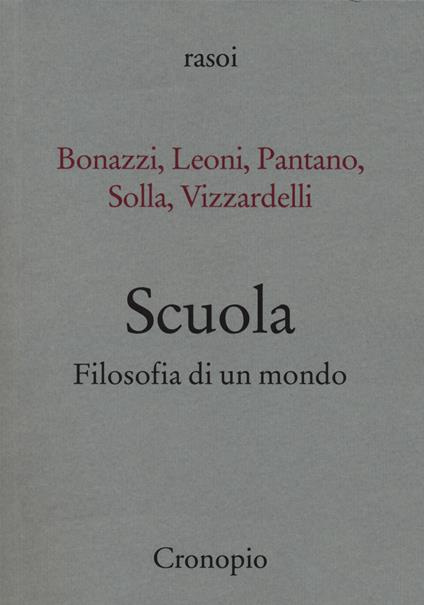
Anna Stefi: A questo proposito scrivete: «una scuola che si chiede e che insegna a chiedersi dove abiti la verità, su quale terreno possiamo scommettere di rintracciarla, quali pratiche promettano di realizzarne una briciola». Mi pare che questo sia reso complicato anche dal rapporto tra docente e “mondo”: c’è un discorso sociale – la riuscita delle cose si misura in termini di efficacia –; una scuola – con il suo discorso; e poi il docente, a fare i conti con questa complessità. Senso del dovere, narcisismo, desiderio: perché insegnare? Si usa la parola vocazione, che trovo terribile, si parla di valutazione dei docenti. Noi tutti come docenti constatiamo che in alcune classi qualcosa accade e in altre no. Come riflettere su questo?
Alessandra Pantano: Ci siamo posti il tema del “mondo” nello scrivere il libro. Ritorna anche nel titolo. Mondo come quel che è esterno ma al tempo stesso interno alla scuola. Mi pare di rilevare una tendenza alla diffidenza che attraversa i docenti e il discorso culturale in generale, una diffidenza verso il mondo così come va. E, simmetricamente, il mondo diffida della scuola: le famiglie e le imprese accusano la scuola di non essere adeguata ai tempi. È una doppia diffidenza. Anche su questo credo che sia importante insistere: far entrare il mondo e portare le parole delle lezioni fuori dal mondo, essere, come insegnanti, una finestra più che un muro separatorio.
Matteo Bonazzi: di nuovo mi pare che sia centrale il modo in cui noi abitiamo il sapere. Veniamo da una tradizione gentiliana che ha un po’ cancellato il “fuori”: il mondo deve essere pensato, concettualizzato, va portato “dentro”. Il mondo fuori come qualcosa che forse non vale nemmeno la pena di pensare. Si parla, in anni più recenti, di portare la realtà nella scuola. La realtà è ridotta a quel che accade, a un discorso sulla realtà: si leggono i giornali, per esempio. Rispetto alla realtà il sapere è sempre indietro, arranca. Mi pare che negli adolescenti ci sia l’esigenza di mettere alla prova il sapere, di verificare che stringa qualcosa del reale, che riesca ad agguantare qualcosa della vita. Non rappresentare ma toccare il reale. Per questo bisogna fare i conti con l’angoscia di cui dicevamo prima, l’angoscia del tremare e di essere esposti alla non padronanza. Lì, per l’insegnante, c’è certo una fatica, ma c’è anche il suo essere toccato, la sua vibrazione. Il soggetto insegnante è soprattutto un ex-studente e quando insegna si sente interrogato, risponde al proprio Super-io. Questo ci rende ciechi a quel che accade in classe, come se continuassimo a parlare al maestro. Se l’insegnante si sgancia dal fantasma dello studente che è stato, può scoprire che insegnando si angoscia e insieme si vivifica. Ed è lì che uno studente può iniziare a supporre che ci sia un sapere per cui ne vale la pena. Si tratta di rischiare nella trasmissione, forse dire questo è un modo per non mettersi dalla parte di chi ha soluzioni, di chi dice cosa bisognerebbe fare. Se ipotizziamo che nella pratica dell’insegnamento qualcosa di questo lo abbiamo incontrato, scrivere un libro di questo genere è provare a testimoniarlo. Per come la vedo io da un lato c’è una perdita, e questo, socraticamente, dovrebbe privilegiare i colleghi filosofi, animati da una certa posizione di svuotamento e di non sapere. Si parla molto del: portare gli studenti a fare esercizio delle domande. L’impressione è che ci sia da aggiungere un pezzo: non è solo perdita, c’è anche l’elemento che abbiamo chiamato soddisfazione non narcisistica, godimento, quel “riguardare” prima di tutto noi come insegnanti. Ed è questo che fa contagio. Gli studenti sono soggetti e dunque sono portatori di un sapere, e di un elemento di soddisfazione e godimento, che si tratta di mettere in risonanza. Questo passaggio deve forse essere ancora costruito per capire meglio le condizioni di possibilità di tutto ciò: è pensabile dentro un’istituzione come la scuola, che funziona con certi discorsi, l’introduzione di un elemento che non è soltanto il lusso socratico del non sapere ma qualcosa che possa includere la nostra enunciazione, il luogo da cui prendiamo la parola, e la soddisfazione che questo può comportare?
Anna Stefi: Vi chiedo ancora qualcosa rispetto al tema della relazione e alla richiesta, del discorso sociale, di una educazione: affettiva, sessuale, etc. Una domanda che viene fatta alla scuola e che mi pare che allontani da un’idea che attraversa il vostro libro, di un legame senza rapporto, di una relazione non speculare.
Matteo Bonazzi: Mi vengono in mente due cose. La domanda che viene fatta alla scuola di educazione sessuale non è solo della scuola, è anche degli studenti. Non credo che sia utile avere una posizione critica: ognuno viene con la propria domanda, come in una analisi personale. Non si tratta di chiederci se la domanda è giusta o sbagliata: il soggetto collettivo porta la propria questione. Quando con i ragazzi del liceo, su loro richiesta, avevamo tenuto delle lezioni di educazione sessuale, mi aveva colpito che una delle questioni per loro era come differenziare l’approccio sessuale dall’abuso, come se ci fosse un elemento discreto che consente di fare questa distinzione. Mi pare che questo dia l’idea che siamo in un momento storico in cui la soggettivazione è ridotta a un cognitivismo radicale: si chiedono delle risposte definitorie, come sul piano del diritto. Se consideriamo questo, e riflettiamo su quello che ci dice Lacan – in fondo nessun uomo sa che cosa fare con una donna – possiamo provare a leggere nella domanda dei ragazzi una questione che ha una sua verità, e possiamo non giudicarla come ci verrebbe da fare di primo acchito. Ci stanno dicendo, in fondo, che c’è in gioco qualcosa di intrattabile e forse quello che possiamo fare è esserci davanti a questo: anche perché l’alternativa è che qualcuno dia loro una risposta, come se si potesse delineare questa differenza oggettivamente. La questione dunque non è se è giusto o sbagliato chiedere alla scuola di fare educazione sessuale: accade questo, è così. E dunque si può fare educazione affettiva. Come? Non aggiungendo il contenuto “sessuale” come un contenuto tra gli altri, ma ricordandoci che è il sapere ad essere sessuato, erotizzante, ed è questo che dà al sapere un potere di soggettivazione. Se ci chiedono il corso di educazione sessuale questo ci rivela che abbiamo mortificato il sapere, che abbiamo ridotto la scuola a delle nozioni e che la vera vita è altrove. Si può fare di qualsiasi sapere un buon uso, si tratta di mostrare che ci riguarda, che ne va di noi. Ma per far questo, bisogna esserci. La richiesta di educazione sessuale, in fondo, dà l’idea della domanda che tormenta gli adolescenti: come si sta al mondo? È diventata una questione enigmatica, per loro ma anche per gli adulti.
Alessandra Pantano: Aggiungerei un’ultima cosa. Per chiudere da dove siamo partiti: i corsi che abbiamo organizzato sono diventati dei momenti preziosi per i docenti che vi hanno partecipato, era come se quel luogo fosse diventato uno spazio che, nella vita ordinaria della professione, non è previsto. E mi pare significativo sottolineare, a proposito di questo rapporto con la vita e con l’eros, che gli incontri funzionavano di più quando accadevano fuori dallo spazio fisico della scuola. Questo ci dice che bisogna uscire da scuola ed entrarci da fuori, stare in un interno/esterno, costruire dei luoghi supplementari che rendano viva l’istituzione: non si tratta semplicemente di parlare di attualità, si tratta di tenere vivo il dispositivo non irrigidendolo nelle mura, in un già pensato. E per far questo bisogna che l’insegnante trovi il proprio modo di stare sulla soglia.
Alessandra Pantano e Anna Stefi - insieme a Andrea Giardina e Marco Martinelli del Teatro delle Albe - saranno presenti al tavolo Scuola e non scuola organizzato da doppiozero in occasione dell'ottava edizione di Kum!, il festival diretto da Massimo Recalcati e coordinato da Federico Leoni, che si svolgerà a Pesaro dal 6 all'8 aprile e sarà dedicato a La vita della scuola. Qui le informazioni e il programma.
Le illustrazioni sono di ©Giselle Dekel.









