Una conversazione / Ateliersi. Le mappe del cuore di Lea Melandri
Esserci in qualche modo, come si può, in piccolo; costruire un’architettura possibile per quel festival di teatro che, giunto alla sua ventiquattresima edizione, ci porta all’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Il retro del Teatro La Cucina è la scena: un grande prato verde, tigli tutto attorno, il palcoscenico, le sedie a distanza di sicurezza. Scommessa vinta, quella di Olinda: Da vicino nessuno è normale ci ha permesso di tornare davanti a corpi sul palco, ha consentito che ritrovassimo, con le mascherine, in piccolo, il ‘fare mondo’ che è il teatro.
Due tavoli in scena: uno alla destra e uno alla sinistra. Una poltrona bianca tra loro. In primo piano due leggii che paiono maschere, dietro cui il volto di chi si avvicina scompare. Un microfono al centro del palco e al centro di un quadrilatero di fonti luminose, steli verticali di alluminio attraversati da luci a led. Su uno dei tavoli plichi altissimi di lettere; l’altro coperto da riviste, ritagli. Davanti ai tavoli, Fiorenza Menni occupa la parte destra del palco, Andrea Mochi Sismondi quella sinistra: consultano i fogli, li rigirano tra le mani. Fiorenza si avvicina ad Andrea e poi fa ritorno; non si dicono niente, è un dialogo tra i loro spazi.
Francesca Pizzo indossa una giacca bianca e pantaloni corti bianchi; le gambe magre finiscono in scarpe grigio chiaro, appuntite. Il suo corpo attraversa la platea, la taglia. Poi è la sua voce dietro al microfono: segue il ritmo della musica con movimenti impercettibili. Una colonna sonora di metà anni Ottanta, i Duran Duran, e il suo sguardo che non si ferma su nulla: un contrasto tra presenza e assenza, tra togliere e mettere, tra qui e altrove. Sottile, sembra non esserci; la musica è dappertutto. Un dialogo tra generazioni e generi; tra lo spazio di una cameretta e il prato; i Duran Duran e i nuovi arrangiamenti musicali di Vincenzo Scorza e Mauro Sommavilla. Francesca prende per mano Fiorenza e Andrea: è lei tra loro, passaggio e insieme marcatore di distanza. Poi si sottrae al primo piano e occupa la poltrona: canta raccolta, ma le sue parole, sfondo al dialogo tra Fiorenza e Andrea, raggiungono la scena. Le parole, come se qualcuno alzasse il volume, diventano tutte le voci: quella di un’adolescente che leggeva “Ragazza In”; quella di un ragazzino la cui madre leggeva “Ragazza In”; quella di tutte le lettere, di quelle buste, di quegli indirizzi e nick name: Lacrima nera, Leonessa ’66, Patty, Sognatrice, Una drogata.

La mappa del cuore, Ateliersi, ph Bruna Orlandi.
Si apre così La mappa del cuore di Lea Melandri, l’ultimo lavoro di Ateliersi: un dialogo tra parole in cui la potenza dei corpi modifica il campo di forze.
Lea Melandri ha tenuto per tre anni una rubrica di corrispondenza, Inquietudini, su “Ragazza In”, un settimanale per adolescenti degli anni Ottanta, una rivista capace di mescolare cultura alta e cultura popolare. Lea non rispondeva direttamente alle domande delle lettere, non offriva soluzioni. Le attraversava, le apriva, creava ponti.
Ho incontrato Lea Melandri, Fiorenza Menni, Andrea Mochi Sismondi a Milano, qualche giorno dopo lo spettacolo. Mi sono molto interrogata su cosa farne di queste ore di conversazione: raccontare, riportare brevi stralci. Qualcosa mi ha fatto pensare che potevamo prenderci uno spazio che è il tempo di un dialogo, di un incontro, di un pensare insieme. Mi sembrava, tagliando, di fare un torto a chi legge, tenendo per me il regalo di quelle parole e, insieme, di fare un torto a quello che, ascoltarli, mi aveva restituito.
Fiorenza, Andrea, come nasce questo lavoro?
Fiorenza Menni: I nostri spettacoli nascono dal desiderio di mettere insieme elementi distanti e vedere come possano dialogare. Con Andrea da tempo, ragionavamo sull’idea di ripercorrere il femminismo in Italia: abbiamo sempre avuto come riferimento Lea Melandri, io l’avevo conosciuta molti anni fa, grazie a Ermanna Montanari, e da questo incontro ho seguito il suo pensiero. Il desiderio era di lavorare con questi temi e l’infanzia, cosa che non abbiamo mai fatto prima. Inizialmente il nodo era mettere in relazione persone di generazioni distanti, la storia del femminismo e i ragazzini di oggi. È cercando di capire come avremmo potuto avvicinarci a questa intuizione che abbiamo scoperto l’esperienza di Lea su “Ragazza In”. Il progetto iniziale si è fermato. Esisteva una pubblicazione che raccoglieva alcune di queste lettere, ci siamo concentrati su questo, iniziando a lavorare sul pensiero di Lea. Abbiamo approfondito le scritture, ascoltato le sue interviste: avevamo nelle orecchie il suo modo di parlare, la vivacità. Ed è stata proprio la sua voce che ho riconosciuto per caso una mattina in Via San Vitale, a Bologna. L’ho chiamata e lei era effettivamente lì. Questo incontro ha accelerato le tappe: abbiamo ospitato a Atelier Sì un suo laboratorio e le abbiamo chiesto se sarebbe stato per lei interessante questo progetto. Ci ha aperto, insieme al racconto, le botole di casa sua: tutte le lettere.
Andrea Mochi Sismondi: Un tesoro, abbiamo tirato giù dal soppalco questo sacco contenente tutta la corrispondenza e, rovesciandola al centro della stanza, abbiamo cominciato a guardarla insieme.
Quindi tu, Lea, le hai conservate tutte, non solo le parole, il contenuto, ma anche la materia, le buste, la carta.
Lea Melandri: Un patrimonio: non potevo non tenerle. Non c’era una busta bianca, normale, erano tutte istoriate, con le loro scritte e molte con le mie note e le mie sottolineature. Un materiale che aspettava Fiorenza e Andrea.
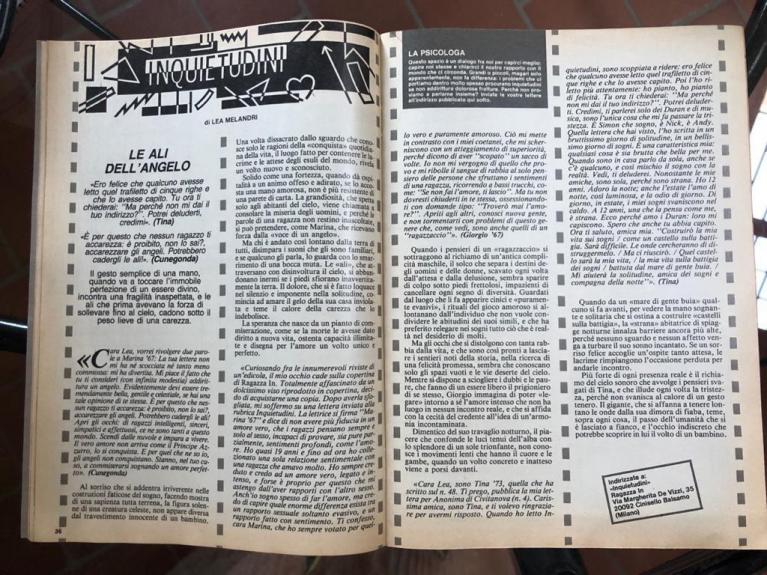
Inquietudini.
Come lavoravi a queste lettere?
LM: Quelle lettere furono un incontro in un momento particolare della mia vita. Il messaggio, spesso, era già sulla busta: “help me”, “Pubblicami”, “Corri postino, non ti fermare, che la mia Lea non può aspettare”. Entravo dentro a queste lettere quasi sino a perdermi. Nella vita il “sogno d’amore” come fusione produce danni, ma non in questo modo della scrittura e riscrittura, il modo in cui ho accostato in quegli anni alcune parole – quelle di Sibilla Aleramo o di Michelstaeder, entrate nel mio libro Come nasce il sogno d’amore. È stato un corpo a corpo, una fusionalità iniziale con quel materiale che mi toccava profondamente e poi un graduale staccarsi, quel tanto necessario per vedere dove sei tu e dove è l’altro. È come se avessi portato il sogno d’amore, che era nel mio vissuto personale in modo doloroso, nel leggere e riscrivere le parole dell’altro. Questo ha prodotto comprensione profonda e reciproca. Ricevevo tantissime lettere – una media di ottanta a settimana – nonostante la mia scrittura che io stessa consideravo enigmatica. Avevo su di me una coperta di lettere: trascorrevo così i sabati e le domeniche. Leggevo, trascrivevo frammenti, le raggruppavo per tema: facevo quello che facevo con i libri, non ho fatto distinzioni. Credo sia stata questa la mia scoperta di quegli anni: avvicinare il senso comune e la cultura alta. Il sogno d’amore, attribuito alle donne come sentimentalismo, attraversava entrambi, è la struttura portante di tutta la storia, di tutta la civiltà: i dualismi, le contrapposizioni, che tendono a ricomporsi in armonia. Venivo da dieci anni di femminismo, avevo l’attitudine all’ascolto delle vite, ma la tematica dell’amore nel femminismo non c’era stata ed era mancata l’attenzione a quell’età particolare che è l’adolescenza, età di passaggio dalla famiglia alla società, in cui sei anche un corpo che deve prendere forma in modelli imposti per secoli. Un’età delicata, dominata da senso di inadeguatezza e solitudine: chi dà ascolto a quel momento della vita? Forse, se ho avuto un’empatia tanto profonda, nonostante avessi più di trent’anni, è perché conservavo qualcosa della mia adolescenza, eredità dei miei anni faticosi nella casa contadina. Ho continuato a ritornare alle macerie della mia adolescenza, resto la figlia di quei genitori poveri che mi hanno dato il privilegio dello studio, un’adolescente a vita che non ha mai smesso di guardare film d’amore. E mi permetto di pensare che se Fiorenza e Andrea sono stati lettori così in sintonia è perché qualcosa della adolescenza lo portano addosso: basta guardarli.

La mappa del cuore, Ateliersi, ph Margherita Caprilli.
Fiorenza, Andrea, torniamo alla costruzione del vostro spettacolo. Nella drammaturgia un aspetto ho trovato molto potente: Fiorenza, sulla scena, è una donna che leggeva “Ragazza In” e racconta cosa erano per lei quelle lettere. E tu, Andrea, sei un uomo la cui madre leggeva “Ragazza In”. Dialogo tra generazioni ma anche tra generi.
FM: Ci interroghiamo sempre su come portare negli spettacoli che costruiamo quello che noi siamo, quello che viviamo. Questo non significa portare il discorso autobiografico: non c’è nulla di vero in quello che mettiamo in scena. Si tratta di raccontare la nostra vita che è vita di pensiero a due, e questo pensiero a due è un filo teso, filo che vogliamo raccontare perché ci sembra che sia la via più interessante per raggiungere il pubblico, per coinvolgerlo.
AMS: La prima questione iniziando a immergerci in questo materiale è stata la questione della legittimazione. È proprio questa trasposizione dal naturale al riconoscimento del culturale: queste ragazze e questi ragazzi ricevevano da quella rubrica, dalle risposte di Lea, l’impressione di non essere sbagliati, storti; di essere magari “fuori posto”, ma il posto poteva essere messo in discussione dal punto di vista culturale. Spesso sono ragazzi di piccoli paesi, ricevono dal loro contesto definizioni stringenti: ci è sembrato che un tema fondamentale fosse la richiesta di mettere in discussione i meccanismi culturali che creavano quell’immagine in cui si sentivano costretti. Smontare le origini di quelle costruzioni dolorose: il fuori posto è tipico dell’adolescente, ma le risposte di Lea lavorano proprio rendendo porose alcune definizioni. Nel lavoro drammaturgico questo tema ha guidato la scelta delle lettere, dei riferimenti che vengono fatti a “Ragazza In”: la questione musicale, la rielaborazione del pop, quel “tra altari votivi e cartoni animati”, la relazione con un sognato esterno, i Duran Duran. Le due figure in scena sono due storie di formazione, formazione alla libertà di pensiero. Questo è anche quello che è emerso dai laboratori fatti con i ragazzi a Bologna, ci siamo chiesti che cosa sia oggi la libertà di pensiero, come ci si riconosce un pensiero autonomo, e dunque ci è sembrato fondamentale evocare storie di formazione. Le figure mescolano elementi autobiografici e generazionali: fa parte della mia storia un rapporto con il femminile che nasce da quelle esperienze, poco importa che sia mia madre o meno. Alcune aperture in quel momento storico vengono da una cultura internazionale che passa attraverso “Ragazza In”, questa rivista che ha mescolato i livelli e aperto finestre fondamentali per una generazione.
FM: Mi sono formata in un piccolo paesino dell’appennino romagnolo, sicuramente la mia famiglia mi ha dato, come apertura, la possibilità di studiare. Non è poco, ma non è sufficiente. È stato per me interessante ricostruire le influenze che mi hanno reso possibile, in quegli anni, il non restare bloccata in una realtà come quella in cui sono cresciuta. Sicuramente negli anni Ottanta qualcosa è stato possibile perché c’erano stati i movimenti degli anni Settanta: non erano arrivati con i loro contenuti precisi, ma avevano sconquassato qualcosa, le famiglie, probabilmente gli insegnanti. Qualcosa di quel movimento ha reso possibile delle trasformazioni e per me, che all’epoca ero una bambina, è stato interessante ricostruire queste possibilità, possibilità che sono state di una generazione che poi ha potuto, negli anni Novanta, passare a una modalità di espressione, a un linguaggio, differente.
AMS: Nel nostro dialogo si è ovviamente anche posta la questione del maschio, si trattava di capire come attraversare queste lettere e come ritrovare l’origine di un pensiero, che è quello delle risposte, nel quale non c’è esclusività di genere. Porre la figura maschile all’interno di questo lavoro ha richiesto una riflessione su quelle che sono state le pratiche femministe storiche e sulle questioni che sono di oggi. Attraversare i materiali e conoscere Lea per me è stato un momento di grande formazione: scandagliare le possibilità di relazione al di là degli elementi di piaggeria o contrapposizione. Credo che questo sia stato possibile nel dialogo tra figure, che dunque ci è venuto naturale riportare in scena, anche perché è la nostra storia.
FM: Io e Andrea abbiamo undici anni di differenza: in quegli anni io ero ragazzina e lui bambino, abbiamo dovuto attraversare la differenza di genere e la differenza di generazioni.

La mappa del cuore, Ateliersi, ph Margherita Caprilli.
LM: Volevo tornare sul tema della legittimazione di cui ha detto Andrea: erano gli anni in cui venivano meno i confini tra privato e pubblico, si modificavano profondamente. Il femminismo parla di personale-politico: scoprivamo che nella vita personale c’è un patrimonio di cultura che riguarda non solo il rapporto tra i sessi, ma esperienze universali dell’umano. Il femminismo è stato il fenomeno che ha raccolto questo cambiamento profondo in modo più esplicito.
Le lettere arrivano in confidenza da quel luogo, la stanza, in cui l’adolescente si sta formando rispetto a un contesto familiare con cui ha difficoltà di relazione. Portavano segreti: né in casa né a scuola parlavano di quello che scrivevano. Non vi era una legittimazione culturale, o politica, però venivano inviate a una scena pubblica. Questo mi colpiva: anche nella mia vita c’era stata un’enorme materia dolorosa rimasta “fuori tema”. Il “fuori tema” era la mia condizione sociale, la famiglia in cui sono cresciuta, la mia condizione sessuale di figlia femmina. Le vicende che hanno segnato più dolorosamente la mia vita, quando tentai di portarle nella scrittura scolastica, furono considerate “fuori tema” – questo il giudizio al mio primo scritto di quarta ginnasio. Quel “fuori tema” è rimasto come una ferita nella carne: le vicende che hanno segnato la mia vita non erano traducibili nei linguaggi colti. Questo credo sia stato uno degli elementi che mi ha messo in una sintonia immediata con le parole che ricevevo. Nemmeno il femminismo aveva dato legittimità a quel vissuto particolare che è l’amore; aveva parlato di sessualità, ma questo desiderio di veder ricomposti sensualità, intelligenza, sentimenti, non aveva trovato posto. Nelle lettere la descrizione del viso e della voce dei Duran Duran erano questo, la descrizione del sogno d’amore: sensualità e dolcezza, solitudine e inadeguatezza, desiderio di essere amati. Certo, dal femminismo mi arrivava una pratica, quella dell’autocoscienza, che aveva aperto le porte ai vissuti personali e alle storie, anche indicibili, del sé.
Di questo “fuori tema”, che è stata la tua ferita, tu ne hai fatto il tuo tema.
LM: Non c’è mio libro che non parli di questo, dell’uscita dai dualismo, del rapporto sentimento-ragione, dell’uscita dalla contrapposizione tra senso comune e cultura alta. L’uscita da queste dicotomie è stato il mio tema centrale e ne ho preso consapevolezza nell’incontro con il movimento non autoritario, con “L’erba voglio”, con il femminismo, con Fachinelli: lì il “fuori tema” era il tema. La vita andava in primo piano, e vita era per me questo retaggio arcaico che ci portiamo dietro, l’esperienza fusionale con il corpo materno, l’enigma delle origini, la differenziazione che ha polarizzato la donna come natura e animalità e l’uomo come cultura e pensiero. Anche gli uomini – lo diceva bene Andrea – portano il segno alienante di una differenziazione che li ha impoveriti di una parte di sé. È bellissimo che il filo narrativo dello spettacolo sia un dialogo tra un uomo e una donna. La foto di copertina di “Ragazza In” era sempre un uomo.
Però ricevevi lettere anche dai ragazzi.
LM: Sì, qualche uomo ha scritto. E quando arriva la lettera dell’“orfanello di Brescia” – così si presentava – si sono scatenate le risposte. Le lettere successive erano tutte per dargli conforto: seppellito dalle risposte! Questo per dire che erano gli anni Ottanta, c’era stato il femminismo, e tuttavia le risposte mostravano un’esplosione di cura. Sono curiosa di vedere oggi, quando porteremo queste lettere agli adolescenti, cosa sia cambiato. Io penso che su queste tematiche di fondo, che pescano alle origini della vita, non sia cambiato molto. È una zona ancora impresentabile. Io credo che solo portare questi vissuti in una pratica collettiva possa produrre una trasformazione e la mia rubrica è stata una pratica collettiva. Mettevo le loro voci in relazione tra loro: “cara Lea, bella la tua rubrica, posso rispondere a Alessandra di Torino?”.
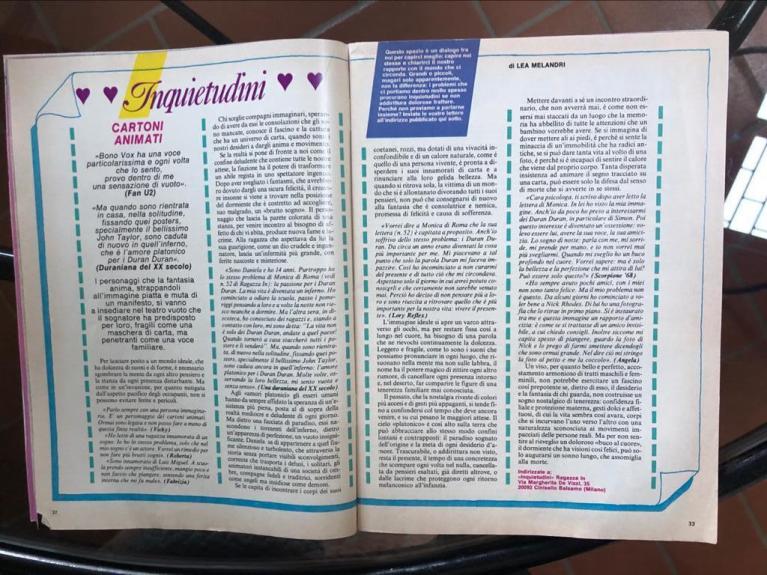
Inquietudini.
Ponti: tra maschile e femminile e cultura alta e lettere. C’è un passaggio di Sibilla Aleramo – che ho incontrato leggendo i tuoi libri – che mi pare lo dica molto bene, quando scrive che gli uomini non sanno quanto a lei arrivi penosa la dichiarazione che le fanno di avere l’impressione di discorrere con lei “da pari a pari”, quanto abbia dovuto adattare a loro la sua intelligenza: “questo cozzo tra il mio ritmo interno e il ritmo delle forme da voi trovate”. Tu hai dato dignità – e Fiorenza e Andrea hanno rilanciato questa accoglienza – al sentimentale, al patetico. Qui, forse, c’è la grande scommessa delle generazioni future, e, forse, della scuola. L’altro tema mi pare questo attraversamento generazionale: nella mia adolescenza è mancata “Ragazza In”, la legittimazione culturale poteva venirmi solo abbandonando questi discorsi, lasciandoli fuori scena, appunto. Mi chiedo se non sia questa l’eredita del femminismo.
LM: Adesso, quando si parla di ruoli, identità, valori attribuiti nella costruzione culturale a maschio e femmina, si parla di questioni di genere. A partire da quei corpi, ma su quei corpi, è caduta una storia: sessismo, ideologia patriarcale. Oggi questo tema è allo scoperto. Portare il corpo a scuola – le sue passioni, i suoi vissuti, i suoi sogni – io credo voglia dire toccare una zona considerata ancora impresentabile perché retoricamente innalzata e storicamente svilita: la fame d’amore, gli Harmony. Il sogno d’amore è stato collocato nel femminile e questo ha dato spinta al bisogno maschile di differenziarsi da questo: la cura, la sensibilità, è pregiudizialmente ancora qualcosa di difficile da assumere per un uomo. Io, femminista, a quarant’anni, sono andata a una festa di carnevale vestita da D’Artagnan! Credo che sia importante interrogare ancora queste maschere così radicate, bisogna capire che anche per il maschio c’è stato il peso di un copione che ha creato grandi difficoltà. Credo che queste lettere sappiano dire, più di molti saggi, il senso di inadeguatezza rispetto a modelli normativi, dati come naturali, che sono la costruzione più perversa che ci ha dato la storia. Portare questo spettacolo nella scuola, con questa teatralizzazione, credo abbia un peso enorme: attraverso le voci di Fiorenza e Andrea le lettere assumono una valenza emotiva e di scoperta. Io stessa ho riscoperto la mia scrittura nelle loro voci.
AMS: Io credo, riprendendo la questione del culturale maschile e del naturale femminile, che siamo arrivati a un momento in cui le crepe siano evidenti, i modelli di riferimento non tengono più. Forse c’è una possibilità di legittimare una divergenza rispetto ai modelli di cui stiamo parlando; portare il maschile sulla scena è stato anche un po’ questo: recuperare una dimensione affettiva, sentimentale, relazionale, nel maschile e poter finalmente riconoscere legittimità culturale a tutto questo. Certo, molto dipende dai contesti e dagli ambienti, ma lo dico anche forte di questi tre mesi di lavoro con adolescenti di un istituto tecnico multietnico di Bologna: alcuni tabù stanno crollando. Credo che la grande difficoltà per loro sia il grande terrore dell’irrilevanza: dal privato arrivo al pubblico, ma poi questa cosa, anche per il fatto che non scandalizza più, interessa qualcuno?
Lea in Alfabeto d’origine affronta questo tema privato/pubblico con riferimento ai social network, che hanno modificato la scena pubblica: la scrittura non è infatti quello spazio segreto della stanza che si espone alla scena, è un privato diverso, nasce pubblico. Questo espone al rischio che la libertà maggiore acquisita si configuri, vista l’invasività di tali modelli, come libertà di somigliare. Leggo però anche io quello che tu dici Andrea, la fatica a identificarsi con dei modelli, qualcosa non tiene più, ma credo che ancora la legittimazione culturale di tutto questo sia assente. L’immaginario adolescenziale, come quello femminile, mi sembra che debba ancora fare a meno di qualcosa, che è il suo proprio, per legittimarsi a un discorso culturale alto.
LM: Mi è venuta in mente Sibilla Aleramo: il romanzo autobiografico, Una donna, è un femminile che si racconta in tutti i suoi aspetti impresentabili, ma per arrivare comunque a creare una immagine alta di sé: “sono l’umanità in cammino”. Nei suoi diari invece la Aleramo non racconta, si scrive. I suoi diari venivano considerati “chiacchiere sulla carta”. E lei, sessantenne, scrive: “c’è in me una sotterranea, segreta, seconda vita, che non posso consegnare nemmeno alla poesia se non disumanandomi, violentandomi, forse uccidendomi”. Rispetto a cosa anche la poesia diventa violenta? Rispetto a questa “sotterranea segreta seconda vita” svilita, considerata materia da rotocalco. La grande coscienza anticipatrice di Sibilla Aleramo sta nell’aver portato nella mischia questo indicibile, da cui fuggono uomini e donne. C’è, insomma, una riserva di vita privata, di storia personale, che chiede voce e può trovarla con l’ascolto di altri, in pratiche collettive.
AMS: La scelta dei Duran Duran, nella costruzione della drammaturgia, è stata per noi il modo di inserire, nella composizione dello spettacolo, la legittimazione di quel livello; è esemplificativa di questo passaggio.
FM: Io credo che forse il teatro resta ancora il luogo dove maggiormente ci si possa permette di distruggere tantissimi schemi. Quello che resta dal grandissimo setaccio che è il pensiero sulla necessità drammaturgica, è il fatto che non ci sono confini tra le arti, quando pensi drammaturgicamente, e non ci sono confini tra i generi. Gli elementi sgocciolano sulla scena per la necessita di arrivare, con una forma narrativa che può anche essere discontinua, ma che mira a mantenere viva e accesa la relazione tra il tuo operare e i corpi e i cervelli presenti in sala. Per me la questione sul maschile e femminile è molto cambiata e credo che la ragione sia questa; non la sento così forte. La necessità del risultato sulla scena mi porta a essenzializzare anche il rapporto dialogico tra queste due figure al minimo necessario. Se fosse di più, se si polarizza tra un maschile e femminile, è esclusivamente per la necessità di generare il passaggio del livello fondamentale, che è l’emozione di questi scrittori. Noi vibriamo, i leggii sono nascosti dietro una maschera, che da un lato ha una sua necessità tecnica, ma dall’altro è un modo per nasconderci, lasciare che arrivi solo quello che emerge dalle parole. Se le lettere risultano incarnate è perché ci siamo messi nella condizione di essere liberi. Come non fare di Leone ’70 un ragazzo che entra sulla scena, ma farlo parlare attraverso soltanto la sua lettera? Nel teatro se misuri elementi e piani questo può avvenire. L’altra scommessa per noi importantissima – e sorrido nel sentire Lea che dice di sentire di più il suo stesso scrivere – era proprio quella di preparare il terreno, drammaturgicamente, perché le risposte di Lea potessero arrivare chiare, perché, per chi ci ascolta, fosse chiaro che quei pensieri, quelle risposte, aprono un mondo altro. Il teatro dosando i suoi elementi, mettendoli in discussione, permettendosi di non esser ligio a nulla, può fare questo.
E avendo i corpi, i grandi assenti da tanta parte del discorso culturale. E da qui mi pare che non posso non domandarvi della presenza in scena di Francesca.

La mappa del cuore, Ateliersi, ph Luca Del Pia.
FM: Noi pensiamo sempre i nostri spettacoli come concerti da cui la drammaturgia emerga. Il luogo musicale è luogo di grande divertimento, vocazione, ed è un’estetica sicura; se riusciamo a capire quale sia il luogo musicale necessario ci sentiamo dentro la migliore scenografia. Lavorare in sala prove con la composizione musicale allenta poi tanti rischi, la distribuzione ritmica ci sembra che tenga a bada vizi teatrali. Noi siamo distanti dai Duran Duran: lo ero io all’epoca, ragazzina punk; lo era Andrea, troppo piccolo. Per un anno abbiamo studiato i loro ritornelli, le loro introduzioni. Francesca aveva già lavorato con noi, e ci sembrava adatta anche perché quando i Duran Duran non erano famosi e cercavano un cantante, era stato loro indicato questo ragazzo molto alto vestito di rosa “bello come Elvis Presley”. “Se canta altrettanto bene – fu il loro commento – è la persona che cerchiamo”. Simon fu questo e Francesca interpreta questo: è una donna che gioca con la sua immagine, non concede ovvietà, permette di avere questa morbidezza vocale – che è di Simon, di Elvis – senza doversi mostrare in un dinamismo o in una arroganza estetica. Metterla in fondo alla scena ma nella luce, celebrata, è stato creare una sovrapposizione tra i ragazzini e i loro miti. Abbiamo poi giocato sulla apparenza fragile di Francesca, che è il suo modo di osservare il mondo: non si pone con sicurezza, ma non appena canta arriva la sua forza. E questo suo essere tra noi, questo farsi medium, ci sembrava il luogo dove dare forma alla nostra volontà di non essere determinati su alcune sentenze: lei ci prende per mano e siamo noi, io e Andrea, che ci prendiamo per mano; il dialogo è tra noi, ma avere in mezzo questa sua presenza di forza e fragilità ci sembrava teatralmente interessante.

La mappa del cuore, Ateliersi, ph Margherita Caprilli.
Ai miei occhi di spettatrice lei, giocando su confini che si confondono, femminilità potente in un corpo androgino, mi è sembrato che tenesse qualcosa del “sono diversa” che attraversa le lettere: ti chiedo di pubblicarmi, riconoscermi, dico la mia differenza ma in fondo godo del cosmo comune che si crea.
LM: Penso che la presenza in scena di Francesca, il suo canto, siano un elemento essenziale: le canzoni sono trasformate dalla sua voce. Inizialmente mi sono domandata “ma canterà sempre?”, e invece è il tessuto di fondo, il sogno, i Duran Duran. Se ho potuto scrivere sul tema dei Duran Duran senza sapere chi fossero, significa che erano la trama da cui emergevano quelle voci. La consapevolezza emerge così da un sogno, ed è per questo che arriva più efficace. Il sogno non è cancellato dalla presa di coscienza.
FM: Per noi è fondamentale – visto che la musica per noi è un luogo – che dallo smarrimento iniziale in cui lei è in primo piano, e ci si domanda se canterà sempre, si colga il suo movimento, il suo arretrare ma restare; la musica diventa il luogo dal quale emergono le parole, anche le parole complesse di Lea. Era importante per noi distribuire i livelli che compongono questa storia: “Ragazza In”, la mescolanza di alto e basso, l’intuizione di consegnare a Lea Melandri una rubrica, mettendo gli adolescenti a confronto con questa scrittura e dunque dando loro fiducia.
LM: Fu in effetti un’eccezione assoluta, un atto di coraggio, ma vero anche che se non avessi ricevuto alcuna risposta l’esperienza avrebbe avuto termine. Le lettere, invece, sono arrivate, e la qualità, nei mesi, si è alzata. Erano gli anni della mia analisi e credo che la mia storia di paziente mi dava una consapevolezza e, allo stesso tempo, consegnavo, nel rispondere, qualcosa di me. Ero un evidenziatore: i titoli di rubrica erano parole loro, immagini loro; iniziavo con un frammento che era delle loro lettere. Erano loro in scena.
AMS: Una rubrica teatrale, un lavoro teatrale di montaggio.
Questa fiducia è anche vostra, Fiorenza e Andrea, che avete rimesso in moto questa parola. Da un lato mi interrogo su come oggi possiamo costruire uno spazio che restituisca questa fiducia, e me lo domando anche in relazione alla scuola, dall’altro vorrei che mi raccontaste come proseguirete questo progetto, che mi sembra che contenga molte possibilità.
FM: Io mi occupo molto di formazione, in Francia poi me ne occupo all’interno di un progetto con i ragazzi delle banlieue dove il percorso d’arte non è scelto da loro, ma da chi ha curato il progetto. Vedo la differenza tra lavorare con chi lo sceglie e chi no. Però, in ogni caso, negli anni, ho imparato a togliermi dal mezzo, essere il meno ingombrante possibile, quasi nascondermi. E un fanatismo nella esaltazione di quello che portano loro, che non significa essere acritici, ma accogliere con meraviglia quello che fanno per lavorare su quella materia tecnicamente. Certo, io sono una guida, ma non sono io, non è il luogo mio. Credo che Lea abbia fatto qualcosa di questo tipo: rimanda a qualcosa al di sopra di loro e di lei, non dice “io”. Certo, può fare questo grazie alla sua sapienza, e dunque il punto è come gestisci questa sapienza: per confermarti o per quello che è importante che sia, e cioè sapienza del mondo, non tua. Comprendere questo per me è stato guadagnare una grande libertà.
Fino ad ora abbiamo fatto un primo laboratorio sulle lettere e abbiamo dovuto un po’ stanare i ragazzi dietro i device. Credo che una questione importante sia il linguaggio: loro non parlano di droga, di scappare di casa, di sentimenti in quel modo, ma questo non vuol dire che questi temi non li riguardino. Va ricostruito un linguaggio e possono farlo solo loro. Nei laboratori noi incontriamo i ragazzi e un po’ arditamente consegniamo a ognuno una lettera: di solito andiamo per contrasto, ma non sempre. Le lettere e le parole dei ragazzi vivono, il materiale di Lea è senza tempo: il fondamento del lavoro è proprio che i pensieri sostenuti in queste risposte sono stati elaborati in un modo che non toglie, ora, la loro forza dirompente. Un materiale che mostra la sua potenzialità teatrale ha questi elementi: una questione di base fondamentale sostenuta da elementi della realtà che ti permettono di generare una scena, una condivisione.
AMS: Rispetto alla tua domanda, su come proseguire, le direzioni pensate sono due. Da un lato continuare questa esperienza di laboratori nelle scuole: Milano, Ravenna, Roma. L’idea è giocare portando la lettera, la risposta di Lea, la potenziale risposta della persona alla lettera, la risposta del ragazzo o della ragazza alla risposta di Lea. Dall’altra parte c’è questo desiderio – che prima del Covid doveva realizzarsi a Santarcangelo – di creare un ambiente da abitare in cui ci possano esserci le lettere, le riviste, le parole di Lea. Questo materiale ha una bellezza materica, una consistenza, porta un livello emotivo oltre che semantico delle parole, dunque stiamo ragionando su come creare uno spazio che si accompagni a questo lavoro su parole e musica. Ci sono aspetti da valutare, ad esempio come inserire le nuove elaborazioni linguistiche che vengono composte nei laboratori nelle scuole. È materiale delicato, è importante ragionare su come mettere insieme parole degli anni Ottanta a parole di oggi.
FM: Stiamo poi provando a rintracciare le “Ragazze In” dell’epoca. È per noi molto interessante vedere come una signora di cinquant’anni si comporta quando tu salti fuori con quella lettera che ha scritto a tredici o quattordici anni. Anche questo è un materiale importante di realtà, le reazioni sono ovviamente molto diverse, e ancora dobbiamo capire come farle intervenire.
LM: Volevo dire un’ultima cosa sulla scuola. Noi negli anni Settanta, in una scuola media, abbiamo provato a far entrare nelle scuole le esperienze di vita che tradizionalmente non hanno né traducibilità né voce. La scuola può aprirsi a queste tematiche, ma è certo che è necessario formare gli insegnanti, una formazione da pensarsi come “scrittura di esperienza”, scrittura che interroga le scritture per quello che nascondono: consegnare frammenti di parole di altri da trascrivere, frammenti che come piccole zattere portano la parola di altri e aprono al parlare di sé. Dare legittimità ai vissuti è un bisogno enorme, ad ogni età. La formazione degli insegnanti a mio avviso va pensata in questo modo, ci vuole una esperienza, certo, ma non un sapere trasmesso come contenuti e lezioni.
Mi trovi molto d’accordo, per fare che la scuola sia un’occasione di incontri è necessario che sia abitata da persone che siano disponibili ad incontrare. Io credo che far entrare nelle classi, e non solo con gli studenti, progetti come questo, questa contaminazione con il teatro, possa davvero molto.
AMS: A Bologna è stato possibile portare il progetto nelle scuole grazie ad alcuni docenti, è un bisogno dunque sentito.
Lea Melandri, nella prefazione al libro La mappa del cuore, che raccoglie il mondo cui Fiorenza e Andrea hanno ridato vita, scrive che, fuori dal triste isolamento, nelle trame da lei intessute, le cattedrali del pianto lasciano il posto agli incontri, “alle intuizioni profonde di chi ha visto le radici comuni della paura”. Questo, forse, è un po’ il compito: fare come ha fatto Lea, come ha fatto Ateliersi, dare fiducia a un altro dire, agli adolescenti, ai tempi lunghi del dialogo, alla nostra “seconda segreta vita”; fare che sia occasione di incontro, un incontro che ci renda parte di qualcosa di più grande di noi. Lo ha detto bene Fiorenza: fare accadere la sapienza del mondo.









