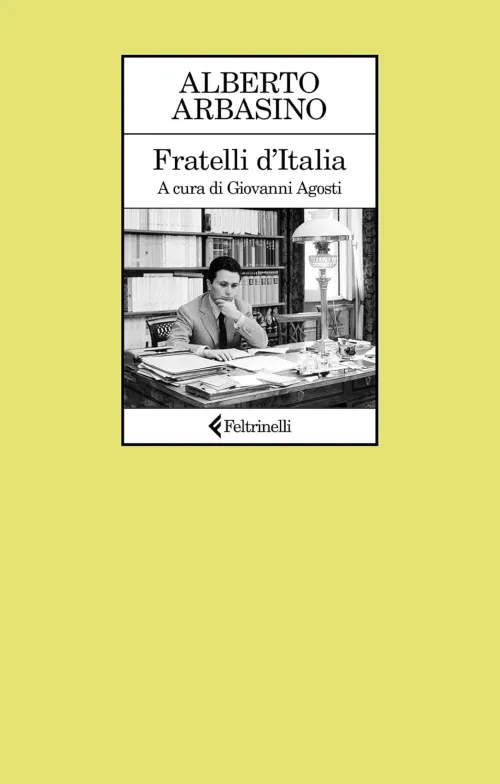Arbasino e i primi Fratelli d'Italia
Nel maggio 1963, un mese dopo l’uscita della Cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, il trentatreenne Alberto Arbasino pubblica per Feltrinelli Fratelli d’Italia, tappa cruciale, col senno di poi (anche se qualche estimatore con le antenne più lunghe degli altri, vedi Roberto Longhi, aveva già capito tutto per tempo) di ogni arbasineide che si rispetti.
Romanzo riscritto, modificato, glossato, ampliato per decenni, Fratelli d’Italia rimbalza cambiando forma e connotati da un editore all’altro, da Feltrinelli a Einaudi, fino ad approdare all’ultima versione a stampa Adelphi, del 1993, che arriva quasi a triplicare in mole la prima versione. Oggi l’originario editore ripropone, per le cure di Giovanni Agosti, la princeps degli anni ’60, con una postfazione del curatore che unisce la natura del documento critico stilato dall’intenditore alla partecipazione intima della memoria affettiva.
Innanzitutto, comincio col dire che Fratelli d’Italia è un romanzo torrenziale ma svelto; scritto tutto al presente, scorre liscio con lo stesso ritmo e la stessa velocità delle spider rombanti dei suoi protagonisti, una manciata di giovinastri di genio, ipercolti, amabilmente sbarazzini, privi di complessi o inibizioni e dall’apparenza annoiata che si lasciano alle spalle guerra, bombardamenti e miseria per gettarsi a pesce nell’incipiente era del boom economico.
La vita di questo specimen sociologico quasi didatticamente cosmopolita (un italiano, uno svizzero, un francese, un tedesco…) fila in un vortice che tocca, su e giù, tutta la Penisola (con estreme puntate in Baviera e a Londra), in una caccia inesausta di prime teatrali e festival musicali, mondanità intellettuale e turismo brado (si batte a tappeto il mondo della provincia italiana) o d’élite, dove l’euforica educazione sentimentale di una generazione assume anche i tratti di una fuga a gambe levate da un recente passato opprimente.
Ho detto che questo è un libro scattante, tutto scritto al presente: seguendo le scalmanate mattane dei vari personaggi, da Antonio (alter ego dell’autore) all’Elefante (il narratore), da Klaus a Jean-Claude, si passa con brio tra passacaglie, sandali color pantegana e foulard color pulce, orrori vacanzieri (a Capri: «se tutti mettessero per terra il cane che portano in braccio, si camminerebbe sui cani»), vasi di vetro con le cotognatine, cineserie, interni romani con Topo Gigio, sciure milanesi che mangiano salsicce, duchesse napoletane che sembrano guardiane dei cessi, marchette romanacce vestite con la pelle di leone, bassotti che bevono il tè (nel servizio buono), scarpe trovate in frigorifero, centrini e sottobicchieri, il riassunto, per bocca di certi monsignori, di un romanzo di Giuseppe Garibaldi (la Clelia), che cade nel centro geometrico del libro.
Ecco, in tutto ciò, il gran romanzo arbasiniano, in questa sua prima versione, fila come l’olio. Come scrive Agosti nella sua postfazione, manca perfino l’ombra, nel dispiegarsi di questo suk social-teratologico, del plurilinguismo di Gadda, del suo pastiche-pasticciaccio ibridante e turrito. Quella di Arbasino è, al contrario, una lingua veloce, un italiano prensile, sovraregionale, che mima, nel modo più fedele possibile, con verve e frizzantezza, gli effetti del parlato (dove i grappoli sintattici spesso interrotti dai tre puntini fanno pensare che la visita fatta a Louis-Ferdinand Céline pochi anni prima, nel 1957, e poi documentata in Parigi o cara, ha lasciato per forza il suo segno).
Ovviamente non a caso ho fatto il nome, più che prevedibile, di Gadda, di cui Arbasino stesso si è proclamato, in un testo raccolto poi nel suo L’Ingegnere in blu, dedicato al Gran Lombardo, “nipotino”: non tanto quel Gadda orsino, accigliato, torvo, che se ne usciva in una manciata di anni (dal 1957 al 1963) con i due capolavori covati per decenni del Pasticciaccio e della Cognizione del dolore, appunto: è soprattutto il Gadda dell’Adalgisa, quello intercettato idealmente da un Arbasino giovanissimo, migrato poi presto a Roma lasciandosi alle spalle la nativa Voghera, la Pavia universitaria, Milano: l’impietoso fustigatore del genius loci meneghino, di quel mondo umbratile di vecchie mamme e zie chiuse nella muffa di antichi tendaggi, osannanti alla cultura del risparmio, del sacrificio, della sofferenza che è il punto di arrivo, frollo a dovere, della illuminata borghesia lombarda settecentesca.

Fratelli d’Italia va da tutt’altra parte, ma questo è il suo retroterra: una piena consonanza gaddiana, quasi sempre implicita, corre sotterranea a tutto il romanzo, ed emerge e si fa evidente, qua e là soltanto, in una tirata rivelatrice, in un ritratto particolarmente velenoso. Così si legge, per esempio, nelle prime righe del quarto capitolo (su dodici totali):
Ho avuto dei giorni difficili, sai, in casa mia… Il puritanesimo lombardo della Controriforma, chissà come lo conosci, tu… La moralità tipo San Bernardino alle Ossa… La Divinità contenta solo quando si rinuncia a qualche cosa per amor suo… fare molti fioretti… soffrir tanto per farle piacere… più si sta male, più lei gode… quindi, non buona… E i morti sempre lì sotto, presenti, se ne parla sempre e si vanno a trovare continuamente… coi loro fiori, e i loro lumini, e le loro reti d’affetti claustrofobici coi vivi… […] E in ogni divertimento, sempre implicito qualche cosa di peccaminoso, di ingiusto… che prima o poi verrà punito… Fra la sedia e la poltrona, sempre scegliere la sedia… La frase più frequente: sarebbe troppo comodo!... Come se quel “comodo” fosse un giudizio di valore sfavorevole… Metà si fanno preti o suore, in casa mia, cosa credi…
Da qui, poi, la partenza a razzo verso un mondo di chicche e fondants, di liberazione sessuale e avventure nelle pinete: di viaggi internazionali in cui la spinta di una vorace ed elettrizzante esterofilia fa prendere nota di tutto, dai gemelli da mettere ai polsi, ai formaggi giusti da assaggiare, alle riviste indispensabili da leggere introvabili in patria.
Questa apertura catalogica al grande inventario del mondo, non poteva avvenire che nelle forme esplose del metaromanzo, meglio, come scriveva Alfredo Giuliani, del metaromanzo che contiene in sé anche le proprie istruzioni per l’uso, e che prende, tra le altre, la foggia del romanzo-conversazione, dove si seguono, oltre alle peripezie degli eroi, anche quelle dei concetti (intermezzi sullo stato dell’arte che sembrano arie o recitativi, cori e assoli virtuosistici: su musica, narrativa, lirica, prosa; con l’aggiunta di dossier semiprivati di celebrità letterarie).
Un flusso dialogico a siparietti che inocula arditamente affondi saggistici in un corpo narrativo, tutto sommato, esile (il plot di Fratelli d’Italia, a dispetto della sua mole, si riassumerebbe in una decina di parole). È in questi straripanti monologhi, omaggio pop alla civiltà della conversazione propria del mondo di Proust, e prima ancora di Stendhal, Manzoni, Leopardi, che Arbasino regola i conti con la miseria culturale dell’Italia del Dopoguerra: come nelle famose pagine sulla «gita a Chiasso», diventata negli anni un proverbiale tormentone autoriale:
Per gli autodidatti sarebbe anche bastato fare una gita a Chiasso intorno al 1930 invece di buttar via i trent’anni migliori della vita umana lamentandosi a vuoto e perdendo del tempo a inventare la ruota o a scoprire il piano inclinato mentre gli altri marciavano già in treno o in dirigibile. Bastava arrivare fino alla stanga della dogana di Ponte Chiasso, due ore di bicicletta da Milano, e pregare un qualche contrabbandiere di fare un salto alla più vicina drogheria Bernasconi e comprare, oltre a un Toblerone e a un paio di pacchetti di Muratti col filtro, anche i Manoscritti economico-filosofici di Marx (1844), il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein (1921)…
Ma la cosa interessante, per me, è che lo scatto in avanti e all’esterno, implica quello che ci si lascia alle spalle, a casa propria: l’enciclopedismo eclettico di Arbasino (che si traduce, sulla pagina, tra l’altro, nella sua tipica e affabulante carovana di forestierismi) è mosso da una molla più oscura della gioiosa scoperta del mondo e dei suoi multipli aspetti: lo aveva intuito Giovanni Testori: «la verità vera è che Arbasino (e lui lo sa benissimo) corre da un cantone all’altro del globo perché avverte, sente o presente che la pace delle sue ossa la troverà solo a Voghera». L’estro catalogico e la sua corsa inventariante come fuga dal ristagno e dalla morte. Ed è proprio la Morte, come in una moralità barocca, che si mostra in pochi momenti cruciali del romanzo, e fa da contraltare allo zampillante spettacolo delle forme sociali.
Oltre al piacere di leggere la prima mano dell’opera (la stessa versione, del resto, che l’autore aveva scelto di inserire nel Meridiano a lui dedicato uscito nel 2009), tra gli elementi notevoli di questa edizione spiccano le suggestioni della postfazione di Agosti (cui si potrebbe affiancare la lettura di Stile Alberto di Michele Masneri): la ricostruzione della preistoria del romanzo, con tanto di camarille di araldi e detrattori (Giorgio Bassani che doveva ospitare Fratelli d’Italia nella collana da lui diretta, ma che finisce per impazzirci, sul patchwork arbasiniano di saggistica e narrativa); a libro uscito, la lista infinita delle stroncature, con la mondanità degli ambienti alti che riconosce il proprio ritratto e si sente sputtanata praticamente in ogni riga; il tentativo di assegnare un volto reale ad ogni pseudonimo usato dall’autore per i suoi personaggi: per pararsi le spalle senza rinunciare a descrivere la realtà precisa e concreta che voleva ritrarre.
Un ultimo elemento contraddittorio ricordato da Agosti: con Arbasino si ride serissimi (i francesi usano la bella espressione pince-sans-rire), un distacco elegante ma arguto, cui non sfugge nulla, domina il suo sguardo: e la stessa postura, che qui può farsi spietata, riguarda l’amore (anzi, l’«amòr»). Non appena gli affetti si surriscaldano, non appena incominciano ad aleggiare gli spiritelli dei sentimenti, un implacabile colpo di bacchetta magica li trasforma in un melodramma che si può freddare con due battute; un’ironia gelida e galante stringe il cuore di Arbasino, e lo fa andare per il mondo con passo vivace (oppure, che è la stessa cosa, come scriveva Pasolini, lo fa zoppicare segretamente, come un cane cieco e randagio).
Leggi anche:
Roberto Deidier | Arbasino dall'America agli Zombi
Raffaele Manica | Arbasino in blu
Marco Belpoliti | La frivolezza di Arbasino
Marco Belpoliti | Arbasino parla di Pasolini