Io e mio figlio Federico Aldrovandi
Nonostante l’aria condizionata, fa ancora molto caldo qui dentro, nell’aula del tribunale. E non riesco a pensare a niente. Sono passati due anni dalla prima udienza del processo, è il 6 luglio 2009. Il giudice Caruso è in camera di consiglio da cinque ore. Sono quasi le sette di sera, dovrebbe uscire da un momento all’altro. In tutti questi anni non sono stata in grado di leggere dietro quella sua espressione immobile, che ha sempre mantenuto in aula. Non sono riuscita a cogliere un’emozione, una smorfia, un trasalimento anche piccolissimo che mi permettesse di intuire i suoi pensieri. Nulla.
Sta uscendo con un foglio tra le mani. La sentenza. Colpevoli. Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto sono condannati a una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per eccesso colposo in omicidio colposo. Sono colpevoli.
Piango rido, rido piango. Stefano e Lino sono qui, accanto a me che rido e piango. Piange e ride anche Lino, abbraccio Stefano. Piangono anche i nostri avvocati, mi cercano i giornalisti, si avvicinano per avere una dichiarazione. «È giusto.» Riesco a dire solo questo, tra le lacrime. Sono le uniche due parole che mi risuonano dentro. È giusto. È giusto che ci sia una condanna, non sono riuscita nemmeno a sentire di quanti anni ma non è così importante. C’è una condanna, questo conta. È giusto. Sento di avere ottenuto giustizia, c’è una sentenza, finalmente.
In questi anni ho capito cosa significava realmente quello che ho provato in quel momento. Perché la sensazione di avere avuto giustizia passa senz’altro attraverso le sentenze dei tribunali, che sono fondamentali, ma va oltre. Non si ferma qui. Quello che conta è il significato di una sentenza. Quando un giudice arriva a definire la colpevolezza di un imputato, come è successo per noi, questa consapevolezza diventa pubblica. Il giudice sancisce la colpevolezza davanti a tutta la società.
Per me, per il mio dolore, è importante. Perché ho bisogno del consenso, della consapevolezza di tutti. Di sentire che gli altri sono a conoscenza, come lo sono io, di quanto è accaduto. Che è chiarito, stabilito davanti a tutti quello che i quattro poliziotti hanno fatto a Federico. La società poi, in fondo, è questo: il gruppo, le persone, il movimento. Possiamo definirla in tanti modi. È la coscienza diffusa. Ed è di questo che hai bisogno per non sentirti sola.
È il valore sociale di una sentenza che, alla fine, ti fa sentire di avere avuto giustizia o meno. Per me non era importante che la condanna fosse di tre anni piuttosto che l’ergastolo. Era importante che fosse una condanna.
Vale per tutti. Loro sono colpevoli. Tutti lo sanno.
Tutti sanno che hanno ucciso Federico.
Anche se le pene sono state basse, mi consola il fatto che sia un esempio per gli altri. Perché ce ne sono tantissimi di casi così. La vera vittoria è che è aumentata la sensibilità pubblica rispetto a queste vicende.
Vuol dire non essere più inermi.
Che cose del genere non potranno più accadere nel silenzio generale.
È per questo che di fronte a queste tragedie il bisogno di socializzare è così forte. Per questo condividere l’impegno con gli altri è stato necessario.
La dimensione sociale coinvolge persone che non conosci ma che sentono quello che senti tu, che partecipano ai tuoi stati d’animo. È questo che ti permette di ricevere e di dare, è uno scambio. Perché so di fare qualcosa che vale per Federico ma che varrà anche per tutti i Giacomo o gli Stefano, per tutti i ragazzi del mondo. […]
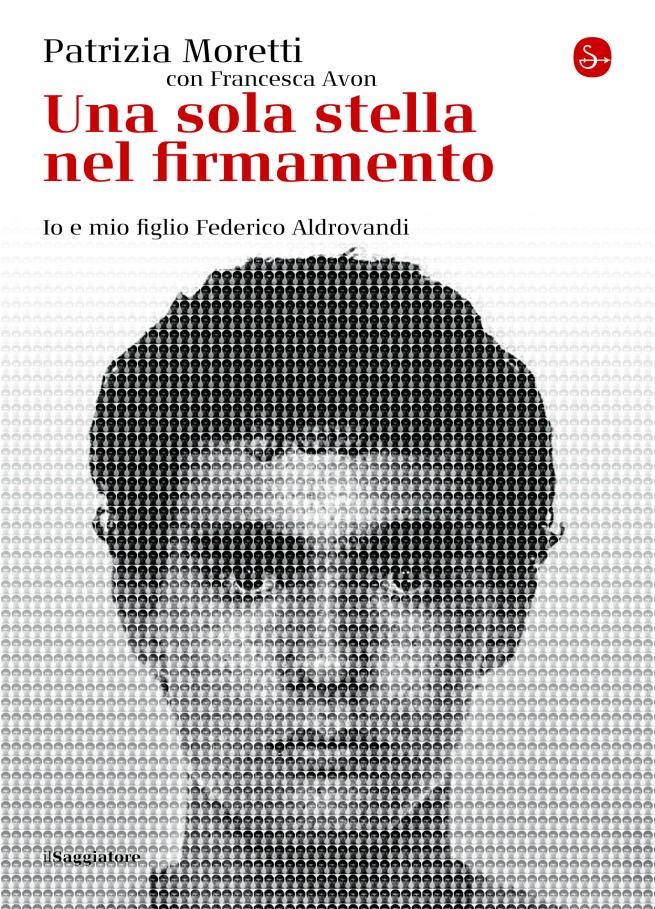
Una condanna deve incidere nella vita della persona che la subisce. Se sei colpevole non è possibile che nulla cambi nella tua vita. Concretamente.
Dopo la condanna definitiva, abbiamo chiesto che i quattro poliziotti venissero licenziati dalla Polizia di Stato, in quanto persone prive dell’equilibrio e della perizia necessaria per fare questo lavoro. Ho chiesto inoltre che venisse stabilito che chi è condannato in via definitiva, anche per pene inferiori a quattro anni, venga allontanato dalla forze dell’ordine. È intollerabile pensare che, alla fine, potrebbero essere liberi di compiere ancora quello che hanno fatto a mio figlio.
Pontani, Pollastri, Forlani e la Segatto sono stati condannati con sentenze pesantissime che contenevano giudizi trancianti sul loro operato. E poi succede che lo Stato, il loro datore di lavoro, li riaccoglie e li rimette al vecchio posto. Non ci sto, non posso accettarlo. E non mi convincono le risposte che tirano in ballo i regolamenti. Così il cerchio non si chiude. […]
L’istituzione principale, il ministero degli Interni, però non ha ancora risposto alla richiesta di licenziamento dei poliziotti condannati. È una richiesta che abbiamo fatto pubblicamente, molte volte, ai diversi ministri che si sono succeduti in questi anni. Ne abbiamo parlato con i vertici della Polizia, sono andata alla Camera e ho incontrato la presidente Boldrini. Ma è il ministero degli Interni che deve prendere una decisione.
Sembra ci sia sempre un ostacolo insormontabile. Qualche cavillo burocratico. Quando mi sento rispondere con frasi del tipo «per l’omicidio colposo non è prevista la radiazione» mi sento offesa, sono parole indecenti.
Possibile che i regolamenti non si possano cambiare? Leggi assurde si rivedono. Ma se non si possono cambiare regolamenti che feriscono l’umanità delle persone allora c’è qualcosa che non funziona. Io temo che in realtà non si voglia cambiare e questo mi fa paura.
Pensare che dopo tanta fatica e tante lotte nulla cambi è frustrante, mi fa arrabbiare, mi fa stare molto male.
Mi resta quest’ultima rivendicazione, non penso si tratti soltanto di una faccenda privata. L’ho detto, è una questione sociale. La mia battaglia in tutti questi anni è stata sostenuta dalla fiducia nelle istituzioni, il mio interlocutore finale. Se non avessi avuto fiducia forse tutta questa strada non l’avrei fatta. E non dico che non l’avrei fatta in questo modo, che è l’unico che conosco, ma non l’avrei fatta proprio. Se non cambia nulla nella vita di chi ha ucciso mio figlio, sono costretta a cambiare idea sulle istituzioni. La mia fiducia vacilla parecchio.
Ormai tutti e quattro i poliziotti hanno finito di scontare la pena. Non lo so dove siano. So soltanto che per loro è prevista una sospensione dal servizio di sei mesi. È una sanzione decisa dalla Commissione disciplinare del Dipartimento di Pubblica sicurezza, so che Monica Segatto ha fatto ricorso al Tar, il suo avvocato è Ghedini, quello di Berlusconi.
Al termine di questi sei mesi, se nulla cambia, i poliziotti rientreranno in servizio. Come se niente fosse, con le stesse prerogative. Ho saputo addirittura che Forlani l’avevano messo all’Ufficio stranieri, prima della detenzione. La loro posizione è demandata ai Consigli provinciali di disciplina delle questure del Nord Italia, saranno loro a valutare. So che c’è un procedimento disciplinare in corso. Ho chiesto di poter accedere agli atti ma non è possibile, è una questione interna alla Polizia che tale deve restare.
Non penso mai a loro come delle persone con un’identità definita, un nome e un cognome: Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri. Non so se si tratti di un meccanismo di fuga, di una difesa ne- cessaria per poter sopravvivere. Ma ci penso poco, perché pen- sarci mi fa male. Il cervello scappa, fugge, si ribella a questo pensiero.
Quello che in realtà mi aspetto ora trascende il futuro di questi quattro singoli individui. È un desiderio spersonalizzato che riguarda un contesto più vasto, riguarda proprio le condizioni in cui ci troviamo nei confronti dell’istituzione. Può la Polizia mantenere in servizio persone simili? Certo, siamo noi, la famiglia di Federico e i quattro poliziotti condannati a essere coinvolti, ma la questione non riguarda solo noi. Il concetto va oltre, è più ampio, è questa dimensione che oggi mi interessa. La mia, a questo punto, è una rivendicazione sociale, non è più privata. Del destino dei singoli non mi voglio occupare, non mi interessa. Preferisco non pensare alla loro esistenza perché mi fa male. Preferisco pensare a un ideale, a una concreta possibilità che le cose cambino.
Un estratto dal libro di Patrizia Moretti con Francesca Avon, Una sola stella nel firmamento. Io e mio figlio Federico Aldrovandi (Il saggiatore)
Il libro verrà presentato a Milano martedì 6 maggio alle 18.00 presso la Feltrinelli di piazza Duomo. Con Patrizia Moretti e Francesca Avon interverranno Natascha Lusenti e Silvia Ballestra







