Speciale
La leggerezza e la ferita: Calvino di fronte e di spalle
Sono trascorsi trent’anni da quel 19 settembre del 1985 in cui Italo Calvino moriva improvvisamente all’età di 62 anni a Siena. La vita di Calvino non è stata poi così lunga, eppure ha scritto tanto e soprattutto ha attraversato da protagonista insieme ad altri (Pasolini, Sciascia, Morante, Volponi, Moravia, ecc.) la letteratura italiana del dopoguerra, dal 1947, anno del suo debutto con Il sentiero dei nidi di ragno, sino a quella fatidica metà degli anni Ottanta.
Trent’anni sono un tempo sufficiente per tracciare un bilancio della sua opera. C’è ora una nuova generazione di critici che si affaccia con intelligenza e crescente autorevolezza nel paesaggio letterario italiano. Sono quasi tutti nati negli anni Ottanta, ed erano ancora bambini quando Calvino ci ha lasciato. A loro abbiamo chiesto un bilancio dello scrittore Italo Calvino nella forma più diretta ed efficace: cosa è vivo e cosa è morto della sua opera? Cosa ci serve ancora oggi di Calvino, dei suoi libri, dei suoi saggi, dei suoi interventi giornalistici e anche politici? Cosa è invece diventato obsoleto o non serve più? Quale giudizio formulare su di lui? Possiamo separare Calvino dalla sua epoca, dal rapporto con il suo tempo, oppure no? È diventato un Classico?
Si tratta di tracciare un bilancio e di prendere delle misure, formulare giudizi che saranno, ovviamente, anche generazionali. Ed è proprio questo che ci interessa.
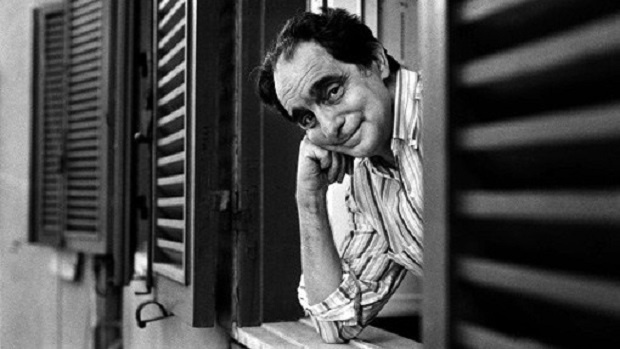
Nello spiegare il perché amasse i suoi scrittori preferiti, in un’intervista apparsa nel 1959 su “Nuovi Argomenti”, Italo Calvino affermava: «amo Kafka perché è realista». Quel Kafka che ha insegnato al nostro Novecento che realismo, dopo di lui, avrebbe significato «qualcosa di più profondo» e che pertanto Calvino non poteva esimersi dall’arruolare alla sua genealogia. Fautori, entrambi, di un necessario sguardo obliquo sulla realtà, di un realismo che potremmo qui definire strabico: Franz declinandolo sotto il sole allucinato dell’angoscia; Italo, al contrario, in nome di quel valore-cardine della leggerezza (da intendere sempre come «reazione al peso di vivere»), sotto il segno del quale si apriranno le sue postume Lezioni americane (1988). Non è un caso che quella prima conferenza si chiudesse proprio ricordando il cavaliere del secchio, protagonista di un breve ed enigmatico racconto di Kafka (Der Kübelreiter, 1917), che, alla ricerca di un po’ di carbone in una fredda notte al tempo della guerra, vola in sella al suo secchio vuoto (segno di privazione e insieme desiderio, ricerca): la più azzeccata proiezione autobiografica; emblema per antonomasia del senso ultimo dell’avventura letteraria del signor Calvino (a suggerire come, in fondo, la levità calviniana discenda da un’analoga inquietudine nei confronti dello stare al mondo).
Nel loro destino di autori è inscritto il desiderio comune di esorcizzare, reinventandole, angosce e paure: è lo stratagemma di Perseo assurto a metodo, lo scrutare nello scudo che si fa specchio deformante; strumento di allegorizzazione di una realtà che riesce comunque indecifrabile. Come accaduto già con Dostoevskij e Proust, anche la letteratura di Kafka e Calvino (certo ciascuno a suo modo) si volge alla radicale necessità di raccontare l’uomo, offrendone una mutata rappresentazione (è indubbio che il più sofisticato, geometrico, intellettualistico, fu senz’altro il ligure). Si potrebbe parlare, in analogia con il mondo della scienza, di svolte paradigmatiche o di rivoluzioni copernicane, riguardo alle possibilità intraviste, da Dostoevskij a Calvino, passando per Proust e Kafka, nel ripensare e immaginare la nostra condizione. Che la partita decisiva per la sopravvivenza dell’uomo del XXI secolo non possa più prescindere dall’attualissima lezione dell’autore delle Città invisibili – dal rigoroso memento che l’uomo della storia non debba mai smarrire la coscienza di essere, prima di tutto, uomo nella natura e della natura – mi pare sia sotto gli occhi di tutti. L’uomo è stato e rimane, per dirla con una battuta, un bipede che s’è montato un po’ troppo la testa. L’occhio di Calvino avrebbe dovuto aiutarci a sviluppare gli anticorpi di un’etica tanto essenziale quanto complessa. Certamente fu questa l’utopia di superficie connessa a quel controrealismo disancorato da ogni addentellato col tradizionale canone dell’impegno. E invece?
A trent’anni di distanza dalla sua scomparsa, possiamo tentare un bilancio, interrogarci sulla tenuta di quell’alternativa rappresentazione, frutto di una siderale presa di distanza; mirare, più da vicino, al disegno nel tappeto. La lettura unilaterale di quest’autore ha finito, da un certo punto in poi, per disinnescare e neutralizzare l’effettiva portata della sua opera: e, forse, non poteva andare diversamente, appellandosi il nostro a un’ideologia così onnicomprensiva nel declinare la sua perplessa critica dell’esistente, tradotta in ossessiva ricerca di metodo e nella speciale devozione per il gioco combinatorio. Il moltiplicarsi degli studi sull’autore, se da un lato ha contribuito a certificarne l’indiscutibile peso, dall’altro sembra non aver giovato abbastanza a fugare del tutto il vizio prospettico di una lettura o in subordine o in chiave d’antagonismo; e questo ancora sul finire degli anni Novanta, se a due anni di distanza da un saggio di svolta nella critica calviniana come quello di Belpoliti (L’occhio di Calvino, 1996) Carla Benedetti usciva con il suo Pasolini contro Calvino (1998), comprimendo il suo giudizio nella dialettica tra non-finito e finito, contestazione e incarnazione delle dinamiche in atto, per risolverlo a tutto vantaggio di P.P.P., interprete non accomodante (a differenza del ligure) della crisi intellettuale e culturale degli anni Settanta. A parte il sentire oggi, dal canto mio, prossimo, più l’incerto Calvino che non lo sventurato Pasolini, profeti entrambi senza dubbio, ma il primo assai più insospettato, proprio nel teorizzare quel continuo annaspare, quella mancanza di centro, di punti saldi, che mai come adesso fa parte del nostro bagaglio minimo di navigatori a vista. La loro contrapposizione può avere ragioni d’esistere solo partendo da presupposti ideologici; mentre bisognerebbe tenerli insieme, entrambi preziosi e direi, semmai, complementari, nel fornire una chiave di lettura – il poeta di Casarsa sul piano della storia, lo scoiattolo della penna su quello d’una finalmente recuperata filosofia della natura – di quegli anni decisivi. Così come mi ha stupito non poco leggere, in un editoriale di Berardinelli apparso lo scorso anno sul “Foglio”, che l’olivettiano Volponi sarebbe «l’anti-Calvino della narrativa italiana», per poi sbalzarne un ritratto le cui caratteristiche – e soprattutto l’assillo del caos, l’utopica disposizione a ricercare la quadratura tra mente e realtà fisica – appartengono, inequivocabilmente, anche e in maniera decisiva al Calvino della svolta cosmicomica. Anche in questo caso, dunque, si ripropone lo schema dell’obbligata definizione di Calvino in negativo, giustapponendone l’esperienza e l’opera ad altri preferibili e apocalittici interpreti, rispetto all’integrato ed etereo profeta che a un certo punto (dopo l’uscita dal P.C.I.), rampante, come il barone Cosimo Piovasco di Rondò, ha traslocato sul suo albero frattale per mai più discendervi (epperò decidendo di portare con sé una rinnovata cassetta degli attrezzi). Risultato? Tutti gli altri big del secondo Novecento italiano sarebbero da preferirgli, al più la sua opera servendo come mezzo di contrasto per meglio far risaltare la chiaroveggenza altrui, dei Pasolini, dei Volponi, appunto. Al massimo concedendogli il dorato confino nell’alveo di un manieristico epigonismo, per quanto di alta fattura (come fece Baldacci che, sempre pronto a registrare verticali primogeniture e ricostruire alberi genealogici, già ai tempi dell’uscita dei racconti deduttivi di Ti con zero, decretò la sua discendenza da una costola di Bontempelli). Stenta insomma a tramontare l’idea di un Calvino distante: solitario Dio di uno spazio tutto suo, cerebrale e letterario; quando, al contrario, ci allontana soltanto in apparenza dalla vita: nel “distrarci” coi suoi freddi tatticismi; ché le ipotesi di carta sulla nostra cronica inadeguatezza, servono a profilare un’etica alternativa, utile a rimanere a galla e resistere agli urti. E che dire dell’affrettata conclusione di liquidare il suo come un «moralismo aurorale, con apparenze anti-morali», per ridurre tutta la sua produzione letteraria a «una bella sala pedagogica», una lustrata raccolta di fiabe e di nuovi miti pronti all’uso? Così ancora il Berardinelli di Casi critici (2007) che ci ha regalato uno dei saggi più intensi sul “Calvino moralista” (ch’era peraltro già apparso su “Diario”), inanellando fulminei intercambiabili ritratti dello scrittore (quasi calvinianamente ispirati a una variazione su tema unico), la cui imperturbabile saggezza lo rassomiglierebbe a una sorta di Lao Tzu postmoderno e le cui calibrate stenografie avrebbero l’esotico sapore di un koan zen (si pensi a quanto si è scritto sul finale di “Come imparare a essere morto”, l’ambiguo raccontino di chiusura di Palomar). Forse qui, istintivamente impegnato a chiudere i conti con lo strutturalismo e gli avversati fortini della teoria della letteratura (che vede replicati nella narratività a emotività zero, ad apparente zero conflitto del ligure), Berardinelli, infine, risolve il suo racconto critico nella vulgata comune sullo scrittore che moltiplica, occulta, disperde in calcolato e raffinatissimo giuoco tutto quanto: dispone simmetriche toppe dinnanzi ai buchi neri della vita. E quasi non riuscendo più ad arginare un moto d’ironia, erompe in una retorica domanda: «Come non essergli grati?».
Nemmeno una parola spesa dal critico, invece, su quanto tragico sia il destino diviso inscritto in quella maschera di atterrita giocosità che Italo non smette d’indossare: sempre in bilico, sempre a rassicurare, proprio mentre patisce; negandosi al caos della vita, per non turbare il lettore ma soprattutto se stesso. Anche quando un infallibile patologo come Cesare Garboli in Pianura proibita (2002) si sofferma sulle ragioni profonde dell’ostinato trincerarsi di Calvino dentro la rigorosa pratica di una letteratura che potremmo definire della distanza (basata sulla sistematica elisione dell’io autoriale), attribuendo alla cifra ludica della sua scrittura il tratto di una puerilità bloccata, omette tuttavia di specificare come quella stessa puerilità, così espressa, fu il segno della conclamata nevrosi dello scrittore: per Calvino, come per l’Amleto della Taverna dei destini incrociati (1973), il gioco letterario è ricerca di metodo, la ricerca di metodo è nevrosi, la nevrosi si manifesta come ossessiva ricerca di un grimaldello gnoseologico che lo rassicuri circa la possibilità di decrittare la realtà.
Cosa ci rivela tutto ciò? Che la figurina del Calvino degli accoppiamenti giudiziosi, l’autore che più di tutti ha saputo incarnare, attraverso la sua opera, la conciliante pax tra autore e critica, che ha messo d’accordo Nouvelle Critique, scienza e pubblico dei lettori, non basta più ad esaurirne la complessità. Ché alla distanziante facciata corrisponde, sottotraccia, un’implicita autobiografia del rimosso (nel segno di quella nevrosi di cui s’è detto) che andrebbe dipanata e messa in luce (vicenda questa che pare accomunare autori, peraltro assai diversi tra loro, come Gadda, Sciascia, Consolo, per stare ai più noti).
E dire che basterebbe ripercorrere la parabola intellettuale di Calvino a principiare da quello snodo centrale, e non solo per lo scrittore, che è La giornata di uno scrutatore (1963), libro-referto di una crisi e individuale e storica, e da cui tutto ricomincia; proseguire magari tirando via il belletto a Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), sintomo dell’ennesima impasse, in cui, fingendo di parlare del e al Lettore, parla in verità di e a se stesso; togliere via gli occhiali, infine, al miope signor Palomar che, al netto dei suoi sempre falsificabili teoremi, non riesce a liberarsi dall’ansia del dubbio…
Accanto al Calvino sincero moralista, dallo slancio utopico e dalla rinnovata etica, autore insomma (come del resto Levi e Volponi) della complessità, interprete di sacrosante “illusioni” e stoicamente addestrato alla distanza, rimane, nell’ombra, ma tutto da scoprire, il Calvino della nevrosi, dello spavento della vita.
Domenico Calcaterra, nato nel 1974 a Sant’Agata di Militello, è dottore di ricerca in Letteratura Italiana, Cultore della materia presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina. Alla pubblicazione di saggi dal passo più analitico come Vincenzo Consolo. Le parole, il tono, la cadenza (Prova d’Autore, 2007) e Il secondo Calvino. Un discorso sul metodo (Mimesis, 2014), alterna scritture critiche, nella misura della recensione o del saggio breve, alcune delle quali sono poi state raccolte in Niente stoffe leggere (Meligrana, 2014). Collabora con “L’Indice dei Libri del Mese”, “Doppiozero”, “Succedeoggi”.







