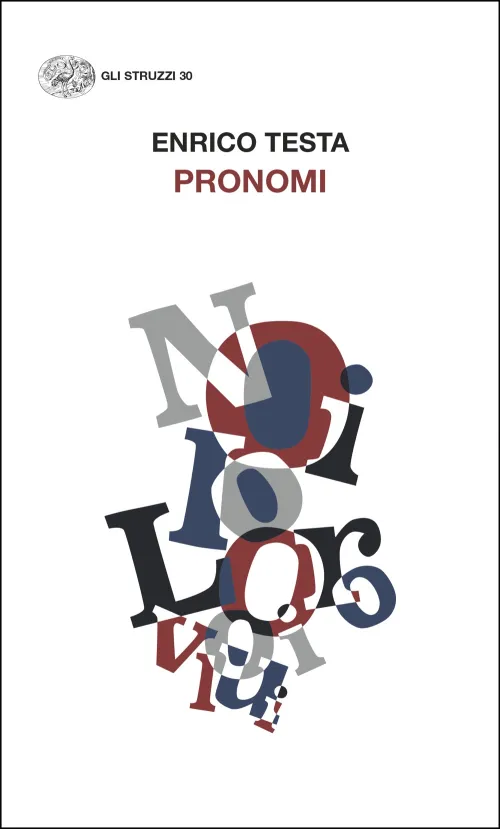Enrico Testa: tu noi voi loro
Raffinato interprete e antologista della lirica italiana secondo-novecentesca, maestro di un’intera generazione di storici della lingua e critici stilistici, nonché traduttore e rinomato poeta in proprio: tutte queste anime sembrano confluire, apparentemente scomposte, nell’ultimo libro di Enrico Testa, Pronomi (Einaudi 2025); una sorta di autobiografia intellettuale sparpagliata in una miriade di frammenti di varia lunghezza e impegno, in cui citazioni dai propri auctores si alternano a riflessioni esistenziali, digressioni lessicologiche, schegge critico-letterarie, malumori sull’età contemporanea ecc.
Più che come un testo autobiografico a tutti gli effetti, dunque, Pronomi (che rielabora e aggiorna una prima versione del 1996) si legge come uno zibaldone di appunti senza date, un registro di affezioni intellettuali costruito secondo uno “stile interruttivo”, nel segno di Benjamin, e che al tempo stesso, attraverso le medesime schegge di cui si compone (e i frequenti richiami interni), dà forma a un soggetto testuale rispondente a una concezione apertamente dialogica, relazionale (“reattiva”, direi) dell’identità. In altre parole l’io, il pronome responsabile dell’atto enunciativo, si trova definito in queste pagine da una pletora di voci, parole e figure dell’alterità (tu, noi, voi, loro) che lo attorniano, lo confortano con la propria presenza o assenza – o, più spesso, lo provocano.
Se è dato infatti rintracciare, in queste quasi 350 pagine di notazioni divaganti (ma sempre stilisticamente calibrate), una specie di tratto ricorrente, è soprattutto nella tonalità generalmente disforica (spesso polemica e risentita, più spesso ancora melanconica) della voce che dice io, che in questo senso fa della provocazione – ricevuta e impartita – uno strumento di avvicinamento alla conoscenza attraverso il rifiuto di ogni conformismo.
È un sentimento apocalittico, quello di Testa (si veda, già nel risvolto, il riferimento a un “tramonto occidentale” osservato da una sdegnosa finestra), che prevedibilmente tende ad appuntarsi sulle storture di un’epoca out of joint se mai ce ne furono quale quella attuale, tra sedicenti bisogni costantemente indotti dal mercato, svendita all’ingrosso di ogni principio etico e una sorta di insopprimibile coazione all’esibizione narcisistica di sé (o del proprio avatar digitale); un’epoca che, rifiutando ogni forma di sofferenza e difficoltà, allo sguardo caustico dell’autore ha ormai assunto i modi di “una commedia in cui non ci si vergogna più di nulla e ci si offende di tutto”.
Solitudine, dipendenza generalizzata dai dispositivi (tante piccole botte di dopamina a ogni notifica, ogni cuoricino, ogni sospetto di vibrazione dello smartphone nella tasca), un regime di informazione dilagante che erode, fino a smaterializzarla, la memoria del mondo reale e la fiducia nella sua antica concretezza: dal fondo di questa grottesca simulazione multitasking cui la stessa esperienza del reale, almeno dalle nostre parti, pare essersi ridotta, il Brontolio d’oltretomba di Testa (come da titolo, tutt’altro che ironico, di uno degli ultimi capitoli) sembra trovare parziale sollievo nella tendenza ossessiva a vagabondare tra storie e parole di affezione, in una sorta di dromomania intellettuale che ha in Walser, Handke, Celati e in altri celebri passeggiatori letterari le proprie guide d’elezione.

Meta prediletta (e prevedibile) delle peregrinazioni d’autore, come tali necessariamente prive di un solido filo narrativo-argomentativo, è infatti il linguaggio; o meglio, e in primo luogo (per ciò che pertiene al momento destruens), il suo continuo “tradimento”, diagnosticato ora nei tic della comunicazione social-mediale e dell’aziendalese che infestano le conversazioni; ora nelle forme di una retorica pubblicitaria che, dietro il richiamo a parole svuotate di ogni significato (e perciò altamente redditizie) come creatività, libertà, autenticità ecc., rivela il suo asservimento alla propaganda neoliberista del produci-consuma-crepa; o, ancora, nelle nevrosi del catechismo benpensante, con i suoi bollini rossi e le sue parole d’ordine calibrate sull’ultima suscettibilità del giorno (e vale la pena notare come siano tutte, quelle qui convocate, sottovarietà di un’unica anti-lingua, per dirla con Calvino, di importazione statunitense).
Dove però Testa sembra finalmente concedere, a sé e al lettore, un attimo di tregua dal fastidio per un presente a tratti assurdo, è nelle manifestazioni di quella che lo stesso definisce una personale forma di logofilia, intesa come “passione per le parole come modi per partecipare al mondo”, e come tale capace di garantire un argine al disprezzo diffuso (anche, e forse soprattutto, a livello istituzionale) per le possibilità espressive ed immaginative dello strumento linguistico.
Da qui, disseminati nel volume, ma addensati nel lungo capitolo centrale su La passione per le parole, una serie di godibilissimi “profili di parole” (nel solco di un padre nobile della disciplina come Bruno Migliorini): microsaggi di storia linguistica che, ad esempio, toccano l’ininterrotta fortuna moderna dei derivati in -crazia, -fobia e -oide (e che certo dicono qualcosa del nostro mondo, del suo sistema di pseudo-valori: è il caso di infocrazia, espressione di un’ideologia che riduce i processi di conoscenza al bombardamento ubiquo di dati e contenuti); o che, attraversando lingue e tradizioni differenti, aprono scorci preziosi sulla varietà di riferimenti letterari e antropologici tipicamente convocata da Testa nei suoi studi maggiori: eloquente la ricca digressione che dal savoiardo baban, passando per le lallazioni infantili, arriva alla genia dei tanti “barbari” o “babbei” letterari, in un tragitto che dalla novellistica toscana del ’500 arriva a Bartleby e a tanta parte del ’900 più comico; o, infine, le schede dedicate a certi sentimenti intraducibili, a tratti ineffabili, e alle loro marche etnico-linguistiche, come il portoghese saudade o il rumeno dor.
La lingua come strumento in grado di dare conto della nostra presenza al mondo, di riattivare cioè un contatto tra l’esperienza e una sua possibilità di trasmissione, si pone come il tratto comune di questo minimo vocabolario “vissuto” (giusta il riferimento al “modo vissuto del linguaggio” di Bally), dove ogni parola, bachtinianamente, non può che presentarsi alle labbra di chi parla, e nella penna di chi scrive, abitata dallo spettro di voci altrui.
A proposito. Tra le pagine più intense di Pronomi sembra inevitabile richiamare, per provare a concludere, anche i numerosi frammenti dedicati al genere lirico (di cui Testa, come già detto, è onorato studioso e frequentatore) e, in modo particolare, ai sedimenti rituali di cui tale genere letterario è da sempre depositario, e cioè il motivo del colloquio con i morti – nella ricerca, da parte di chi resta, e parla, di un altrimenti impossibile ricongiungimento con chi se n’è andato, scivolato nel silenzio dell’assenza. Diversi brani del capitolo Rammendare, cucire, intrecciare tornano infatti sul topos millenario del dialogo con l’assente, inteso come luogo testuale in cui provare a dare forma al sogno struggente di ritrovare chi non c’è più, chiudere e riaprire conti, ancora e ancora, e “incidere, insomma, il manto dell’oblio con le trame verbali del nostro desiderio”. Perché poi, se non mi sbaglio, un possibile modo di leggere questa raccolta di note di vita e di lettura è anche quello di intenderlo come un libro di fantasmi sui generis (a questo, del resto, mi fanno pensare le citazioni da uno dei più importanti autori di ghost stories della post-modernità, W. G. Sebald). Il simulacro vocale che gradualmente emerge e “prende corpo” dalla successione dei brani – specie quelli in corsivo, di taglio più intimo-confessionale – non solo lancia richiami verso le ombre del proprio passato; ma a sua volta, in rari momenti, sembra sfidare il silenzio della morte e il suo non-dicibile donando loro la voce, in una “comunità di parola” risuonante dall’altrove per eccellenza, solitamente muto a chi ancora vive.
In un panorama letterario in buona parte popolato da forme di autobiografismo ordinarie o semplicemente sciatte, per cui la scrittura è chiamata a trascrivere un vissuto e un’identità già dati, stabilmente definiti a priori, l’operazione frammentistica di Testa, senza pedanterie o tecnicismi inutili, intende piuttosto rimarcare la dimensione linguistica (in questo senso, fantasmatica) della nostra persona – di quel destino che ognuno di noi, purché accetti di “guardare al proprio principio come se appartenesse a un altro, come se fosse una narrazione che ci riguarda solo in parte”, può credere di riconoscere, a un certo punto, nel regesto delle affezioni che rendono tale un’esistenza.