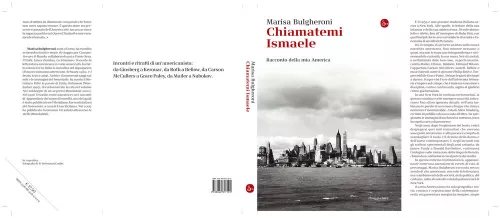Fiori di morte: Jack Kerouac a Milano
La grande americanista e traduttrice Marisa Bulgheroni raccoglie in Chiamatemi Ismaele. Racconto della mia America, in uscita presso il Saggiatore, i suoi incontri con gli scrittori che hanno fatto la storia della letteratura e della società americana dal secondo dopoguerra a oggi (da Norman Mailer a Harold Brodkey e Grace Paley, passando tra gli altri per Saul Bellow, Philip Roth, Allen Ginsberg, Vladimir Nabokov, Cynthia Ozick). Sono splendidi articoli e interviste pubblicati soprattutto a partire dal 1959 al 1991, integrati da ritratti e da ricordi inediti.

E così ecco il leggendario Jack Kerouac, che non sono riuscita a incontrare in America, che non avrei più creduto di poter incontrare, che, a sorpresa, sono invitata a presentare al pubblico milanese una sera del novembre 1966. Eccolo, spaesato e indomito, nella grande sala sotterranea della libreria Cavour gremita di ragazze e ragazzi in frenetica attesa, colorati, eleganti nei loro costosi stracci beat. Lui, lo scrittore marinaio che – «come Melville a New Bedford» un secolo prima – era arrivato a Boston nel giugno 1942 in cerca di lavoro, con la sua «sacca nera gonfia di classici stampati in caratteri minuti». E aveva trovato un ingaggio non a bordo di una baleniera, ma di una nave mercantile, la S.S. Dorchester, impegnata in missioni di guerra. Lui, il grande jazzista della parola che sa modulare il fiato mentale – e quasi il respiro della memoria – in frasi spezzate e riprese nell’improvvisazione di un attimo irripetibile. Lui, che, prima di scoprire il bop di Charlie Parker, è cresciuto, testardo, sui libri – Omero e Shakespeare, Joyce e Proust – ma ha completato la sua educazione di vagabondo nell’immenso spazio americano, su treni in corsa e macchine lanciate a pazza velocità.
Qualcosa di selvaggio, una ventata d’aria salmastra, isola la figura di Kerouac al centro del palco, tra i suoi interlocutori italiani. Barcolla quando si alza per stringermi la mano come se fosse sulla tolda di una nave, ma certo ha già bevuto troppo whisky. E sono io che gli ritaglio intorno uno sfondo oceanico nell’atmosfera psichedelica di luci incrociate della sala, io che incontro nei suoi occhi arrossati il tagliente colore dei mari nordici, e non «i fiori di morte» che lui vedeva negli occhi dei suoi compagni in partenza sulla S.S. Dorchester. Non immagino, io, che a volte ho intuizioni di strega, che questo, in Italia, sarà il suo ultimo viaggio.
Kerouac è qui controvoglia. Ha lasciato la madre paralizzata da un ictus, sepolta sotto un macigno di silenzio: «mémère», la stella fissa del suo intermittente orizzonte domestico. Più che mai questa sera corrisponde al ritratto che di lui ha dato John Clellon Holmes: «Diffidente come un coyote su una pista e intrattabile come un cavallo che rifiuta la sella». È partito in guerra con se stesso, e ora, sul campo, scalpita, beve, si prepara allo scontro con il pubblico. Quei giovani, forse appassionati, ma inconsapevoli, si illudono di incontrare l’inventore della beat generation di cui si sentono parte oggi, nel 1966, senza sospettare che lui ne negherà l’esistenza: «Nessuna generazione è nuova… tutto è vanità…». Ignorano la rabbia profetica che gli farà scrivere: «Ci si ammazza per arrivare alla tomba prima di essere morti, e il nome di quella tomba è successo, tumulto, frastuono e merda pura…».
Una frattura cronologica ha spezzato la carriera di Kerouac: Sulla strada, scritto nel 1951, pubblicato nel 1957, è il libro al quale la critica l’ha inchiodato in un’equivoca eternità. E in quelle pagine aveva dichiarato: «Per me esistono solo i pazzi, pazzi di vivere, pazzi di parlare, pazzi di essere salvati, quelli che desiderano tutto simultaneamente, che non sbadigliano mai, mai dicono un luogo comune, ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio…». E allora: che la serata incominci, che si accendano falò di parole, e il «santo pagliaccio» – come si è definito lui stesso – reciterà la sua parte…
Per presentarlo Alberto Mondadori ha scelto due grandi eccentrici della Milano anni sessanta: Luciano Bianciardi, geniale e anarchico autore della Vita agra, come Kerouac insofferente di un successo che lo inquieta, e Mario Spinella, sapiente e dolcissimo, i capelli grigi raccolti in un codino da indiano di una qualche perduta tribù metropolitana. Bianciardi confessa di aver tradotto I sotterranei in un duro corpo a corpo con una lingua di cui tentava di rendere i ritmi jazz in un italiano funambolico. Soltanto dopo si è ritrovato quella musica nella testa e ha riconosciuto in Kerouac un maestro. Spinella, freudiano, è attratto dal tema della ricerca dei padri perduti nello spaziotempo della narrativa di Kerouac, intravisti «nella tetra fioca luce rossa dei tramonti d’America».

E ora la parola passa a me che, come Kerouac, arrivo dalla morte – perché nella sua stanza oscurata, a Como, mia madre ha ormai poco tempo, e ogni suo minuto è prezioso. Ma la letteratura può essere una strana passione e, avendo anch’io tradotto Kerouac, mi sento legata a lui da un diritto/dovere poetico, inesplicabile come un amore, e sono qui… Mentre mi avventuro a definire la sua «prosa spontanea», voci dal pubblico gridano: «Nanda! Nanda!»; ma io, stranamente assorta come se camminassi su una lastra di ghiaccio sottile, non mi interrompo. Non penso sia – come lo è – una protesta (perché Fernanda Pivano, per qualche alchimia che mi è ignota, è stata esclusa dalla serata). Immagino che quel nome sia un marchio malizioso: qualcuno mi giudica più suggestiva e descrittiva che rigorosamente critica. E allora continuo, imprimendo al mio discorso una decisiva svolta semiologica, e la raffica di termini tecnici zittisce i disturbatori. Poi intuisco il mio errore nel sorriso di Alberto Mondadori, nel suo «Brava! Ce l’hai fatta!», nel sollievo di Domenico Porzio, che mi applaude, convinto.
Ma già Kerouac, il bicchiere di whisky saldamente in una mano, sta rispondendo alle domande del pubblico con un’infinita pazienza rotta da scatti d’ira, ammiccamenti, risate. Ha bevuto e beve, ma è uno scrittore e non se lo dimentica mai. Non si è mai sentito vivo se non scrivendo; e ha scritto vivendo, in corsa. «Sì» dice «le mie storie sono vere, cambio soltanto qualche nome, qualche luogo. Cerco di raccontare la vera storia di ciò che ho visto e di come l’ho visto. Credo che con il monologo interiore si possa raccontare la vera storia dell’America, del mondo.»
Parla, a tratti, il francese antico dei suoi leggendari avi bretoni emigrati in Canada. «Sì» dice «credo negli angeli in terra, credo in Dio, quando sto bene. Se sto male bestemmio Lui e tutti i santi. Sono cattolico. Sono anche, in parte, indiano: per questo mi sento a casa dappertutto in America. No, non ho bisogno dell’LSD, non c’è niente di meglio del whisky.» Sa che non è vero. In Big Sur si è rappresentato come un Thoreau negativo: incapace di ubriacarsi d’aria, condannato a popolare dei propri incubi di alcolizzato i boschi, il cielo, l’oceano, di cui registra disperatamente la musica notturna. Ma qui, a Milano, è costretto a rispondere a domande che non lo toccano più, e le liquida con brevi battute, o divaga e canticchia sull’orlo del crollo.

Che cosa pensa di Lyndon Johnson? «È un ipocrita! È soltanto un ipocrita!» E del movimento per la pace? «L’ha inventato Tolstoj. Gandhi l’ha copiato…» Della guerra in Vietnam? «Sono con i soldati di tutte e due le parti.» Le piace Jackson Pollock? «Certo! Disegna molto meglio di me. E una volta ci siamo ubriacati, io e lui, insieme.» Finché arriva l’odiata domanda che forse non si aspettava più: «Quanto ha contribuito il suo talento pubblicitario a creare il personaggio Kerouac?». Nella sala cala un innaturale silenzio. Kerouac è uno straordinario inventore di slogan, di titoli di libri, di definizioni memorabili. Lui ha dato il nome alla beat generation e ne ha illustrato il duplice significato di «battuta» e «beata». Ma non per questo vuole essere ricordato. Si avventa sul microfono, lo scuote come se fosse una sbarra della gabbia in cui si sente imprigionato. «La pubblicità» dice «non è il mio mestiere. Il mio mestiere è scrivere, nuotare nel mare della lingua. Sono venuto qui perché il mio editore mi ha offerto ottocento dollari, e lo ringrazio per questo. Ma non sono abituato a tanta attenzione. In America mi danno del dumb, del cretino, mi trattano come un “santo imbecille”… In America…» E improvvisa, dal testo di Visioni di Cody: «“L’America è ricercata dalla polizia, inseguita attraverso / il Kentucky e l’Ohio, dorme coi topi della stalla e / geme tra le lamiere di cupi silos remoti / … è l’impersonale tempo notturno ai crocicchi, agli incroci dove / ognuno guarda da una parte e dall’altra, da quattro parti…” È lì che ho vissuto, che ho imparato a scrivere nel mio gergo: “nel linguaggio della corrente del fiume dei suoni, parole, buio, che portano al futuro e testimoniano della pazzia, della vuotaggine, del casino della mia mente, che, benedetta o imbenedetta, sta dove cantano gli alberi…”». Ha citato, di nuovo, se stesso – un passaggio dei Sotterranei – a occhi chiusi, potrebbe addormentarsi.
Lo scuote un’ultima domanda: un americano tra il pubblico vuole conoscere i suoi progetti per il futuro. E lui, stremato, si alza in piedi, indica con un vago gesto giocoso la lampo dei jeans, ma Domenico Porzio lo prende sottobraccio e lo guida verso l’uscita tra un ultimo scroscio di applausi. Fuori, sotto un arco di manzoniano cielo stellato, i beatniks milanesi gli si stringono intorno in un gioioso assalto: vogliono toccarlo, assicurarsi che esista, prima che scompaia tra le pagine dei suoi libri. Nessuno vede nei suoi «stanchi occhi marini» i fiori della morte. Kerouac non ritornerà in Italia. Morirà tre anni dopo, distrutto dall’alcol. La serata milanese sprofonderà rapidamente nelle cronache.
Il 24 ottobre 1969, prima che la bara di Kerouac venga ricoperta di terra, nel cimitero di Lowell, in Massachusetts, dove è nato, Allen Ginsberg vi lascia cadere una rosa. Lo racconta Ann Charters nella sua biografia, e io mi sono chiesta perché. Perché una rosa? Forse Ginsberg ricorda una frase che, rileggendo Sulla strada incanta anche me: «Se getti una rosa nel fiume Hudson, alle sue misteriose sorgenti negli Adirondack, pensa a tutti i luoghi che costeggerà nell’eterno scorrere dell’acqua verso il mare…». Oggi – riflettendo sull’omologazione delle singole letterature di Occidente e d’Oriente, levigate da un rapido editing globale – mi sembra che il vero viaggio di Kerouac sia stato simile a questo: una corsa imprevedibile, non sulla strada, ma nel flusso infinitamente mutevole della lingua americana, che Kerouac amava di una passione quasi fisica, nella quale lasciava una traccia corporea come il fiato caldo del trombettista.