Speciale
Pievani e Remuzzi: siamo ibridi e migranti
Tra il gennaio 2021 e il giugno 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con il governo cinese, ha aggiornato più volte il dossier sullo sviluppo della pandemia da SARS-CoV-2. Le indagini convergono oramai nell’individuare a Wuhan, e più precisamente tra le bancarelle del mercato di Huanan, l’epicentro del virus Covid-19: è dunque evidente come la cronaca medica, tramite strumenti sempre più meticolosi, risulti perfettamente in grado di chiarire i contorni del come e del dove della catena epidemiologica iniziale. D’altro canto, confinata nella propria autonomia disciplinare, essa non pare capace di offrire una risposta altrettanto risoluta alla questione genealogica del suo perché (che pure riveste un’importanza decisiva anche in ambito medico, in ottica preventiva): quali sono le cause concomitanti che hanno reso possibile – o necessario – un certo evento pandemico globale piuttosto che un altro? Al contrario, nel confronto con la biologia evolutiva – là dove il presente biologico si lascia interrogare attraverso i sedimenti genetici del passato – la clinica può intravedere uno spiraglio teorico ulteriore per formulare un’ipotesi ardita ma feconda. Le vere origini del Covid-19, suggeriscono alcuni studiosi, non andrebbero ricercate unicamente in Cina, ma nelle viscere delle grotte abitate decine di millenni fa dai Neanderthal: lì avrebbero vissuto i primi, inconsapevoli, “pazienti zero”.
La spiegazione attinge alle conoscenze in nostro possesso dei rapporti tra la nostra specie – l’homo sapiens – e i Neanderthal; del resto, è dimostrato dalla ricerca che tra queste due “umanità” si siano verificate numerose ibridazioni capaci di lasciare impronte durature nel “nostro” genoma, con effetti ambivalenti: da un lato, esse hanno fortificato la nostra specie, dotandola di strumenti immunitari nuovi e resistenti; dall’altro, hanno reso alcuni individui più esposti, altri tendenzialmente immuni, a certe malattie virali come il Covid-19. In questa cornice, la fragilità dell’umano esposto al contagio non risulta più un mero accidente descrivibile in termini osservativi, ma un segno inequivocabile della sua genealogia ibrida. Oltrepassando i confini dell’ambito medico, l’indagine medico-genealogica del Covid-19, condotta secondo una prospettiva evoluzionistica, dischiude per ciò stesso orizzonti che travalicano la biologia, lambendo territori ben più vasti: l’antropologia, l’etologia, l’ontologia. Ciò che ne emerge è una figura dell’umano profondamente decentrata rispetto ai modelli di purezza originaria o autonomia assoluta, configurandosi come il frutto di una lunga genealogia di incroci, trasfusioni, coabitazioni genetiche con altre specie ominidi.
Questa, almeno, la prospettiva che guida il saggio Dove comincia l’uomo. Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana, firmato da Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi per i tipi di Solferino (Milano 2025). Una tesi netta, espressa sin dal titolo in forma di domanda indiretta: dove ha avuto inizio l’essere umano? Esiste un “inizio” nel senso tradizionale? La risposta è radicalmente negativa. L’essere umano non comincia nel senso in cui comincia una storia, ma si definisce, ab origine, come l’esito transitorio di un’evoluzione aperta e frammentata; l’umanità corrisponde a un’ipostasi contingente, all’espressione specifica e storicamente determinata di un processo biologico più vasto e non lineare (solo per comodità definibile “evoluzione”), che ha compreso la contaminazione tra diverse specie: «Per noi oggi è quasi impossibile immaginare un essere umano ibrido, ma in passato fu per lungo tempo la norma» (p. 7). Occorre ripensare, su queste basi, l’essere umano come realtà strutturalmente indefinita, precaria, sempre in divenire, sempre sull’orlo di un cambiamento possibile, se non necessario. Nessuna chiusura pessimistica, né una condanna al caos evolutivo o al relativismo biologico: è nella transitorietà costitutiva della nostra specie che viene intravista da Pievani e Remuzzi una possibilità definitoria dell’essere umano. L’apertura all’ibridazione e alla contaminazione diventa cifra dell’esistenza dei sapiens, per cui essere vulnerabili significa stare al mondo. Da qui, peraltro, la stessa indicazione della naturalità delle migrazioni umane, intese come contaminazioni necessarie con l’ambiente: «Viviamo su un pianeta instabile e migrare è l’adattamento più efficace per cavarsela» (p. 11). L’antropocentrismo tradizionale – insieme alle sue derive discriminatorie razziali – viene in questa maniera messo in discussione, e finalmente rovesciato: non vi è umano – nessun tipo di umano – che sia al centro (sociale o geografico) di alcunché, poiché ogni individuo sapiens appare interamente iscritto entro un quadro che lo trascende. Il medesimo titolo scelto da Pievani e Remuzzi, Dove comincia l’uomo, diviene così sintomo di un semplice dispositivo dialettico: il termine “uomo” (non “umano”) non denota un punto di partenza, ma corrisponde all’artificio linguistico che, nel corso delle cinque sezioni del testo, viene usato e al contempo smascherato, decostruito; l’“uomo” (declinato al maschile, come ipostasi dell’umano) viene proiettato in un orizzonte ecologico di cui ignora l’origine e non detiene il controllo, ma che gli impone una rimodulazione del suo rapporto con altri umani e con la natura intera (cfr. Ibid.).
Il saggio si apre dunque con un’indagine sulle origini dei sapiens (I. Tempo profondo) che, fin dalla loro comparsa, si sono manifestati come enti, per così dire, in relazione: l’umano non è nato solo, né da solo. La sua esistenza si è immediatamente intrecciata con quella di altri ominidi, in un contesto evolutivo corale che ha messo in discussione ogni pretesa di unicità: occorre «paragonare l’evoluzione a una sorta di bricolage che può soccorrere gli organismi in modo tale che si adattino alle circostanze attuali» (p. 44). Nel corso della storia evolutiva, anche per effetto di sollecitazioni ambientali, si sono in effetti verificate le condizioni che hanno reso necessarie le migrazioni a cui risalgono la compresenza tra specie ominidi diverse e la successiva coesistenza – esaminata nel dettaglio nella seconda sezione (II. Molti modi di essere umani) – tra sapiens e altre specie affini, come i Neanderthal, i Denisova e due forme di homo pigmeo rinvenute in Asia; essa ha dato adito a incontri niente affatto episodici: «Non solo […] tra noi e i Neanderthal, ma le ibridazioni tra specie umane furono molteplici […] C’è stata convivenza, interazione, intimità, durante almeno 200.000 anni, ma forse anche di più» (pp. 67 e 73).
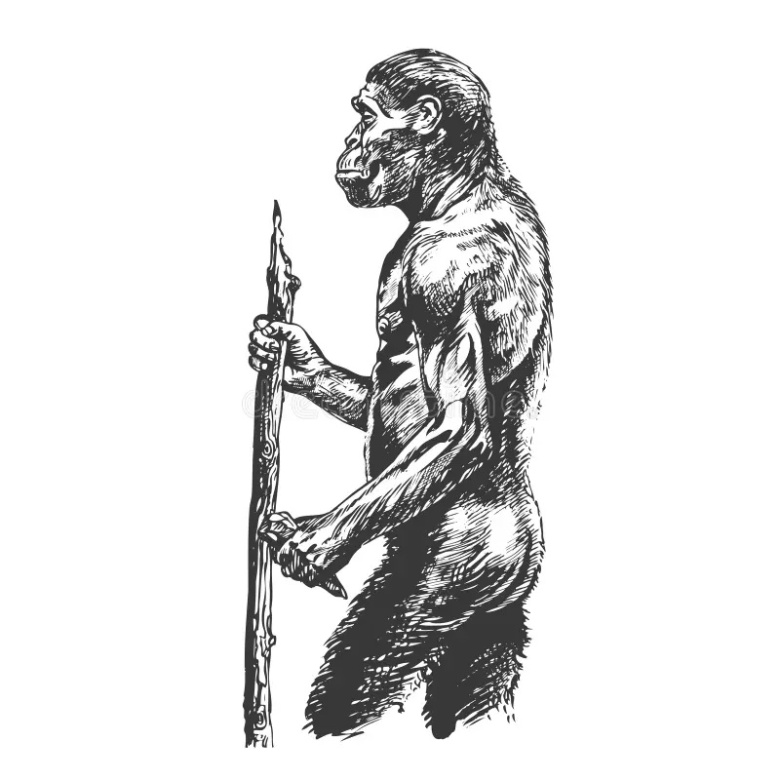
Alla luce di questi rapporti, la terza sezione (III. Ibridarsi fa bene e male) di Dove comincia l’uomo può analizzare solidamente l’attuale corredo genetico umano, rivelandone la natura tutt’altro che monolitica. I dati dell’indagine biologica molecolare e genomica mostrano come l’homo sapiens contemporaneo custodisca, nel proprio Dna, tracce inconfondibili delle interazioni passate: il suo codice genetico è un archivio sedimentato in cui sopravvivono le vestigia di funzioni perdute ma non cancellate e potenzialmente riattivabili: «I genomi sono barocchi», ché sovradeterminati da un processo di “esaptazione”, di «riuso opportunistico di strutture (genetiche e fenotipiche) evolutesi per tutt’altre ragioni, o come effetto collaterale di altri processi evolutivi» (p. 33). Simili pleonasmi non sono errori, ma segni muti di una memoria che racconta precisamente la nostra intricata storia evolutiva. Essa rende ragione dell’eredità genetica maturata a contatto con altre specie umane che ha «avuto un ruolo fondamentale nella nostra capacità di adattarci all’ambiente e [l’ha] ancora oggi, nella nostra vita di tutti i giorni» (p. 75): per esempio, la contaminazione con i Neanderthal ha reso possibile lo sviluppo di geni che, in passato, hanno potuto «proteggere chi ne era portatore da tante malattie» (p. 110); per converso, tale ibridazione ha avuto effetti ulteriori a livello genetico favorendo, almeno in alcuni individui, l’esposizione ad altri virus, come il Covid-19, ma consentendone altresì, progressivamente, la neutralizzazione: «L’aplotipo che oggi ti fa morire di Covid, migliaia di anni fa proteggeva da altri patogeni» (p. 117). Come dire che «il sistema immune ci protegge e ci condanna allo stesso modo, servendosi di geni che vengono “dalla notte dei tempi”» (p. 118). Ecco allora che l’identità dell’essere umano definita dall’esposizione alle malattie, si configura come il risultato dinamico e precario di una stratificazione di alterità; ciò che siamo coincide, in gran parte, con ciò che abbiamo incorporato: «Pensavamo, noi umani, di essere al centro dell’universo […]. E invece no». Siamo l’anello (provvisoriamente conclusivo) di una storia millenaria, al cui interno ci «sono anche i virus» a cui siamo esposti e che ci definiscono in base a gradi di ibridazione tra ominidi (p. 97).
A dire il vero, proprio quando il testo lascia intravedere l’estensione e la profondità della nostra parentela evolutiva, un interrogativo – per certi versi inquietante – si impone con forza dirompente: se l’umanità ha convissuto così a lungo con altre specie, perché oggi i sapiens si ritrovano da soli? La questione non ha una sola risposta. Alcune interpretazioni richiamano i cambiamenti climatici che hanno inciso sull’ambiente in maniera rapida e brutale, favorendo mutazioni cognitive nei sapiens che li hanno resi più reattivi, più adattabili, più capaci di manipolare l’ecosistema. In questa trasformazione, la loro capacità tecnica e simbolica avrebbe conosciuto un’accelerazione decisiva: strumenti, linguaggi e reti sociali più complessi. Il sapiens si sarebbe fatto “maître et possesseur” del globo, assumendo – e autogiustificando – la propria centralità operativa e contribuendo a mutare gli equilibri tra specie, talvolta in modo irreversibile: «Dove arriva l’uomo un poco alla volta gli altri scompaiono» (p. 78). Nondimeno, sarebbe riduttivo, o persino anacronistico, immaginare un’esplosione violenta, un genocidio preistorico: mancano prove archeologiche di conflitti diretti e diffusi tra ominidi. Potrebbe quindi trattarsi di uno sviluppo invasivo ma indiretto, oppure di un’integrazione lenta, per progressivo assorbimento, definita «introgressione adattativa» (p. 69): un cosiddetto «assimilation model», a indicazione del lento assorbimento della popolazione di Neanderthal in quella dell’uomo moderno» (p. 78).
In ogni caso, è proprio l’istanza della singolarità – forse contraddittoria, forse inesistente – risultante da questa fusione a definire la specificità dell’homo sapiens, come suggeriscono Pievani e Remuzzi (IV. Quando siamo diventati sapiens?): l’essere umano non si è distinto per un’originaria purezza, ma perché radicalmente ibrido. La sua presunta unicità risiede cioè nella sua peculiare capacità di assorbire e trasformare l’altro, di fare proprie – per assimilazione tanto biologica quanto culturale – le caratteristiche di specie diverse: «L’umanità è una condizione precaria, in fieri, che si raggiunge insieme agli altri» (p. 193). Occorre pertanto ammettere che «l’unicità umana si assottiglia sempre di più» (p. 190).
All’interno di questa trama di assimilazioni e convivenze dissolte prende peraltro forma l’ultima sezione del volume (V. Futuro sapiens?). Qui Pievani e Remuzzi non cercano di mascherare la drammaticità dello scenario attuale, ma delineano una traiettoria possibile per l’homo sapiens che, lungi dall’essere lineare o trionfale, passa attraverso la consapevolezza della propria ambivalenza costitutiva. L’essere umano appare, in base a caratteri (culturali e fisiologici) che saranno in futuro sempre più marcati, come una creatura instabile, portatrice di una doppia tendenza: da un lato la spinta trasformativa che lo ha reso capace di plasmare l’ambiente, dall’altro, la responsabilità oggettiva delle deformazioni che ha causato. L’homo sapiens – che pure, «forse, non è mai stato sostenibil[e]» (p. 23) – non viene infatti banalmente condannato alla (auto-)distruzione, ma messo di fronte alla propria capacità di mutazione. Laddove la crescita dell’umano procede in modo dissonante rispetto alla sopravvivenza del pianeta, appare imprescindibile una rivoluzione non solo tecnologica, ma soprattutto ecologica e sociale: una metanoia della sensibilità, dell’agire etico, un sovvertimento della concezione stessa del rapporto tra specie e habitat che lasci emergere una «coscienza di specie», una «visione pan-specifica» che ci consenta di riconoscere «quanto siamo interconnessi» (p. 218). Un cambiamento che abbia altresì un impatto economico-sociale, ché «in un mondo dilaniato da diseguaglianze feroci, abbiamo un grande bisogno di questa efficacia solidale, per diffondere più bene possibile in cerchi morali sempre più ampi (non solo dentro la nostra tribù» (p. 152). Sogno romantico – e quantomai antropomorfo – di miglioramento dell’umanità? Niente affatto. La lente evolutiva offre una chiave di lettura ancora una volta illuminante e scevra da moralismi. Proprio perché la selezione naturale ha favorito, nei sapiens, forme di cooperazione, empatia, altruismo – anche se in misura variabile – tali tratti possono diventare non solo desiderabili in quanto edificanti, ma perché necessari alla sopravvivenza della specie. È una forma di «interdipendenza» che sancisce che «a volte i singoli organismi dipendono l’uno dall’altro per affrontare le sfide ambientali e si forniscono “aiuto reciproco”» (p. 200): evoluzionisticamente, l’altruismo non definisce un valore astrattamente morale, ma un vantaggio adattivo, una «forma indiretta di egoismo genetico» (p. 148), una risorsa selezionata nel corso della storia naturale che oggi può costituire un punto di forza per affrontare le crisi ambientali, sociali e biologiche; un istinto tipicamente animale – e non per questo meno nobile – che ci consenta di coabitare con la natura che pure deprediamo in funzione delle nostre “nicchie” (cfr. p. 256).
Ebbene, è ponendo questa sfida che le riflessioni esposte in Dove comincia l’uomo si impongono come un esercizio di genealogia medico-evoluzionistica radicale dell’umano, un’indagine delle origini che non si limita a spiegare da dove veniamo, ma che si sforza di dire chi siamo, mettendo in discussione molti dei miti ancora attivi nell’immaginario dell’antropocene. Lo fa a partire dal mito dell’eccezionalismo umano, quello che pretende che la nostra specie sia un fine dell’evoluzione, un culmine irraggiungibile da altre specie. In quest’ottica, Pievani e Remuzzi prospettano anche un’accettazione più o meno naturalizzata dei processi migratori, che rappresentano un “fatto naturale”: dai nostri albori genetici, in cui umani diversi si spostavano e si ibridavano, «tutti noi siamo figli di migranti», gruppi di ominidi nomadi pronti a lasciare «le proprie terre per via del clima divenuto sfavorevole oppure per conflitti» (p. 207). Contro ogni autocelebrazione umana (dell’uomo o di un certo uomo) mascherata da verità biologica, Pievani e Remuzzi ricordano che «la storia dei mammiferi non è stata un’inevitabile marcia di incoronazione dell’umanità» (p. 439) e, a fortiori, di una certa sua declinazione fenotipica, di genere o orientamento. Oggi più che mai, occorre tenere a mente questa lezione: la solidarietà e il sostegno reciproco diventano un vero e proprio dovere evolutivo al di là di ogni privilegio ontologico.
Telmo Pievani aprirà l’edizione di Scarabocchi 2025 il 12 settembre a Novare.
Qui tutte le informazioni.







