Tommaso Pincio. Il dono di saper vivere
«[…] sicché l’immagine di uomo sbagliato e maledetto, incapace di convivere con i suoi simili senza ficcarsi in un qualche pasticcio, si è tramandata nei secoli, fino alla metà del Novecento, quando Bernard Berenson, insigne studioso, scrisse un breve quanto non benevolo saggio su di lui nel quale si dice che, tra i molti doni che aveva, gli mancava quello di saper vivere.»
Lui è Caravaggio, chi parla è il protagonista che una frase più avanti dichiarerà di essersi domandato per tutta la vita se difettava anch’egli del dono di saper vivere. Per il Gran Balordo si trattava di una macchia in un mare di talenti mentre per il narratore la sua è una macchia in un mare di macchie.
Chi è il narratore? Il protagonista di Il dono di saper vivere di Tommaso Pincio (Einaudi, 2018) è un uomo in carcere che racconta la sua vita, la sua disfatta. Ci dice di trovarsi in prigione per un omicidio che non ha commesso (ma non dicono tutti così?), mentre racconta, si domanda e ci domanda se esista qualcuno che possegga il dono di saper vivere, dono che mancava anche a Caravaggio, il pittore da cui è ossessionato. La domanda è quella di tutti noi, quesito che almeno per una volta ci siamo posti. Pincio comincia il suo romanzo così, e piano piano sostituirà il carcerato con se stesso, senza fare trucchi e dichiarandolo apertamente. Se parliamo di un condannato meglio dire di uno che conosciamo bene.
«[...] adoravo immensamente lo sfacelo, mi ci sentivo a casa. Trovavo che pure le opere non potessero desiderare una collocazione migliore. Era come abitare in un eterno novembre, uno di quei giorni di luce livida, quando tutto è stanco e non c'è cosa che non paia avviata al tramonto, sul punto d'accasciarsi al suolo. In quel museo d'autunno, le opere d'arte, imperturbate e imperiture, che fossero statue o dipinti, mantenevano la posizione eretta, restavano verticali. Assumevano la regalità dura di una lapide, un monolite sceso dallo spazio per sorvegliare il sonno di un popolo imbarbarito. Insomma ai miei occhi di giovinastro immalinconito e scontroso, l'arte sembrava più bella, più artistica, in quel luogo cadente.»
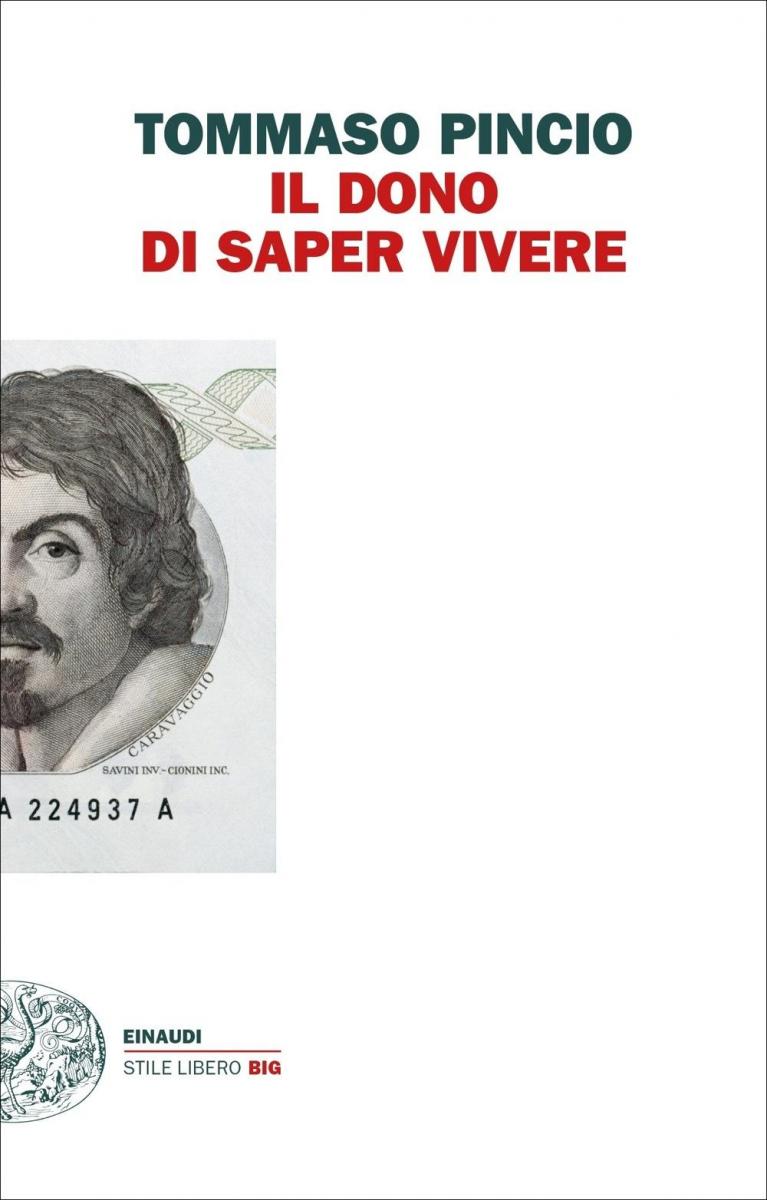
Il libro è una sola grande domanda che attraversa una storia fatta di malinconia e tormenti, di conoscenza dell’arte e di timori, di fallimentari imprese e di opere d’arte. Tommaso Pincio non scrive un’autobiografia, non scrive un romanzo, non scrive un libro su Caravaggio. Scrive, però, come se dipingesse due ritratti, quello dell’artista e il proprio. Due ritratti chiari e sfuggenti, che come in un inseguimento ogni tanto si trovano uno di fronte all’altro. Ci specchiamo nelle nostre fissazioni? Di certo ce le portiamo dietro. Pincio, la sua, la porta addosso da quando lavorava in una galleria d’arte situata nella stessa via in cui Caravaggio uccise.
«E cos’è che più conta in un filo spinato: che è un filo o che è spinato?»
I libri che preferisco sono quelli che mi rimandano ad altri libri, che mi riportano alla mente immagini a cui in qualche maniera sono legato, o altre che mi assillano. Mi piace il testo che si fa mappa e che vada a inserirsi in altre trame, dentro ad altri racconti, che mi riconduca davanti a un quadro o a una fotografia che ho amato, che mi ricollochi in altri momenti della mia vita, che mi afferri per mano con la forza di una domanda, con l’apertura di una poesia riuscita. Molte di queste cose sono accadute tra le pagine di Il dono di saper vivere, alcune fin dai primi capitoli.
Ci sono alcuni versi di Iosif Brodskji che rimbalzano a ogni pagina, versi che dicono di un doppio restituito dall’acqua di Venezia e allo stesso tempo annullato, reso inutile. I versi (tratti da Poesie italiane, Adelphi, traduzione di G. Buttafava e di S. Vitale) sono questi:
La notte, moltiplicata dal mare per due, non dà
folla di zeri, cioè folla di uomini,
anche se i loro volti, a dir la verità,
più bianchi si fanno.
Il doppio incantato e senza fine creato a Venezia dall’acqua dei canali, i palazzi e i volti che in quell'acqua si specchiano, si confondono, si muovono e poi spariscono; in particolare, la capacita di evocare quel doppio e la sua contemporanea assenza – o meglio, la sua inutilità al cospetto dell’acqua – in modo magistrale dal poeta russo; il confronto inevitabile con la nostra immagine allo specchio, confronto che siamo destinati a perdere, mi ha tenuto compagnia mentre leggevo di altri giochi di specchi, di altre spiegazioni di immagini, di altri uomini che si misuravano come in un riflesso, per un’ossessione, quella tra il protagonista del romanzo di Pincio e Michelangelo da Caravaggio.
La scrittura di Pincio è piacevole e colta come sempre e la sua capacità d’invenzione abita un romanzo che si basa su molti fatti storici e gli permette di raccontare di una lite tra vicini di casa e di Caravaggio che non paga l'affitto, di citare critici d’arte, e quadri che ci lasciano, ogni volta che li guardiamo, a bocca aperta. I quadri di Caravaggio non danno risposta, così come non saprei dire se la sua incapacità di vivere fosse null’altro che il talento principale, la furibonda mano che doveva far rissa e dipingere, perché entrambe le cose erano la stessa. Facciamo avanti e indietro tra San Luigi dei Francesi e Villa Borghese, tra La vocazione di San Matteo (qual è realmente Matteo?) e la faccia di Caravaggio stampata sulla banconota da centomila lire.
Pincio parla di occhio, di visioni, di fotografia, di percezione, di capacità di trovare sempre qualcosa di nuovo in un dipinto, di incapacità di osservare qualcosa che non sia quella che si sta cercando. Il viaggio nella vita e nei quadri di Caravaggio è un piccolo gioiello letterario ed è un giro sopra ciò che siamo, ciò che più temiamo. Quasi sempre siamo il nostro peggior nemico. Più che la nostra figura allo specchio, siamo quella ribaltata nei quadri di Caravaggio.
C’è un passaggio del libro che mi è rimasto impresso, in cui Pincio cita David Hockney quando afferma: «Le figure di Caravaggio non guardano mai dove ti aspetti». A me pare che Caravaggio ne sapesse molto di specchi e di persone, mi pare che sapesse il necessario. Pincio prosegue: «Che vuol dire? Dove dovrebbe guardare il giovane della Buona ventura se non al volto malioso della zingara che lo sta ingannando? Dove altro dovrebbe puntare gli occhi San Tommaso se non sulla ferita in cui ha infilato un dito? Dovessimo fermarci al dove, le figure di Caravaggio guardano quasi sempre quel che è ragionevole guardare, e tuttavia la frase di Hockney conserva una sua verità perché qualcosa di peculiare nello sguardo di questa figure c’è, qualcosa che concerne più il come che il dove.»
Qual è dunque il nostro come? Stabilito quello, se ne siamo capaci, il dove diventa una conseguenza ed è comunque meno importante.
Se, come afferma Pincio, quando ci osserviamo allo specchio scambiamo il nostro riflesso per uno sconosciuto, è vero anche che non riusciamo a evitare di cercarlo quel riflesso, di qualunque cosa si tratti.
Poche ore dopo aver finito di leggere Il dono di saper vivere ho visto a Milano la mostra della fotografa Sarah Moon “Time at work”, sono rimasto fermo almeno dieci minuti davanti a una foto “Les jumeaux”. Sarah Moon ritrae due gemelle una di fianco all’altra, eppure, mentre questi quattro occhi ti guardano, tu non puoi fare a meno di pensare che ognuna delle gemelle stia guardando l’altra, e che l’altra non esista se non in un riflesso. Suggestione? Probabilmente, ma anche la peculiarità di un libro riuscito che ti porta a fare dei ragionamenti e a guardare te stesso ovunque ci sia qualcosa da vedere.







