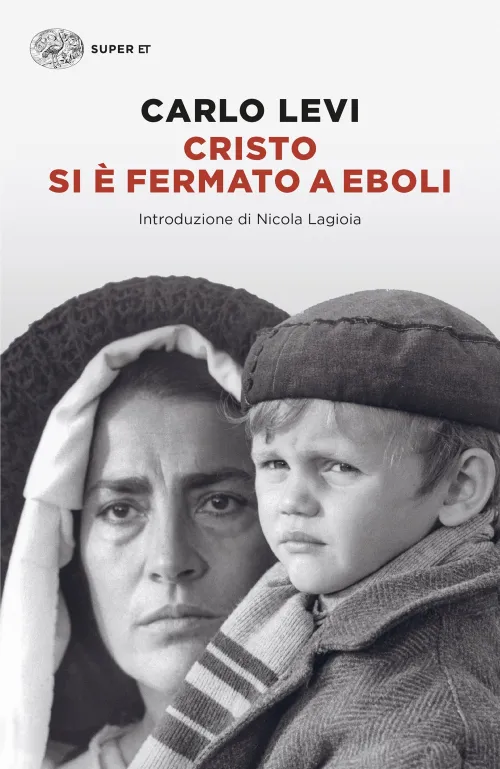Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli
Di fronte all’attuale volgarizzamento della questione meridionale, con tutto il carico di estetizzazione del Sud che esso si porta dietro, la rilettura, a ottant’anni dalla sua prima pubblicazione, di un grande classico come Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi produce uno strano effetto. Le accuse di paternalismo o di cedimento al registro del “pittoresco”, che nutrirono variamente l’enorme dibattito sorto all’indomani dell’uscita e che rivelarono senza dubbio una serie di criticità da discutere, si stemperano quasi completamente in ragione di un dato che riguarda la nostra particolare condizione di “spettatori” odierni del Meridione: il Cristo di Levi – a prescindere dal supposto populismo estetico che, per i detrattori, lo definirebbe o dalla più evidente sensibilità antropologica che, per i sostenitori, ne delineerebbe i contorni – è un romanzo in tutto e per tutto politico. E politicamente andrebbe letto, riletto e giudicato, se non fossimo diventati, in materia di Meridione e non solo, del tutto indifferenti alle questioni appunto politiche che ineriscono alla rappresentazione delle “masse popolari subalterne” (per dirla con Ernesto de Martino) o delle classi sociali oppresse, o più in generale alla funzione non solo artistica della letteratura. Si ha persino il sospetto che le accese discussioni sul Cristo – dietro le quali scorgere, ad esempio, i dissidi, nell’immediato Dopoguerra, tra socialisti e comunisti a proposito delle lotte contadine per la terra e dell’autodeterminazione politica delle realtà agricole – possano trattenersi, prive di qualsivoglia valore conoscitivo, sullo sfondo di una storia ormai lontana nel tempo, al limite esperibile nell’artificioso (e postmoderno) mercato della nostalgia e del passatismo. Se questa distanza producesse un’interrogazione critica sul rapporto tra quel tempo e il nostro presente, non ci sarebbe nulla di male: tutt’altro. Ma sembra evidente che il nostro modo di leggere le vicende del meridionalismo, all’interno delle quali il Cristo leviano appare come un luogo fondativo, le traduca immediatamente e inevitabilmente su un piano soltanto estetico o culturale, con la conseguenza impolitica di trascinarle verso una dimensione libresca o evasiva.
Come ha ricordato uno dei migliori studiosi di Levi, Riccardo Gasperina Geroni, nella postfazione alla recente (2025) ristampa einaudiana del romanzo (che però, è bene ricordarlo, comparve nel 1945 tra i «Saggi»), Cristo si è fermato a Eboli si impose subito come caso letterario, sollecitando l’attenzione massima di critici e lettori non solo italiani. Non si può prescindere dalla considerazione dell’effetto dirompente che il libro di Levi ebbe nel contesto di un’Italia appena libera dal fascismo e volta all’edificazione di un ordine democratico. Nella sua prosa lirica ma sempre attenta al dato di realtà, il Cristo offrì la grammatica con la quale disvelare, sotto la spinta valoriale della Resistenza, una porzione di umanità in sostanza ignota, o eventualmente conosciuta attraverso i filtri esclusivistici delle élites liberali o, nel caso peggiore, gli orrori di certo positivismo razzistico. Mediante le pagine di Levi, del confinato Carlo che approda a Gagliano (nome poetico di Aliano) nel 1935, il Paese scopriva se stesso fuori della retorica rurale e tronfia del regime, e lo faceva con un romanzo che inscenava, da subito, una catabasi politica senza sconti e che, proprio in ossequio a tale discesa, optava per la dismissione problematica del corredo culturale del suo narratore, al fine di capire l’alterità più distante, di incontrarla, di ricomprenderla nella coscienza storica, mettendola in dialogo con l’insopprimibile identità borghese dell’autore.
Da questo punto di vista, come è stato detto da più parti, il Cristo costituisce uno straordinario documento etnografico delle realtà meridionali oltre il confine simbolico di Eboli e fonda, in una certa misura, la tradizione, non ancora adeguatamente riconosciuta, del romanzo antropologico, così favorendo il possibile prolungamento di una dimensione realistica capace di interrogare, dalla specola di un soggetto problematicamente venuto da lontano, un mondo-altro. Non è un’operazione facile, né scontata: il rischio del paternalismo e del moralismo – che Levi non aggira, ma prende sul serio, facendone ragione di autocritica – è dietro l’angolo. Del resto, come ha annotato Gramsci nei Quaderni del carcere, questo rischio fa parte dell’alfabeto categoriale degli scrittori italiani (per vocazione “non nazionali-popolari”, cioè incapaci di attivare una “connessione sentimentale” con gli strati sociali subalterni). E si può discutere sul fatto che non sempre Levi sia indenne da una certa limitazione “esotica” dello sguardo. Ma la forza politica del Cristo sta nel portare a consapevolezza politica e poetica queste tensioni, senza nasconderle. Basterebbe ciò a ridimensionare le accuse di populismo estetico che gli furono mosse (e che, ad ogni modo, vanno prese sul serio per un riesame attualizzante del testo, oltre che per raccontare una certa stagione della critica letteraria nostrana).
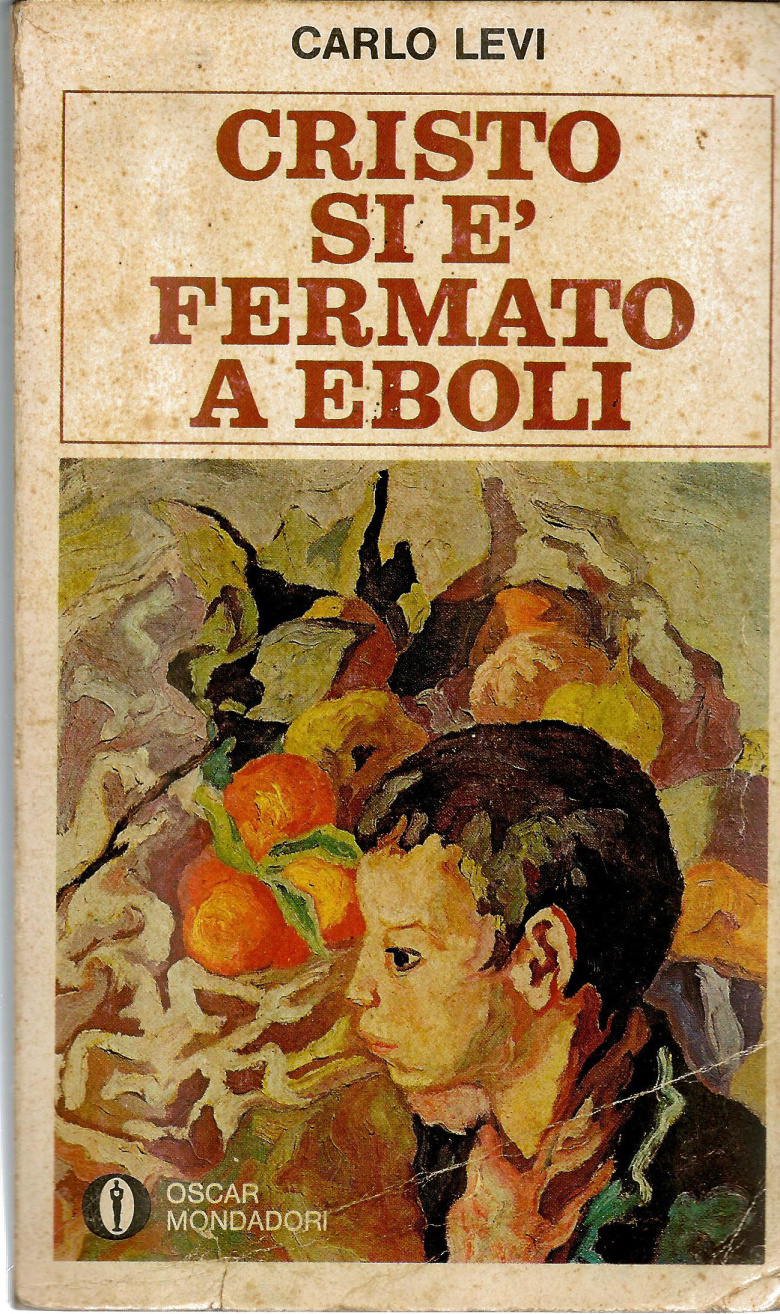
Che sia però l’incontro con una realtà valoriale diversa, e tanto più differente da quella culturalmente borghese, il motore filosofico e narrativo del romanzo, lo conferma il processo di continua e perfettibile definizione del mondo contadino a cui l’intellettuale consegna i suoi pensieri. Lo stesso processo conduce Levi a mettere in discussione i concetti con cui pensare il rapporto tra l’individuo e la comunità e a ricalibrarli, con una manomissione dei propri, per comprendere «un mondo che si continua senza determinazioni, dove l’uomo non si distingue dal suo sole, dalla sua bestia, dalla sua malaria». La comparsa di Luisa, sorella del narratore-pittore, per una visita di pochi giorni, le sue riflessioni amare e crude sull’atroce spettacolo dei bambini materani colpiti dal tracoma («Io non ho mai visto una tale immagine di miseria: eppure sono abituata, è il mio mestiere, a vedere ogni giorno diecine di bambini poveri, malati e maltenuti. Ma uno spettacolo come quello di ieri non l’avevo mai neppure immaginato», confessa al fratello) e le considerazioni che emergono dalla sua “extra-località” (per scomodare Bachtin), riconsegnano lo sguardo di un indignato lettore borghese che sprofonda nell’inferno che, nonostante tutto, ha contribuito a costruire.
E in questa consapevolezza risiede forse quella dimensione politica che spinse anche gli intellettuali meno attratti dalla poetica leviana (e dal suo rapporto col registro mitico) a prendere molto sul serio il Cristo. Il già citato de Martino riconosce nell’esempio di Levi il monito a cui il sapere occidentale dovrebbe costantemente guardare per esorcizzare le proprie tentazioni assolutistiche. Nel 1949, nel noto saggio Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, uscito su «Società», l’etnologo napoletano, già fuori dell’orbita crociana, scrive, ispirato dalle pagine di Levi (seppure riviste in un’ottica già gramsciana), che «Il circoscritto umanesimo della “civiltà occidentale” inerisce […] alla struttura stessa della società borghese: appunto perché è carattere di tale società che Cristo non vada “oltre Eboli”, il mondo che vive oltre Eboli è apparso alla etnologia e folklore borghesi come astorico, ovvero come storia possibile ma che attualmente non si affaccia alla memoria dello storiografo». Si può dire che il confine di Eboli abbia dunque rappresentato un’allegoria dello “storicismo ristretto” (l’espressione è di Alberto M. Cirese) tipico della cultura occidentale e del suo esclusivismo. Ebbene, lo sguardo di Levi ha sollecitato l’autocritica e l’oltrepassamento di quel limite, e dunque l’allargamento del punto di vista storico. Quest’ultimo passa – è forse una delle lezioni più durevoli del Cristo – dalla serietà filosofica con cui si osserva la cultura dei contadini, le pratiche e l’immaginario che essi allestiscono per resistere alla pressione della storia e alla condizione di subalterni. Emancipare il sapere contadino e le sue modalità di espressione da un’interpretazione semplicistica e paternalistica: non è un’indicazione di poco conto. Che Levi abbia tradotto in senso anzitutto poetico le sue intuizioni o abbia riconosciuto idealisticamente l’esistenza di una «immobile civiltà», può costituire, per molti aspetti, un limite (come sempre legato a una specifica idea di libertà umana e di storia universale, cioè all’irriducibile ideologia leviana), ma è indubbio che l’evidenza etnografica di certe sue pagine abbia suscitato, per eterogenesi dei fini, letture e proposte di rilevante tensione politica, persino materialistica.
Certo, lette oggi, le considerazioni finali del Cristo sulle due civiltà – quella cittadina, quella contadina – che non possono incontrarsi paiono riconsegnate al passato. L’assimilazione violenta delle culture locali allo spirito del capitalismo, il loro annientamento nel nome dell’omologazione e la passivizzazione economica del Mezzogiorno passano, nel presente, attraverso forme paradossali di autonomia e di frammentazione, che sedano o rendono impossibile qualsivoglia riappropriazione antropologica e politica del senso di comunità e di relazione sociale invocato da Levi nelle ultime pagine del suo romanzo. L’annichilimento della questione meridionale è, in fondo, dovuto anche al rinvigorirsi di pratiche culturali estetizzanti che confermano il Sud come supposto spazio di un’idealistica differenza, nel quale un concetto come quello di autodeterminazione si confonde con altro e perde la sua valenza politica. Probabilmente, l’egemonizzarsi di queste visioni – al cui opposto potrebbe collocarsi, se solo ne avesse la forza, una versione critica del Meridione come riflesso specifico, dietro la presunta panacea dell’overtourism e del “paesismo” (prendo il termine da un recente e bel libro di Francesco Della Costa), del più generale conflitto tra capitale e lavoro – ostacola quella lettura politica del libro di Levi che si propiziava, nella misura in cui, proprio per raggiunta inadeguatezza del nostro sguardo, il Cristo rischia di diventare, perfettamente rovesciato, solo l’esposta didascalia di un paradiso abitato dai diavoli.