Carlo Levi, Il futuro ha un cuore antico
Tra il 17 ottobre e il 19 novembre del 1955, in occasione dell’uscita della traduzione in russo di Cristo si è fermato a Eboli, Carlo Levi compie un viaggio in Unione Sovietica. Mosca, Leningrado, Kiev, poi Armenia e Georgia sono le tappe di quel viaggio.
Il tratto che dà fondamento al titolo di questo suo secondo libro di viaggio – Il futuro ha un cuore antico, appena preceduto, l’anno prima, da quello dedicato ai suoi viaggi in Sicilia (Le parole sono pietre, Einaudi) – probabilmente è nel passaggio in cui Levi racconta le sue sensazioni già all’arrivo in aeroporto, a Mosca (ancora deve avvenire l’incontro con le persone, ma molto già è testimoniato dalle sue reazioni alle cose).
“… tutto – scrive Levi nelle prima pagina di Il futuro ha un cuore antico – aveva un’aria insieme antica, paziente, disordinata e orgogliosa: sentivo in me una indeterminata sensazione che mi richiamava il Sud, in questo estremo settentrione, il Sud dei contadini, un Sud di poveri, non più poveri” [p. 14].
Questa sensazione torna nelle sue considerazioni dopo la prima settimana a Mosca, domenica 23 ottobre quando riflette sulla sua infanzia [p. 77], ma soprattutto quando si tratta di stabilire un canone mentale (prima che storico o economico) in cui «antico» non corrisponde a tradizione, e «nuovo» non corrisponde a innovazione.
Il tempo è quello inaugurato con la Rivoluzione d’ottobre che Levi legge attraverso la lente della continuità non relativamente alla forma, ma al carattere, alla sensibilità senza cedere all’effimero del nuovo. “Così come gli abitanti della Nuova Inghilterra hanno serbato i modi puritani della patria di origine, o come i canadesi hanno conservato il francese del ’700, i sovietici sono rimasti i custodi dei sentimenti e dei costumi dell’Europa, di quando l’Europa era unita, e credeva, tutta intera, in alcune poche verità ideali e aveva fiducia nella propria esistenza” [p. 79]. E poi aggiunge: “Sono le stesse strade che gli uomini della mia età hanno calpestato in un tempo che sembra lontanissimo, e che qui, a ogni diversa prospettiva, a ogni apparire di persona, pare si riaffaccino dal di dentro, dall’intima ombra del tempo: quella semplicità, quell’ingenuità, quell’onestà, quella pulizia morale, quella timidezza, quella volontà di bene: quell’insieme di ideali che raccolgono insieme i miti del progresso, l’ottimismo della ragione, il positivismo, la fede nella scienza, il gusto per l’arte verista e naturalistica e la decorazione eclettica ed eteroclita, fiduciosa accostatrice di tutte le epoche e di tutti i luoghi, la passione per le grandi idee internazionali, il senso del potere dell’uomo sulla natura e sul mondo, la tecnica, la scoperta, la bontà, la virtù” [Ib.].
Considerazione che mi sembra costituire – come avrebbe detto Manzoni – “il sugo di tutta la storia”.
“La rivoluzione sovietica – scrive nelle pagine finali di Il futuro ha un cuore antico – è assai meno simile di quanto io prima pensassi alla rivoluzione americana, anche se i loro risultati comuni siano l’industrializzazione e il relativo livellamento delle condizioni sociali; e si potrebbe dire per un certo aspetto, assomigli piuttosto a una rivoluzione cattolica” per poi concludere che “forse l’Unione Sovietica è la morale sovietica assai più che l’economia e la politica sovietica e certo mille volte più che la sua cultura e la sua arte” [p. 265; i corsivi sono miei].
Questo è ciò che Carlo Levi ci racconta nel suo libro: una narrazione ricca di dettagli, di descrizioni di un mondo, al tempo stesso, antiquato e giovane.
Il futuro ha un cuore antico è contemporaneamente un libro di viaggio, ma anche un saggio di riflessione sul proprio modo di guardare un «mondo altro». Quel «mondo altro» per molti di coloro che si sono confrontati con quel testo ha i tratti della Lucania che Carlo Levi aveva incontrato nella sua esperienza di confino.
È un tratto, questo della sovrapposizione Lucania/Unione Sovietica, su cui insiste Stefano Levi Della Torre nell’introduzione alla nuova edizione, ma su cui avevano insistito già Gigliola De Donato e Sergio D’Amaro nel loro Un torinese del Sud (Baldini & Castoldi).
Ci sono oggetti che Carlo Levi incontra che gli ricordano un tempo fermo all’atmosfera del grande romanzo russo dell’Ottocento, per esempio il Kvas – la bevanda tradizionale slava a base di pane di segale fermentato che intravede nell’insegna di un luogo pubblico. Vorrebbe berla. La sua guida lo distrae e quell’opportunità si consuma (nel corso del suo viaggio, scrive Levi, quella opportunità non si sarebbe ripetuta [p. 24]). Oppure ci sono i cibi. Per esempio quelli che descrive in Georgia nel villaggio montano di Pasanauri [p. 224].
Accanto agli oggetti ci sono i progetti.
Il progetto nasce da una parte dalle condizioni, dall’altra dallo scopo, ma poi anche dalle domande o dalle curiosità del viaggio. Scrive Levi: “potevo andare dappertutto dove mi paresse, senza alcuna ragione di preferenza o di scelta. Da che parte avrei cominciato? Non amo, in genere, gli schemi e i programmi: [..]. Ma dovevo pur scegliere, prevedere, fare un elenco. Avrei voluto dire che preferivo girare per le strade e conoscere gli uomini, e che un mese o poco più, quanto doveva durare il mio viaggio, è troppo per l’intuizione, per un’impressione che può nascere in un istante, ma troppo poco per la conoscenza analitica degli aspetti infiniti di un paese sterminato […] Poiché mi si chiedeva un programma, finii, a poco a poco, a furia di aggiunte, per metterci dentro tutto: le case, le fabbriche, le scuole, i contadini, gli scrittori, gli artisti, gli ospedali, gli istituti scientifici, i giornali, i teatri, il cinematografo, lo sport, le città, i villaggi, i grandi e i piccoli, ogni cosa...”[pp. 30-31].
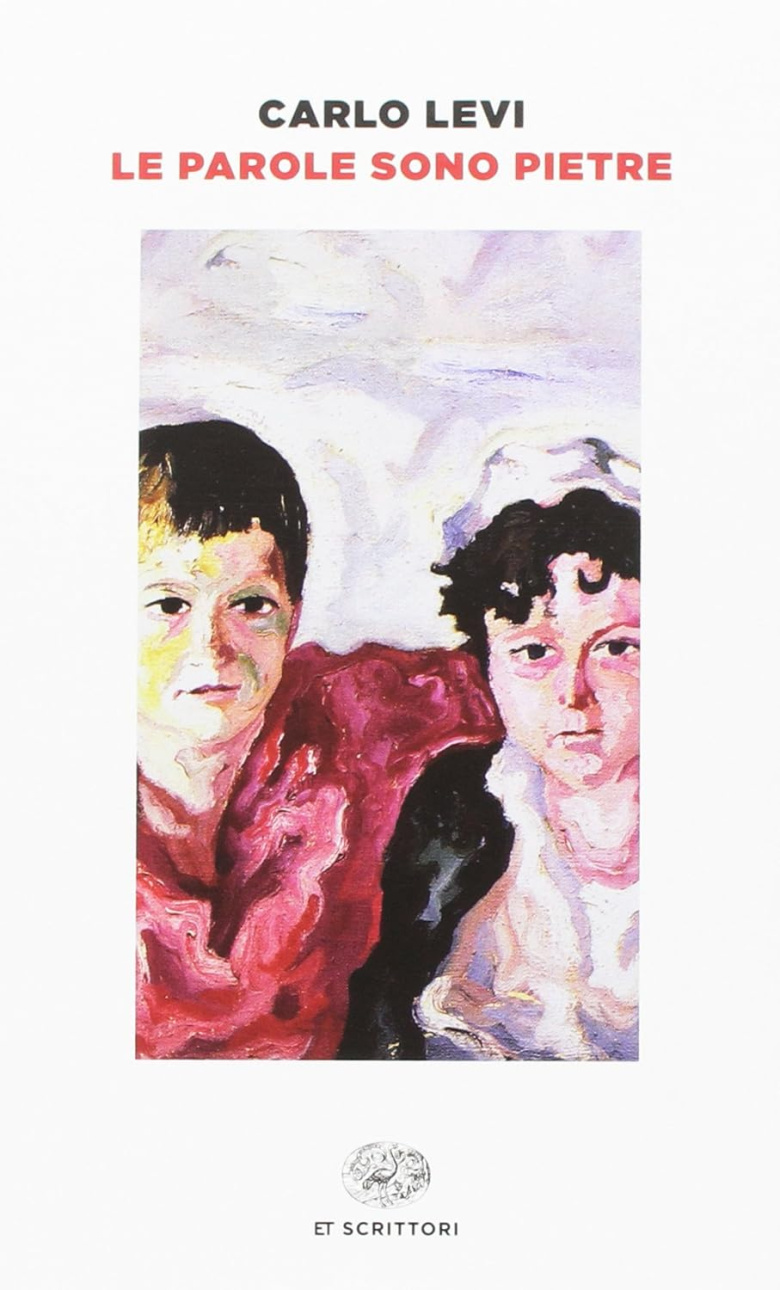
Poi ci sono i tratti che forniscono garanzia.
La Russia, a differenza dell’Europa, pare a Carlo Levi nel novembre 1955 un cosmo umano e mentale, che ha fatto di tutto per mantenere i suoi tratti originari a fronte di un’Europa che invece si è stravolta nella foga di modificarsi e di adattarsi al nuovo tempo. La conseguenza, per quest’ultima, è che il Novecento è stato un passaggio “di catastrofe in catastrofe” [p. 80].
Al contrario, la Russia, in forza di una rivoluzione nazionale che l’ha isolata, da quella rivoluzione e da quell’isolamento è riuscita a mantenere e a garantire la sua personalità storica, tanto da apparirgli ora “come il miraggio del paese dell’infanzia, il miraggio semplificato di un’Europa immaginaria e perduta” [p. 81]
Un tratto che ritorna, per esempio, nella sensazione che prova nell’incontro con il mondo del lavoro a Leningrado, in una fabbrica tessile che, sottolinea, non ha niente di speciale nelle forme, nei ritmi, da quelle che conosce a Torino. Ciò che gli appare profondamente diverso è la condizione psicologica, mentale dei lavoratori.
“Un che di giovanile, di sicuro e di felice era in loro – scrive – lontano dalla grigia folla dei marciapiedi. Lontanissimi dai visi aspri e tesi degli operai di tante fabbriche che conoscevo, da quegli sguardi a volte rassegnati, a volte pieni di nascosta rivolta, sempre, in qualche modo, ostili e costretti” [p. 117; il corsivo è mio].
Che cosa li distingueva da quelli? Scrive:
“C’era, su tutti quei volti, l’aria ilare e giovanile della conquista, il senso di libertà e di fierezza di chi, pensando di averlo costruito con le sue mani, trova, bello o brutto che sia, se stesso e la pace, nel mondo in cui vive” [p. 118; il corsivo è mio]. Lo stesso profilo torna nelle note sulla condizione di lavoro nel colcos nella sua tappa in Armenia [pp. 180 182 e 195 e sgg.], un mondo descritto con stupore, con condivisione per certi aspetti, senza caricarsi di domande quale poi sarà anni dopo lo sguardo inquieto con cui Bruno Bettelheim (nel suo The Children of the Dream) indaga e scava sulle esperienze comunitarie, soprattutto sulle generazioni nate in quelle esperienze.
Spicca in queste pagine la richiesta a Carlo Levi proprio dei componenti del colcos in Armenia di “dire la verità, quando tornerai in Italia, nel tuo paese, senza cercare di abbellire le cose che hai visto, né di menomarle. Noi non abbiamo paura della verità; abbiamo paura soltanto della menzogna: vogliamo sia detto quello che è bene e quello che non lo è” [p. 201]
In effetti si potrebbe osservare come Carlo Levi dia voce in questo resoconto di viaggio, che è soprattutto un momento di riflessione pubblica sull’anima profonda di un paese, alle emozioni che ha provato, ma anche alle attese dei suoi interlocutori.
E tuttavia a un lettore di oggi, – ma presumo anche di allora – non può sfuggire un aspetto che in alcuni momenti emerge in quelle pagine e che rappresenta un indicatore di sensibilità «al tempo presente» sia di Carlo Levi, sia del suo lettore nell’estate 1956 quando il libro esce in prima edizione, sia, infine del lettore di oggi.
La domanda riguarda quanta consapevolezza e quali domande avesse Carlo Levi a proposito di quel tempo che sta tra la morte di Stalin (5 marzo 1953) e le denunce dello stalinismo che Kruscev renderà pubbliche nel suo rapporto segreto al XX congresso del Pcus leggendo la sua relazione nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 1956 e che domande si facesse nelle settimane successive alla lettura di quel rapporto quando la notizia inizia a circolare fuori dall’Urss.
Il viaggio di Levi si compie prima di quell’appuntamento, ma Il futuro ha un cuore antico esce dopo che le questioni della denuncia hanno iniziato a circolare sulla stampa internazionale.
Carlo Levi sceglie una scrittura intorno alla “questione Stalin” (peraltro molto marginale, e anche questo è un indicatore) in cui la sua persona emerge. Riguarda i cenni, peraltro molto fugaci, a quanto ancora sia forte il culto di Stalin nella monumentalistica. È, per esempio, la scalata di notte a Erevan alla statua di Stalin, in un tempo in cui è ancora vissuto e percepito come «eroe nazionale» [p.190] o quale sia ancora il ruolo pubblico che Stalin ricopre in occasione della sfilata per la commemorazione della “rivoluzione d’ottobre” [p. 215].
Ma soprattutto è la dimensione di un tempo sospeso in cui protagonista, scrive, non è la generazione che ha fatto la rivoluzione, o quella della “Grande Guerra Patriottica” (come è denominato in Urss il periodo della Seconda guerra mondiale), ma quella successiva e che ora deve confrontarsi con un nuovo tempo. Una generazione, scrive, “che è arrivata dopo, [che] sente i problemi morali più di quelli ideologici, e si rivolge alla coscienza e alla libertà” per poi concludere, rivolgendosi a questa nuova generazione, “L’avvenire è aperto: l’errore sarebbe di opporsi in nome di una concezione che ha avuto forse in passato le sue ragioni e le sue necessità, ma che oggi è invecchiata e dannosa. Contro chi dovete combattere? Contro i pericoli che sono in voi, contro la burocrazia e il conformismo (e l’indulgenza alla tirannide)” [p. 282; il corsivo è mio].
Tutto questo testimonia di un disagio se non provato durante il viaggio, certo presente una volta che le emozioni, le sensazioni, le immagini che hanno accompagnato quel viaggio devono trovare spazio sulla carta, ovvero trasformarsi in libro.
Lì si colloca un’incertezza, forse una ritrosia, a fare i conti con le contraddizioni che nel frattempo si sono aperte tra il ritorno in Italia e le notizie che si diffondono sui contenuti del Rapporto Khruscev.
Una scrittura che non può ripetere il canone dell’immediato secondo dopoguerra quando l’esperienza di viaggio in Urss si era concentrata sugli sforzi e gli eroismi di un popolo che ricostruiva la propria nazione (come la descrive Vittorio Foa nel febbraio 1951, al ritorno di un suo viaggio in Urss, in un suo intervento sul mensile “Rinascita” dal titolo L’uomo creatore nell’economia sovietica). Ora, nel 1956, la scrittura di quell’esperienza testimonia della difficoltà a fare un passo in più.
Il risultato è un’allusione che fotografa un’istantanea, più che un percorso. Quell’istantanea, per certi aspetti non risolta, ancora riguarda il vocabolario e l’immaginario di una mentalità a sinistra che dice di aver superato quel tempo, ma ancora vive la critica a quell’esperienza come “tradimento della propria appartenenza” e, insieme, “crisi della propria identità”.
Leggi anche:
Mauro Boarelli | Carlo Levi, L'orologio
Alberto Saibene | Oltre Eboli: Carlo Levi e Francesco Rosi
Matteo Marchesini, Carlo Levi, Morante, Pasolini
Eliana Di Caro, Lo sguardo del confinato Carlo Levi







