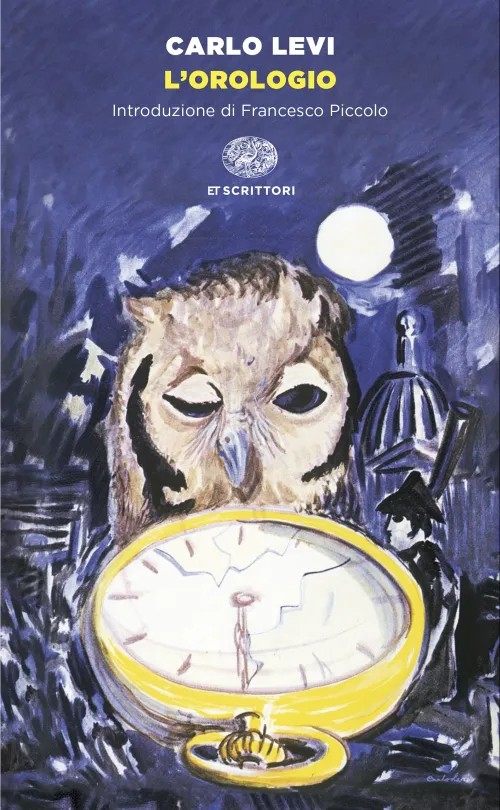Carlo Levi, L'orologio
Per ricordare Carlo Levi a cinquant'anni dalla scomparsa (1975), "doppiozero" pubblicherà una serie di articoli dedicati ai suoi libri più importanti. Cominciamo oggi con L'orologio, riproposto nelle scorse settimane dalla casa editrice Einaudi, che lo pubblicò per la prima volta settantacinque anni fa. (La redazione).
“La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni”. È l’inizio spiazzante del libro di Carlo Levi L’Orologio, pubblicato da Einaudi nel 1950 e ora riproposto dalla stessa casa editrice in occasione del cinquantesimo anniversario della morte dell’autore. Molto criticato all’epoca, quasi dimenticato nei decenni successivi, L’Orologio racconta la ricerca di un nuovo ordine politico e sociale e il suo intrecciarsi con la ricostruzione materiale e civile del paese dopo l'oppressione del fascismo e lo sfacelo della guerra, ed è la rappresentazione letteraria più lucida, appassionata e disincantata della nascita della Repubblica.
Il libro di Levi non è facilmente classificabile. Non è un romanzo, non è un saggio, non è un memoriale, ma intreccia con grande sapienza narrativa – sorretta da un'altissima qualità di scrittura – registri diversi e molteplici sguardi per comporre un intenso affresco sociale e politico. Il lettore si trova di fronte a una acuta osservazione antropologica del mutamento postbellico, attenta ai dettagli, alle vicende individuali, allo spazio urbano. Accanto ai protagonisti della politica, decine di personaggi del popolo si accalcano nelle pagine del libro raffigurando la vitalità di un paese che – nella miseria del dopoguerra – si muove incessantemente, riempie le strade e le piazze, scopre la libertà e il disordine.
Il racconto si svolge nell’arco di tre giorni in cui Levi – all’epoca direttore del quotidiano del Partito d’Azione “L’Italia libera” – è protagonista o testimone di una fitta serie di avvenimenti, incontri, viaggi. A questo condensarsi del tempo narrativo si affianca – per contrasto – una dilatazione costruita attraverso minuziose descrizioni di luoghi e persone e lunghi flashback.
Il precipitare degli avvenimenti politici che costituisce il centro narrativo del libro è immerso nel flusso della quotidianità, una quotidianità accelerata, febbrile, che Levi di tanto in tanto rallenta alla ricerca di una molteplicità di punti di osservazione e che contrappone sia al tempo immobile e sempre uguale a se stesso della burocrazia sia a quello ancora incerto della politica, oscillante fra le urgenze della ricostruzione e della definizione di un nuovo assetto istituzionale e la rarefazione racchiusa nella separazione dal proprio corpo sociale, di cui lo scrittore coglieva già allora i primi sintomi.
Al centro di questa stratificazione temporale c’è Roma, la città in cui lo spirito della Resistenza viene tradito, la città dei ministeri dove “tutto si impantana, e perde forma”. Il contraltare a questa degenerazione è Ferruccio Parri, “un crisantemo sopra un letamaio”, il comandante partigiano ed esponente del Partito d’Azione che guidò per pochi mesi il governo dopo la liberazione:
Era diverso, come straniero: [...] tra gente esuberante, era schivo; in un paese amante della retorica e delle frasi, era scarno e ritroso [...]. Aveva il viso sofferente, come se un dolore continuo, il dolore degli altri che non può avere fine, gli volgesse in basso gli angoli della bocca, gli spegnesse lo sguardo, e gli avesse, fin da fanciullo, imbiancato i lunghi capelli. (L’Orologio, Einaudi 2025, p. 168)
Nella descrizione di Levi risuonano le parole con cui Carlo Rosselli – il fondatore di Giustizia e Libertà che, insieme al fratello Nello, verrà ucciso in Francia da sicari fascisti nel 1937 – ricorda il suo compagno di prigionia nell’ultima notte trascorsa nel carcere di Palermo:
Parri è la mia seconda coscienza, il mio fratello maggiore. [...]. Questi uomini alti e puri sono tristi, terribilmente tristi e solitari. Scherzano, ridono, amano come tutti gli altri. Ma c’è nel fondo del loro essere una tragica disperazione [...] La vita è per loro [un] dovere. Fino alla conoscenza di Parri, l'eroe mazziniano mi era parso astratto e retorico. Ora me lo vedo steso vicino, con tutto il dolore del mondo ma anche tutta la morale energia del mondo, incisa sul volto. (Socialismo liberale e altri scritti, Einaudi 1973, pp. 512-513)
La caduta del governo Parri, nel novembre 1945, aprì la strada alla definitiva archiviazione di ogni esperimento di innovazione nelle istituzioni, ed è il nucleo intorno a cui ruota tutto il racconto. Le pagine dedicate alla conferenza stampa con la quale Parri annunciò le dimissioni descrivono con acume tutti gli attori coinvolti nella crisi, a partire dal suo protagonista principale, o meglio la sua vittima sacrificale, dalla cui bocca esce il "linguaggio dei morti, che dicono la verità che nessuno intende". E poi i capi della destra e della sinistra (De Gasperi e Togliatti), "visi teologali e cardinalizi [...] fin troppo umani, accorti, abili, attenti, astuti, avidi di cose presenti", la folla eterogenea dei presenti, divisa tra vecchi notabili, giovani arrabbiati e delusi, preti, contadini, operai, politici e politicanti ("C'era ogni sorta di uomini, l'attuale classe dirigente tutta intera, ed era venuta per sciogliersi"), e infine l’apparato burocratico pronto a festeggiare la fine di un disordine inesplicabile e indesiderato:
Gli uscieri [...] avevano un’aria stranamente allegra: come se la riunione che si stava svolgendo fosse un veglione o una festa da ballo in loro onore. [...] Non avrebbero più dovuto trepidare al pensiero di folli riforme, di insensati cambiamenti, di crudeli epurazioni, di ridicole pretese di efficienza [...]. Quella dimora sconsacrata, sarebbe tornata a essere un santuario, una chiesa; ed essi, come era giusto, gli unici sacerdoti”. (L’Orologio, pp. 161-162)
Levi si interroga sul significato profondo della crisi di governo, al di là delle manovre politiche che l’avevano determinata. Immagina un dialogo con Andrea Valenti e Carmine Bianco, (pseudonimi dietro ai quali sono riconoscibili due esponenti di primo piano del Partito d’Azione, Leo Valiani e Manlio Rossi Doria), uno dei passaggi più originali del libro, una ventina di pagine in cui lo scrittore mostra la capacità – rarissima – di rendere materiale narrativo un dialogo politico. Valenti-Valiani propone ai suoi interlocutori una rielaborazione del concetto di lotta di classe attraverso la metafora dei "Contadini" e dei "Luigini" (riferimento esplicito al podestà don Luigino, uno dei personaggi di Cristo si è fermato a Eboli). I primi sono i produttori, coloro che costruiscono a partire dalle proprie idee e dalla propria disciplina interiore, i secondi "Sono quelli che dipendono e comandano; e amano e odiano le gerarchie, e servono e imperano". I Luigini sono maggioritari nella società, e hanno il monopolio della lingua: mentre i Contadini usano le parole per dare concretezza alle idee, i Luigini si impadroniscono "delle parole per stravolgerne il senso a piacere". Quanto ai partiti, è la loro stessa struttura ad essere “luigina”, e quindi non possono esprimere forme di rappresentanza originali fondate sull’autonomia e l’autogoverno, in grado di segnare una reale discontinuità con il passato (L’Orologio, pp. 175-193).
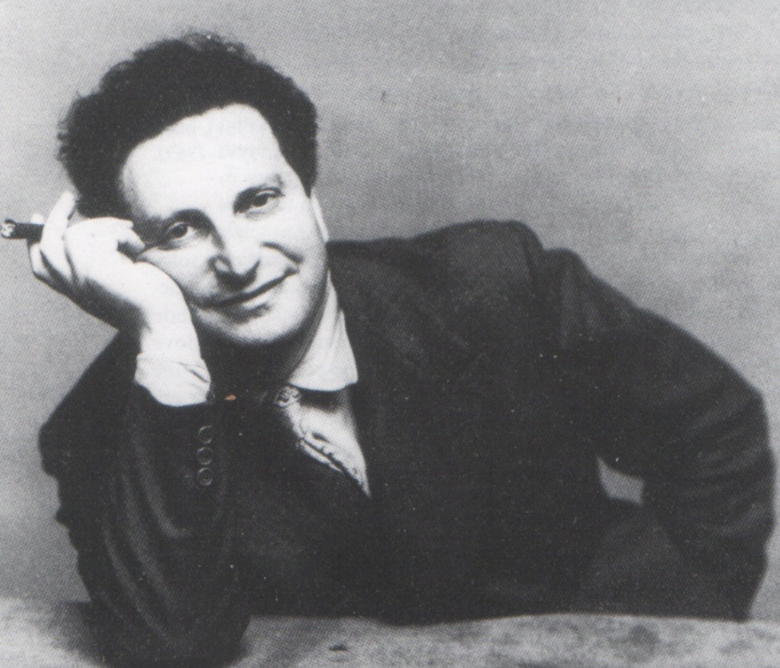
In questo scontro, Parri – un contadino travestito da luigino – era destinato a soccombere.
Il dialogo affronta da un’angolazione diversa i nodi del dibattito che attraversò il fronte resistenziale nel periodo successivo alla crisi di governo. Nel 1947 la rivista “Il ponte” diretta da Piero Calamandrei aveva dedicato un numero alla “crisi della Resistenza". Tra gli articoli ospitati, quello di Vittorio Foa – figura di rilievo dell'antifascismo e dell’azionismo, riconoscibile tra i personaggi di Levi sotto lo pseudonimo Fede – ricostruisce le origini di quella crisi e le rintraccia nel contrasto tra l'aspirazione dei Comitati di liberazione nazionale a diventare organi di governo e l’accettazione di muoversi entro la struttura dello Stato prefascista. "Rompere lo stato dall’interno”: questa la contraddizione in cui la Resistenza cadde ancora prima della formazione del governo Parri. Ed è una contraddizione propria anche del Partito d’Azione. È lo stesso Foa a tracciarne i contorni in un brano dedicato a Carlo Levi scritto alla fine degli anni ‘60 in cui si interroga sulle ragioni della breve vita del partito, che si scioglierà nel 1947, dopo soli cinque anni dalla fondazione:
Molti di noi si innamorarono [...] della tecnica della politica. Ci vendicavamo del fascismo sconfitto riscoprendo avidamente tutti gli strumenti che esso ci aveva sottratti [...]. In realtà il fascismo sconfitto si vendicava di noi; rimossa la dittatura e la camicia nera, arnesi ormai antiquati, la classe capitalistica canalizzò lungo gli strumenti della democrazia tradizionale la riconquista e il consolidamento del suo potere [...]. Ci dividemmo allora tra chi credeva nella tecnica politica e chi riaffermava il valore della poesia e della verità. E cademmo tutti insieme, i poeti (come Carlo Levi, Emilio Lussu, Guido Dorso e Ferruccio Parri) e i tecnici. (Per una storia del movimento operaio, Einaudi 1980, pp. 50-51)
Come è facile intuire, la rappresentazione della crisi governativa proposta da Levi non poteva essere gradita al Partito comunista, i cui intellettuali furono impegnati in una acrimoniosa demolizione del libro. Il critico e storico della letteratura Carlo Muscetta (che in un convegno agli inizi degli anni ‘90 fece pubblica autocritica per il suo attacco) accusò Levi di essere fedele a una “poetica decadentistica, al gusto della bellezza di ciò che muore”, dedito al “gusto per la leggenda” creata intorno a una “folla di individui giustapposti e senza storia”, cantore di una “leggenda della Resistenza, che muore nel qualunquismo”. (“L’Unità”, 16 giugno 1950)
A Mario Alicata – che qualche anno più tardi assumerà la direzione della commissione culturale del partito – si deve la stroncatura più feroce. A suo dire, Levi è affetto da “Approssimazione culturale e immodestia (incapacità di andare a scuola dal popolo)”, e il suo libro “si ammanta [...] di tutti i luoghi comuni, di tutto il ciarpame della decadenza culturale contemporanea”. Si è ancora in tempo a “salvare” Levi, sentenzia Alicata, ma per questo ha bisogno di “molti duri, fraterni, amichevoli cazzotti” (“Rinascita”, n. 6, 1950).
Ben pochi furono i critici che accolsero positivamente L’Orologio. Tra questi Franco Fortini, che aveva colto il “tentativo di un riscatto intellettuale” dopo la sconfitta politica, pur evidenziando i rischi di “un certo estetismo” (“Comunità”, n. 8, 1950), e il poeta Giacomo Noventa, che in un denso saggio aveva indagato – con un pessimismo che non apparteneva a Levi – uno dei temi centrali del libro: la condizione di estraneità di gran parte del popolo rispetto a coloro che hanno creduto di interpretarne i pensieri senza mai averli compresi fino in fondo e perciò continuano a vivere nella finzione, e l’incapacità (dei rivoluzionari come dei reazionari) di “colmare l’abisso” che separa le due società (Discorso su Carlo Levi e sulla situazione spirituale italiana, introduzione a “Nulla di nuovo” e altri scritti, Il Saggiatore 1960).
L’Orologio intreccia una molteplicità di argomenti, che possono essere organizzati intorno a due temi principali: la continuità dello Stato e il primato della politica. Il primo riguarda l’incapacità dei soggetti politici che avevano partecipato alla Resistenza di realizzare una rottura radicale con l’assetto istituzionale preesistente, senza comprendere che la sua sopravvivenza avrebbe condizionato negativamente e depotenziato qualsiasi progetto di cambiamento. Il secondo rappresenta il “peccato originale” del sistema politico post-bellico, che ha comportato la perdita di vista della realtà sociale nella sua integrità e la sua riduzione ad una sola dimensione, istituzionale e tecnica.
Muovendosi tra questi due poli, Levi costruisce una narrazione che risulta tanto chiara e scorrevole alla lettura quanto complessa nella molteplicità dei riferimenti storico-antropologici e nei significati (anche simbolici).
Come ogni opera letteraria di valore, non si esaurisce nel suo tempo, continua a interrogarci. Non lo fa, però, nei termini semplicistici e deformanti proposti nella prefazione alla nuova edizione da Francesco Piccolo, che – oltre a incorrere in evidenti errori interpretativi che banalizzano l’opera – si spinge a vedere nell’orologio che dà il titolo al libro (e a cui corrispondono episodi che aprono e chiudono il racconto) la chiave di lettura del modo in cui l’Italia “supera tutto” nel corso di epoche differenti, compresa la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento del Partito comunista e Tangentopoli (L’Orologio, p. X).
Non possiamo chiedere a Carlo Levi di spiegare la crisi della rappresentanza politica e del sistema istituzionale dei nostri giorni, ma dobbiamo prendere sul serio le domande che ha posto, perché ci riguardano ancora. Le ha formulate attraverso uno stile linguistico in grado di dissezionare aspetti cruciali della società post-bellica e le ha disseminate in una ricca stratificazione narrativa. Sono ben visibili, basta saperle rintracciare.
Leggi anche:
Alberto Saibene | Oltre Eboli: Carlo Levi e Francesco Rosi
Eliana Di Caro | Lo sguardo del confinato Carlo Levi