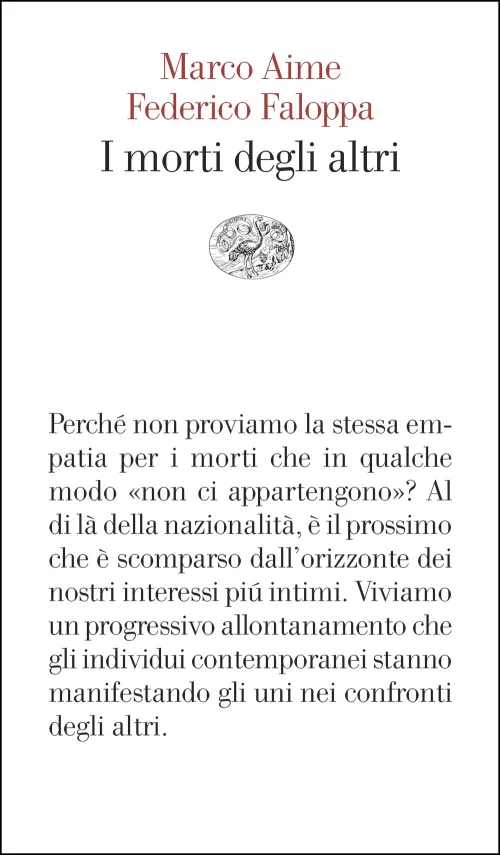Aime e Faloppa e la misteriosa fratellanza dell'altro
Kurtz, l’obiettivo della ricerca del Marlow di Cuore di tenebra (1899), è identificato da Joseph Conrad come un uomo geniale, dotato di un’eloquenza che gli permette quasi di «ingoiare tutta l’aria, tutti gli uomini davanti a lui». Ma è poi proprio la parola a tradirlo, quando a margine di un magniloquente rapporto per la «Società Internazionale per la Soppressione dei Costumi Selvaggi», si lascia scappare una nota a proposito degli individui oggetto delle sue elucubrazioni: «Sterminare tutti questi bruti!» (in riferimento agli africani con cui aveva avuto a che fare). Poco più di dieci anni prima di scrivere la sua più celebre novella, Conrad era stato ufficiale a bordo di imbarcazioni commerciali nel Sud Est asiatico, assistendo coi propri occhi alla marcescenza dell’Occidente moderno e della sua specifica impresa, il colonialismo. La visione di quell’intrico disperante di sfruttatori e sfruttati l’aveva spinto a licenziarsi dall’impiego, pur ambìto, di comandante di vascello, per poter testimoniare attraverso la scrittura ciò a cui aveva assistito. Era una necessità etica ancor prima che estetica: «per quale motivo il ricordo di quegli esseri – affermerà poi nel 1912 in Una cronaca personale – avrebbe dovuto chiedere di esprimersi in forma di romanzo, salvo che sul fondamento di quella misteriosa fratellanza che unisce in una comunione di speranze e timori tutti gli abitatori di questa terra?».
Il mondo a cui apparteneva Conrad era ovviamente meno ricco di interconnessioni del nostro, e per questo lo scrittore d’origine polacca esprimeva come propria missione prioritaria nei confronti del lettore quella di «fargli udire, fargli sentire – cioè, prima di tutto, di fargli vedere», suscitando in lui, se non pietas, almeno una consapevolezza di contraddizioni ignorate. Dai tempi di Conrad, il mondo è diventato molto più piccolo e quasi del tutto privo di angoli bui verso cui indirizzare lo sguardo di qualcuno, cercando di fargli vedere. Eppure, non sembra essersi accresciuta la coscienza etica su cui si dovrebbero basare l’arte o la conoscenza, così come troppo poco si è divenuti consapevoli dell’ipocrisia degli emuli di Kurtz e dei loro lapsus. Anzi, è proprio la prossimità virtuale a tutto e con tutto a rendere ancora più problematiche le nostre omissioni.
Marco Aime e Federico Faloppa, che insegnano rispettivamente Antropologia culturale a Genova e Language and Discrimination a Reading (Regno Unito), hanno pubblicato per Einaudi un libro dal titolo I morti degli altri in cui si sente riaffiorare, dietro il pungolo dell’attualità, la stessa necessità di Conrad. Qui, appunto, non si tratta di condurre i lettori in luoghi sconosciuti, ma piuttosto di rinnovarne lo sguardo. La postura abituale che assumiamo, in buona o in malafede, è esemplificata da un esercizio proposto dall’antropologa Vanessa Maher ai suoi studenti: si devono disegnare, a partire da un cerchio centrale che rappresenta il luogo in cui si vive, una serie di altri cerchi sempre più ampi che rappresentano il mondo a venti chilometri da casa, poi a cento e così via. Quindi, per ciascun cerchio e frazione di mondo, bisogna scrivere in breve tempo un episodio che viene alla mente. «Il risultato – scrivono Aime e Faloppa – è che si tende a indicare cose positive nella nostra zona, mentre via via che ci si allontana, le cose sembrano diventare progressivamente negative.» Questa semplice esperienza, che può sembrare divertente, dice più a fondo di una chiusura in sé stessi e di una diffidenza che congelano qualsiasi moto di reale empatia. E dice anche di una serie di pregiudizi (bias, come più spesso li si preferisce definire) che corrompono la conoscenza e i suoi usi politici.
Sembra che la «misteriosa fratellanza» da cui Conrad si sentiva interpellato sia a tutti gli effetti muta: ingoiata, come gli uomini che gli si parano dinanzi, dalla bocca di Kurtz, che al pari dei media contemporanei è eloquentissima ma incline a farsi scappare dalle labbra, in una sorta di coprolalia appena mascherata, i suoi intenti osceni. Che si incarnano in tic per cui si contano, e si piangono, più i morti occidentali che quelli di Paesi o popoli distanti nello spazio oppure lontani per ideologia, religione, assetto politico; in automatismi capaci di perpetuare i fantasmi occidentali dell’Oriente già smascherati da Edward Said; in idee date per scontate che minano imprese gravide di buone intenzioni come l’ambientalismo o la difesa del patrimonio artistico mondiale.

A questi ultimi due temi, Aime e Faloppa dedicano capitoli che, pur trattando argomenti in apparenza meno urtanti, hanno il potere di scuoterci con altrettanta forza: perché, se di alcuni pregiudizi siamo (con la coda di paglia) lesti a fare ammenda, di certi valori tendiamo ad andare fieri senza chiederci esattamente di cosa davvero siamo orgogliosi. In molti ricordano l’indignazione provata nel 2001 per l’abbattimento, da parte dei talebani, dei Buddha della valle di Bamiyan (un esempio tra molti, purtroppo, di azioni di fanatici contro monumenti o opere d’arte). Ma cos’è un’opera d’arte? «È l’arte a creare le opere d’arte» ha affermato l’africanista Jean-Loup Amselle, intendendo come ognuna di esse acquisti il proprio statuto all’interno di un sistema che le definisce e le convalida. Similmente, Walter Benjamin in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935-39) aveva scritto che «il valore di unicità dell’opera d’arte “autentica” ha una sua fondazione nel rituale, nell’ambito del quale ha avuto il suo primo e originario valore d’uso». «Arte» non è un concetto neutro, ma il risultato di un sistema collocato di tradizioni, di credenze collettive, di attribuzioni valoriali o economiche ecc. Che cosa si salvaguarda dunque quando ci si prende cura di un bene artistico? Forse, più che il bene stesso, un’idea di arte – la nostra, perlopiù. E l’idea di natura, solo in apparenza più leggibile come universale, merita gli stessi sospetti. Così Aime e Faloppa: «Accomunate sotto la dicitura di “patrimonio mondiale”, e “istituzionalizzate” come bene universale dall’Unesco, ecosistemi e opere di tipologia e culture diverse finiscono per sembrare più “occidentali” e favorire la percezione che […] tutta l’arte ci (a noi occidentali) appartenga, e che solo noi abbiamo i titoli per preservarla». Il paradosso è che i fanatici distruttori di opere finiscono per risultare ermeneuti più sottili di quanto crediamo, perché forse insieme alle opere stesse mirano a demolire l’antropologia che spinge una parte del mondo ad attribuire a esse un determinato valore.
Se la riduzione (o il distanziamento) strumentale dell’altro al sé è uno dei due poli dell’indagine di Aime e Faloppa, non si deve dimenticare che il secondo – come è evidente dal titolo – è il tema della morte, un tema che va oltre la stimolante perlustrazione offerta nel libro. I due autori ricordano che l’“altro” molto spesso ci sembra perdurare nella sua alterità anche nell’orizzonte della morte: si mantiene come «resto umano» a cui si possono ancora applicare le categorie di «nemico» o di «diverso», disattivando la compassione per la comune transitorietà. Ma viene da pensare che questa anestetizzazione dell’empatia sia direttamente collegata a una rimozione – ben diffusa nella contemporaneità che insegue il miraggio di vite prolungate – della morte come destino individuale inaggirabile. Se non si prende coscienza della morte come proprio destino, verrebbe da ripetere con l’Heidegger di Essere e tempo, essa rimane intesa come un evento qualsiasi che capita, all’esterno e non a me (e quindi all’altro). In fondo, è un evento che non mi riguarda, così come non mi riguarda a chi accade: spostando il volto dalla morte, sposto il volto anche dall’altro. Invece, la morte accettata come destino individuale rende consapevoli dell’unicità di ognuno davanti a quella possibilità inevitabile, e quindi aiuta a far percepire la dimensione tragica di ogni esistenza. Forse sta proprio in questo spazio la possibilità di recuperare il senso autentico della pietà.
Le ultime pagine del libro di Aime e Faloppa contengono un riferimento a un articolo di Giorgio Agamben dal titolo Il volto e la morte (2021), in cui il filosofo richiama l’attenzione sullo ius imaginum vigente nell’antica Roma, una consuetudine che gravitava appunto attorno al culto dei morti: si trattava, in sintesi, del diritto dell’uomo libero «di custodire il volto dei suoi antenati per esibirlo in pubblico durante le feste della propria comunità». Un diritto che andava di pari passo con la partecipazione alla vita politica, e che richiama alla mente anche i ritratti funerari del Fayyum, che pur se pensati per non essere visti – poiché venivano applicati su corpi mummificati – dicono di un’identica attenzione al volto. Viene da pensare, in questo contesto, alla riflessione di Emmanuel Levinas sul volto, che uno dei suoi più attenti interpreti italiani, Silvano Petrosino, ha condensato così: «il volto non è segno… il volto segna l’interruzione stessa di ogni possibile semiosi, finita o infinita che sia» (Emmanuel Levinas. Le due sapienze, Feltrinelli 2017). Aime e Faloppa ricordano come spesso nei media le immagini che rappresentano migranti, oppure vittime di tragedie che sembrano distanti da noi, non ne comprendano i volti: proprio perché, non mostrandoceli, possiamo attivare la semiosi che i poteri e le pratiche politiche ci spingono a seguire per disumanizzarli. Ascoltando Levinas, bisognerebbe dunque smettere di pensare all’altro come altro, ma vederlo finalmente in volto, accorgendosi che non è “altro” ma “unico”: «in Levinas» scrive ancora Petrosino «“volto” non vuol dire e non sta per “alterità”, bensì per “unicità”» e così si può comprendere che «l’“unico” non è mai il “solo”». Una comunione di «unici»: forse è proprio questo il misterioso senso di fratellanza che aveva spinto Joseph Conrad, un oscuro comandante di navi commerciali, verso la letteratura.