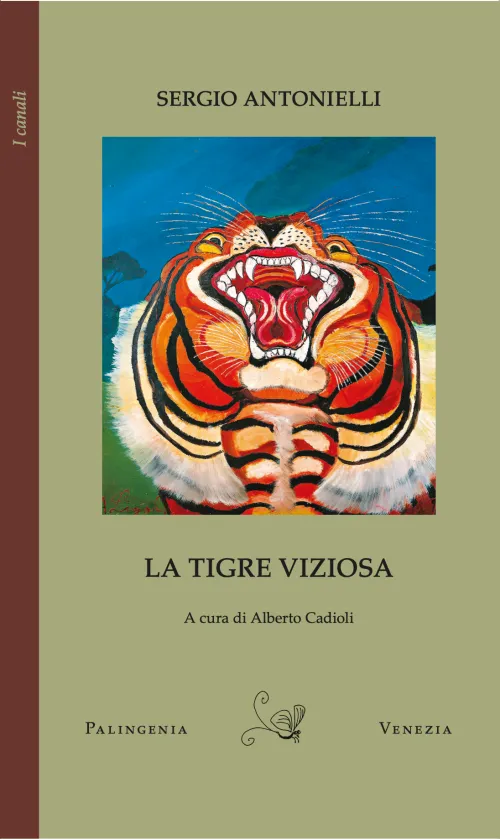Parla la tigre
Sergio Antonielli fu fatto prigioniero dall’esercito inglese nell’autunno del 1942, dopo la sconfitta di El Alamein. Dal Nordafrica, dov’era ufficiale, fu portato in un campo di prigionia a Yol, nella regione più a Nord dell’India. Entrò nel campo che aveva ventidue anni, ne uscì a guerra finita, nel ’46. Certamente fu proprio in quegli anni passati a ridosso delle montagne himalayane che sentì parlare delle tigri, che ne avvertì da vicino il respiro. Forse, vide con i suoi occhi qualche vittima incauta dell’animale, che si era spinto fino ai margini degli abitati. La sua attività di scrittore, che al ritorno in Italia affiancava a quella di critico e professore, fu segnata fin da subito da quelle esperienze: la prigionia e l’incontro con una natura estranea, seducente. Esordì nel 1949 con Il campo 29, traduzione romanzesca degli anni di segregazione, che gli valse qualche premio e l’attenzione della critica; poi, dopo una seconda prova più opaca (La dinastia, Rizzoli 1952), venne accolto l’anno successivo nei «Gettoni» Einaudi con un racconto lungo, La tigre viziosa, che incontrò il favore sia di Elio Vittorini sia di Italo Calvino. Palingenia ripropone ora, a cura di Alberto Cadioli, questa novella passata per lo più inosservata nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra. Per una ragione che Vittorini, nel risvolto dell’edizione einaudiana, sottolineava, non solo guardando al passato, ma quasi profetizzando un destino: «Non si è mai parlato molto di animali nella letteratura italiana».
L’unicità del libro di Antonielli è evidente sin dalle prime righe: è un esemplare maschio di tigre indiana a raccontare, con voce e consapevolezza del tutto umane, la sua traiettoria terrena. Un’esperienza segnata dal rapporto con l’altro da sé, l’uomo appunto, che sembra contaminare la sua voce. La tigre, timorosa dei contatti con gli uomini e relegata nel proprio universo regolato dalla legge della riproduzione e della predazione, è quasi folgorata da una fucilata che la manca di poco, e che la porta a una serie di «infrazioni» alla divisione del mondo tra il regno della ferinità e quello della civiltà. La fascinazione della tigre verso questo secondo àmbito del reale assume la forma del desiderio più propria per un predatore: dopo aver abbattuto una prima vittima umana, vuole cibarsi della stessa carne, che le provoca disgusto ma allo stesso tempo un piacere fino ad allora mai provato. Ma in quella coazione a uccidere, in quei brividi e rimorsi, c’è già una mutazione irreversibile: «il vero vizio» ha commentato Giacinto Spagnoletti «sta appunto nel conoscere un’altra dimensione della propria natura, abbandonando quella propria ed essenziale; ed è tale che dallo stato della sensualità passa a quello della conoscenza». La tigre, dalla giungla, raggiunge le pendici delle montagne, contempla nuove possibili vittime e allo stesso tempo spia le vite e le abitudini degli uomini. Villaggi, cave, riti di sepoltura, animali addomesticati per il lavoro, episodi di crudeltà gratuita. Fintanto che, da cacciatrice, diventa cacciata; potrebbe salvarsi tornando a valle, nel ventre della giungla che l’ha sempre avvolta, nutrita. Ma la linea è varcata, la distanza dalla «schifosa dolcezza dell’uomo» non può più essere recuperata. Pur riconoscendole, e sentendosene ancora superiore, si lascia irretire dalle trappole di un cacciatore, e la seconda fucilata della sua esistenza la travolge in modo fatale, lasciandola più sorpresa che pacificata: «Né davvero, avessi avuto il tempo di pensarci, mi sarei potuto immaginare che un giorno tutto ciò avrebbe acquistato un senso».
Quel senso che sfugge alla tigre auto-cosciente, Vittorini lo trova interpretandone la parabola come un’allegoria: a rovescio, dove c’è una tigre che si umanizza, c’è un uomo che si fa bestia – e sullo sfondo si intuisce ancora, vicinissimo, lo spettro della guerra, la sua gran carneficina. È comprensibile lo sforzo di ricondurre il monologo della tigre in un orizzonte umanista, ma forse il tentativo finisce per smentire, subito dopo averla enunciata, l’eccezionalità della novella. Un’interpretazione, peraltro, da cui lo stesso Antonielli avrebbe finito per farsi irretire, poiché due dei suoi libri successivi, sempre impostati sulla falsariga del «monologo animale» (Il venerabile Orango, Mondadori 1962, e L’elefante solitario, Mondadori 1979) appaiono come dei veri e propri contes philosophiques: delle narrazioni a chiave che dietro gli scenari naturali e le sembianze bestiali dei personaggi fanno emergere temi e tipi dell’attualità umana (è ancora Spagnoletti a sottolinearlo). La tigre viziosa, invece, non si presta a questo gioco di decifrazione, anzi oppone una resistenza; oppure – il che è la stessa cosa – offre la sua superficie scivolosa a «diverse letture (tutte possibili e legittime)» (così Cadioli nella postfazione).
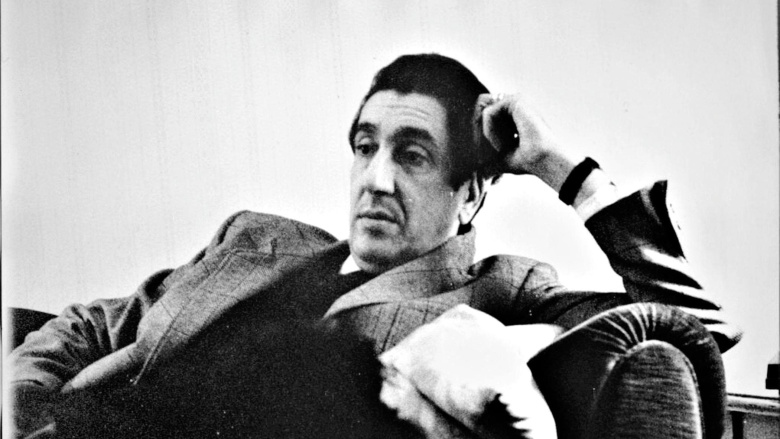
Un modo per approcciare l’enigma può ritrovarsi proprio nella scandalosa e contraddittoria umanità della «voce» della tigre. Ci sono scrittori – vengono in mente, per esempio, certe pagine di Cormac McCarthy – che addentrandosi nella sfera animale hanno scelto di accentuare l’incommensurabilità di questa con le percezioni e le motivazioni degli umani. Antonielli fa l’esatto contrario, e la sua tigre sembra possedere lo stesso spirito analitico con cui il Dottor Jekyll di Stevenson misura l’aggressione che Hyde, attraverso la pozione chimica, muove al suo corpo di uomo vittoriano e alla sua mente morale e scientifica. In questa scelta c’è, evidentemente, qualcosa di più di una disomogeneità di mezzi e intenti. Bisogna guardare forse a un testo apparso, in maniera curiosa, nello stesso anno in cui usciva la novella di Antonielli: un classico dell’antropologia, I riti di caccia dei popoli siberiani di Éveline Lot-Falck. La studiosa francese sottolineava come, presso i popoli da lei studiati, non si concepisse una distinzione tra uomini e animali. Di conseguenza, non si dava nemmeno un’idea di metamorfosi: «tra uomo e animale non c’è un mutamento di essenza, ma una semplice differenza di pelle». Per i cacciatori che abitano l’estuario dell’Amur e l’isola di Sachalin, i Ghiliachi, la tigre «si dà una scrollata e appende a un palo la sua pelliccia», così come «l’anima umana veste indifferentemente la pelle dell’orso, della tigre, dello zibellino». Sulla spinta di questo vento orientale, l’incongruenza, nella tigre di Antonielli, tra la consapevolezza umana e il manto ferino, appare, più che una contraddizione, un dramma che si consuma sullo stesso palcoscenico. Con una trama che, però, non si muove in un circolo, in una cangiante mutevolezza di ruoli e di sembianze, ma che ha un orientamento, una direzione nel tempo. O meglio, una direzione che crea il tempo. Il vizio della tigre, il suo rimorso nell’andare verso gli umani e la loro carne, è il segno di un processo che esiste, e che non può essere riavvolto e ricompreso nella metamorfosi perpetua. Di che cosa si tratta dunque? Forse proprio di quel movimento che, dall’indistinzione primordiale, porta al distacco dell’uomo dal continuum dell’essere.
In Il Cacciatore Celeste (2016), Roberto Calasso, riprendendo alcune nozioni della paleoantropologia contemporanea, indicava il passaggio alla dieta carnea come il punto decisivo in cui Homo si separa dal resto dei viventi, in quanto unico, di essi, in grado di modificare in maniera profonda la propria natura. E non solo di modificarla, ma di conservare in qualche modo il «rimorso» di quell’evento nell’edificio della cultura: «Nel regno animale, gli esseri continuavano a vivere come avevano sempre vissuto. Ripetevano immancabilmente gli stessi gesti. Quando Homo si trasformò in predatore, inferse una lesione in questo ordine delle cose. Da allora ogni uccisione fu anche un segnale che ravviva il ricordo di quel passaggio». L’ipotesi degli studi sullo sfondo delle pagine di Calasso è che, per compiere tale passaggio, l’uomo primitivo avesse imitato il comportamento di animali saprofagi come iene e sciacalli prima di iniziare, lui stesso, a uccidere altri animali per nutrirsene. Nella novella di Antonielli, uno degli episodi decisivi è quello in cui, irritata dagli ululati degli sciacalli verso la luna, la tigre ne atterra uno, ma poi lo lascia andare per un’inspiegabile moto di pietà. (Lei stessa poi, poco prima di morire, finirà per levare un canto alla luna.) Se la protagonista del libro non è solo tigre, ma tigre-umana, compresa in uno stesso orizzonte di indistinzione degli esseri, è come se risparmiasse nell’animale saprofago la parte di sé che si distaccherà per diventare qualcos’altro, folgorata da un’improvvisa premonizione. E premonizione è proprio dell’uomo già compiuto che, attraverso tranelli e strumenti tecnici (il fucile, forse un veicolo per coprire più rapidamente le distanze), non avrà poi lo stesso istinto di pietà, riconoscendosi già pienamente diverso dall’animale, già insignoritosi da sé della corona di sigillo della creazione. Due strati di storia, dunque, insistono nel racconto di Antonielli: o meglio, uno strato in cui non c’è storia – lo strato dell’animale-uomo – e quello della storia umana. Ma i due strati, pur distinti, non sono incompatibili, possono coesistere. La caccia è uno dei teatri di quell’oscillazione. Questo, forse, lo sguardo che può abbracciare le contraddizioni della tigre-uomo di Antonielli, e non rinchiuderla in un’allegoria troppo umana, troppo lontana da quell’origine lontana, ma sempre presente e pulsante come una ferita, che la sua «voce» riesce a rievocare con forza e ambiguità.
Nel 1987, a Monza, la città dove Antonielli, romano di nascita, aveva vissuto per molti anni, si tenne un convegno per ricordare la sua opera di critico e scrittore. Vi intervenne anche Giovanni Giudici, che di Antonielli era amico fin dall’inizio degli anni Sessanta, e che ricordò la propria «indegnità d’essere padrone di un cane [il setter delle Quindici stanze, incluse in La vita in versi], a confronto della pazienza e dell’amore che Sergio dedicava al suo Ringo», un barboncino che gli sopravvisse, nell’inverno dell’81, di soli pochi giorni. Per Giudici, Antonielli aveva «il tacito coraggio di contemplarsi in Ringo come in uno specchio», e colpisce l’uso della parola «coraggio» accanto a un nome così buffo come Ringo, e a un rapporto apparentemente tanto banale, come quello tra un padrone e un cane in un contesto cittadino. Antonielli non finiva di stupirsi per il «filo fragilissimo» a cui è appesa la vita dell’animale, ancora più scioccante nella sua inconsistenza di quella umana perché «può troncarsi da un momento all’altro, senza neppure quel minimo segnale di preavviso che è consentito, grazie all’uso della parola, all’uomo». Con i suoi animali parlanti e «ragionevoli», Antonielli aveva inteso riparare, almeno un poco, quell’ingiustizia. E con la tigre, in modo particolare, andare a fondo di una fratellanza troppo spesso tradita, o equivocata in una benevolenza superficiale – e mai davvero compresa.