Vallorani: Medusa science-fiction
Sono passati cent’anni esatti dalla pubblicazione del primo numero di Amazing Stories, la rivista americana diretta da Hugo Gernsback, che avrebbe proiettato la science-fiction (o scienti fiction) nell’orbita della letteratura popolare di genere. Nel suo editoriale dell’aprile 1926 Gernsback elencava come padri nobili della fantascienza Wells, Verne, Poe. Utilizzando lo stesso ordine, la copertina della rivista pubblicizzava le storie di questi autori che avrebbero dovuto nobilitare l’inizio dell’impresa. Mancava un nome importante, quello di Mary Shelley, i cui racconti – alcuni dei quali, come “The Mortal Immortal” (1833) decisamente fantascientifici – con ogni probabilità non erano accessibili a Gernsback. Perché mi soffermo su questi dettagli in un intervento dedicato alla fantascienza italiana delle donne, e, in particolare, all’ultimo romanzo di Nicoletta Vallorani? Perché l’espulsione dal canone sf di una scrittrice fondamentale come Mary Shelley, l’autrice non solo di Frankenstein (1818), ma anche dell’apocalittico L’ultimo uomo (1826), ha costituito una sorta di maledizione, un curse letterario, che ha contribuito a rendere difficile l’affermazione nella narrativa fantascientifica non solo nella cultura inglese e nord-americana, ma anche nel nostro paese. Se, per quanto riguarda la fantascienza anglofona, la presenza femminile nel territorio dell’immaginario che comprende science-fiction e distopia, è ormai un fatto assodato – basterebbe pensare all’apprezzamento riservato alle opere di Ursula K. Le Guin o al successo di Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood – la situazione italiana presenta le sue asperità, complicate dall’assenza di uno spazio riconosciuto riservato al ‘genere’ (inteso come genre) fantascienza, dotato di modalità e formulazioni teoriche specifiche. Avendo avuto la fortuna di aver lavorato alla Statale di Milano, dove l’insegnamento di Letteratura Italiana Contemporanea era tenuto da Vittorio Spinazzola e da allievi e allieve come Giovanna Rosa, ricordo benissimo le indagini critiche della scuola di Spinazzola rivolte al poliziesco e al romanzo rosa, ma non potevo ignorare una certa diffidenza nei confronti della fantascienza sia in generale, sia nel contesto italiano. Peraltro, se vogliamo aggiornare queste considerazioni, segnalo che durante il Festival della Fantascienza tenutosi a Trieste tra il 28 ottobre e il 2 novembre dell’anno scorso il Premio letterario Mondofuturo ha visto come finalisti tre scrittori di fantascienza, tra i quali emerge Luca Giommoni con il suo Nero, che meriterebbe un discorso a parte, malgrado nella giuria fosse presente una autorevole rappresentanza femminile, composta da Loredana Lipperini, Giulia Martino e Nicoletta Vallorani. Evidentemente, le poche opere delle scrittrici iscritte al concorso non erano meritevoli di essere prese in considerazione. È curioso notare che una delle scrittrici italiane che riscuotono un notevole successo, Licia Troisi, la quale, tra l’altro, rarissima avis, gode di una formazione scientifica nell’ambito dell’astrofisica, ha preferito dedicarsi a elaborate saghe fantasy.
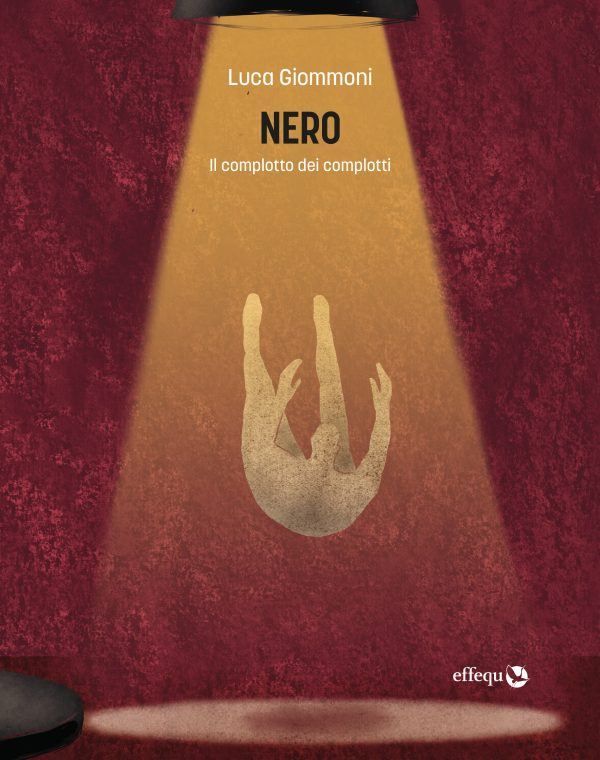
La ridotta presenza femminile, risalente al ‘trapianto’ nel nostro paese della narrativa sf, è confermata da chi si è occupato delle origini della fantascienza made in Italy, a partire da Vittorio Curtoni (Le frontiere dell’ignoto. Vent’anni di fantascienza italiana, 1977) per finire con i recenti e informatissimi studi di Giulia Iannuzzi, tra cui segnalo Fantascienza italiana. Riviste, autori, dibattiti (2014). In realtà, a ben guardare, due personalità di scrittrici e intellettuali di spicco vanno ricordate. La prima è Roberta Rambelli (1928-1996), impegnata nell’editoria specializzata soprattutto con La Tribuna di Piacenza e con le riviste Galaxy (edizione italiana) e Galassia, che fu anche traduttrice eccellente e prolifica romanziera, attenta alle convenzioni del genere, nascondendosi sotto i più disparati pseudonimi anglicizzanti, dal trasparente Robert Rainbell al vistoso Hunk Hannover. La sua eredità di operatrice culturale è stata raccolta in tempi recenti dalla casa editrice bolognese Elara, diretta da Armando Corridore.
Il secondo esempio è quello di Gilda Musa (1926-1999), fine poetessa, che trasferisce nella prosa dei suoi romanzi di fantascienza, pubblicati per lo più negli anni ’70 del secolo scorso, le sue preoccupazioni per la precarietà della condizione femminile (Esperimento donna, 1979) . Nel caso di Musa, non si può trascurare il suo sodalizio sentimentale con Inìsero Cremaschi, che sarebbe stato tra i più convinti sostenitori di una ‘via italiana’ alla fantascienza. Rammento, in quei tempi ormai lontani, il mio atteggiamento di anglista e americanista un po’ schizzinoso nei confronti di questa materia. Oggi riconosco volentieri che avrei dovuto essere meno ostile, anche se, a mo’ di giustificazione postuma, ero preoccupato da una certa deriva patriottica e nazionalistica che rischiava di immeschinire, a mio parere, il dibattito in corso, ma che non riguardava né Rambelli, né Cremaschi e Musa.

Ad ogni modo, prima che la fantascienza delle donne decollasse in Italia, saremmo dovuti arrivare alla fine degli anni ‘80, quando La Tartaruga, la casa editrice femminista di Laura Lepetit, avrebbe lanciato, servendosi della competenza di Oriana Palusci, “La Tartaruga blu”, una collana dedicata alla sf femminile, non solo italiana, ma aperta alle proposte di Lisa Morpurgo e di Daniela Piegai. In effetti, “La Tartaruga blu” ci ha lasciato in tutto quattro titoli, a conferma che neppure il suo reading public, fatto perlopiù di intellettuali, nutriva un grande entusiasmo per una narrativa di confine. Tuttavia, almeno Daniela Piegai, nata nel 1948, l’autrice di Il mondo non è nostro (1989) e di Parola di alieno (1998), avrebbe proseguito una più che onorevole carriera fantascientifica, tanto da risultare in attività ancora oggi. Le novità più rilevanti avevano luogo altrove: il Premio Urania, da poco costituito, viene assegnato nel 1992 a Nicoletta Vallorani per Il cuore finto di DR (pubblicato tra i Romanzi di Urania il 3 ottobre 1993). Pur debitrice nei confronti di Philip K. Dick – e forse ancora di più di Blade Runner – nel suo esordio narrativo Vallorani accentua una prospettiva al femminile che diverrà poi uno dei suoi esiti più efficaci, ed evoca un convincente e angoscioso paesaggio urbano, che è quello di Milano, presso la cui Università Statale la scrittrice insegna letteratura e cultura inglese. Ci troviamo quindi di fronte a una personalità completa, capace di muoversi in molte direzioni, che è in grado di esplorare il territorio intermedio tra la fantascienza e il noir, come succede in Eva, il romanzo pubblicato nel 2002 nella collana einaudiana “Stile Libero”. La prosa di Vallorani non esclude intensi spunti autobiografici, che si traducono spesso nella rappresentazione di identità femminili scisse o sdoppiate (Le madri cattive, 2011), appoggiandosi a una prosa fluida, carica di tensioni emotive, e resa più densa dall’allusività delle citazioni letterarie. L’ultima prova narrativa di Vallorani, Ogni cosa e nessuna (Zona 42, 2025), amplia ulteriormente lo spazio narrativo della distopia illuminando di luce livida una città che non è più solo Milano, in cui le donne sono ridotte a vittime degli abusi maschili, a uteri dati in prestito, a relitti abbandonati a se stessi. Tra le strade pericolose e desolate vaga la protagonista, Giuditta detta Giuda, svolgendo il ruolo di “consolante”, una sorta di fabulatrice che ha il compito di rendere meno dura la vita – o, piuttosto, la morte – delle partorienti, le donne spietatamente eliminate quando non possono più assolvere alla loro funzione riproduttiva. In quanto agli uomini, essi appaiono sostanzialmente come brutali figure patriarcali o, nella seconda trama che costituisce il romanzo, come tronfi e ingenui manichini, anche quando, come nel caso di Perseo e Giasone, vengono celebrati per il loro presunto eroismo. Gli echi di Il racconto dell’ancella di Atwood sono evidenti, e rinviano ad altre distopie al femminile, come I figli degli uomini di P. D. James, senza trascurare le teorie sul volo coordinato degli storni compiuti dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. In più, Ogni cosa e nessuna si affida a un più ambizioso tessuto mitologico, grazie all’introduzione di un secondo livello narrativo. Qui, la voce della mostruosa Medusa dai capelli serpentini – forse uno dei personaggi creati dalla “consolante” Giuditta? – riscrive la leggenda che la vuole sconfitta e decapitata da Perseo e racconta di un viaggio nel tempo, a contatto con eventi drammatici che riguardano di solito le donne. Un’aliena mutaforme proveniente da un altro mondo, che visita anche la Milano a noi contemporanea (“In metropolitana tra Loreto e Porta Venezia, mi vedo riflessa, nella forma che mi appartiene qui”), Medusa è in grado di assistere all’angoscia e al dolore delle donne perseguitate di ogni epoca, e talvolta di intervenire a loro difesa. Lascio a lettrici e lettori le complicazioni di un intreccio volutamente sfilacciato da un linguaggio fluido, che rifiuta l’organizzazione ben strutturata del racconto. Non a caso, all’inizio di quello che mi sembra il capitolo più coinvolgente, “Nazeelet”, Medusa, che ha preso il nome di Masha, afferma di essere “una donna, ancora, in cerca di un senso”, aggiungendo: “La mia risorsa è non essere umana. La vostra pena è essere umani e come tali propensi a procurarvi sempre il peggiore dei mondi possibili.” Di fatto, il capitolo culmina in un dolente elenco di donne almeno in parte musulmane (iraniane?), rinchiuse e perseguitate perché reclamano il diritto alla libertà. Da Ogni cosa e nessuna emerge, insomma, una visione sconsolata della condizione femminile, nel passato più remoto, nel nostro crudele presente, in un agonizzante futuro apocalittico, sebbene l’evocazione di figure come Giuditta e Medusa sembri lasciare uno spiraglio alla speranza della ribellione. Proprio perché, spingendosi molto al di là delle formule più consuete della fantascienza/distopia, la ricerca narrativa di Vallorani mi sembra un unicum nel nostro paese, mi sento di esprimere qualche perplessità sull’apparato paratestuale “Le parole del dopo”, che costituisce una sorta di post-fazione di Ogni cosa e nessuna. Non mi preoccupa l’inevitabile presenza dell’ideologia nel testo letterario, anche perché l’ideologia viene assorbita – e spesso rimodellata – dal gioco narrativo o poetico, che mette in luce scarti e contraddizioni. Sono più sospettoso riguardo alle dichiarazioni ‘politiche’ che l’autore esplicita a latere, ovvero al di fuori, del testo, come accade in “Le parole del dopo.”
Una certa affinità, sia pure più incline alla parodia e al grottesco, con la literary (science-)fiction di Vallorani, è riscontrabile nella dimensione metanarrativa presente in Fiore d’agave, fiore di scimmia di Irene Chias (Laurana 2020), in cui compare il personaggio di una scrittrice di fantascienza, mentre la trama si muove tra riferimenti espliciti alla tradizione distopica e la rivisitazione del paesaggio nativo dell’autrice, in questo caso la Sicilia.
Infine, anche se la fantascienza delle donne continua a faticare un po’ per imporsi in Italia, possiamo vantare sul versante femminile un panorama critico di tutto rispetto, come, del resto, confermano anche gli studi di Vallorani su Le Guin e Tiptree. Nel recente convegno napoletano “Per una storia critica dell’Intelligenza Artificiale” (8/9 gennaio 2026), le partecipanti al panel dedicato al romanzo e al cinema di fantascienza erano quattro (su cinque interventi): Emanuela Bufacchi (l’organizzatrice del Convegno), Oriana Palusci, la decana degli studi italiani sulla sf delle donne, Natascia Villani, ed Emanuela Piga Bruni, a cui si deve lo studio La macchina fragile. L’inconscio artificiale fra letteratura, cinema e televisione (Carocci 2022). Not too bad, direbbero gli inglesi.
Leggi anche:
Carlo Pagetti | tutti gli articoli
Nicoletta Vallorani | tutti gli articoli







