Noi, la fantascienza e la bomba atomica
Al recente Festival del Cinema di Venezia Kathryn Bigelow, una veterana dei film di guerra, ha presentato A House of Dynamite, basato sulla risposta americana a un attacco nucleare. Date le tensioni internazionali e i bombardamenti effettuati da Stati Uniti e Israele sui siti nucleari dell’Iran, il cinema sulla bomba atomica e sull’arrivo dell’apocalisse è tornato in auge, in qualche modo anticipato da Oppenheimer di Christopher Nolan, incentrato sulla figura contraddittoria del maggiore responsabile del Progetto Manhattan. Soprattutto negli anni ’60 del secolo scorso il cinema americano ci aveva dato alcune ottime prove su queste problematiche, a cominciare da Fail Safe di Sidney Lumet e dal Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, entrambi sul grande schermo nel 1964. Non trascurerei neppure, circa vent’anni dopo, The Day After per la regia di Nicholas Meyer, un film girato per il canale televisivo ABC nel 1983, fornito di un notevole realismo, che culmina in una scena tragica in cui il protagonista, Jason Robards, incontra un vecchio amico tra le macerie di Kansas City e piange con lui la distruzione del mondo, come fanno in Shakespeare Re Lear e l’antico consigliere Gloucester dopo essere stati espulsi dal palazzo del potere.
Poco più di 80 anni fa, il 6 e il 9 agosto 1945, gli Stati Uniti sganciarono su due città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki, un ordigno nucleare, radendole al suolo, per costringere i nemici alla resa, dopo che erano state calcolate le perdite spaventose che avrebbero subito le due nazioni belligeranti, nel caso che il Giappone avesse difeso dall’inevitabile invasione – come aveva dichiarato – il suolo della patria, spiaggia per spiaggia, isola per isola. La voce sacra dell’Imperatore Hirohito, ascoltata alla radio per la prima volta dai suoi sudditi, annunciò la resa del Giappone il 15 agosto, invocando (un po’ ipocritamente) il bene dell’umanità, che mai più avrebbe dovuto conoscere il terrore dell’olocausto nucleare.
A quei tempi, del progetto Manhattan e delle conseguenze devastanti dell’attacco nucleare l’opinione pubblica sapeva ben poco. Uno dei primi commenti ricchi di annotazioni intelligenti, sebbene l’autore ammettesse di avere scarse conoscenze scientifiche, appartiene a George Orwell, che in “You and the Atom Bomb”, pubblicato su Tribune il 19 ottobre 1945, ipotizza una serie di scenari futuri, a seconda che la bomba diventi un’arma ‘comune’ o rimanga monopolio delle superpotenze. Si ricorderà che in 1984 (1949), uno degli eventi che hanno cambiato radicalmente la storia dell’Inghilterra, indirizzandola verso la dittatura del Grande Fratello, è l’esplosione di una bomba atomica su Colchester.
Della scissione dell’atomo e dell’uso di ordigni atomici si parlava ben prima della seconda guerra mondiale. Già nel 1914 H.G. Wells aveva prefigurato una guerra avveniristica combattuta a colpi di armi nucleari in The World Set Free, in cui si parla di radioattività e di energia atomica. In Italia questo romanzo non privo di risvolti profetici fu pubblicato nel 1981 nella collana dell’editore Mursia dedicata a Wells con il titolo La liberazione del mondo. Una sua nuova versione sarebbe auspicabile. Vale la pena ricordare, comunque, che negli anni ’20 e all’inizio degli anni ’30 l’approccio di Wells, che insisteva sugli sviluppi della ricerca nel campo della fisica, venne considerato obsoleto, essendo superato dagli sviluppi più recenti della biologia e della genetica, che infatti ispirarono Il mondo nuovo di Aldous Huxley (1932). Ma la storia dei libri è spesso curiosa, imprevedibile: sempre nel 1932 – raccontano i cronisti della fantascienza – Leo Szilard, che avrebbe preso parte al progetto Manhattan, rimane colpito dalla lettura di The World Set Free. In quello stesso anno, viene ‘scoperto’ il neutrone.
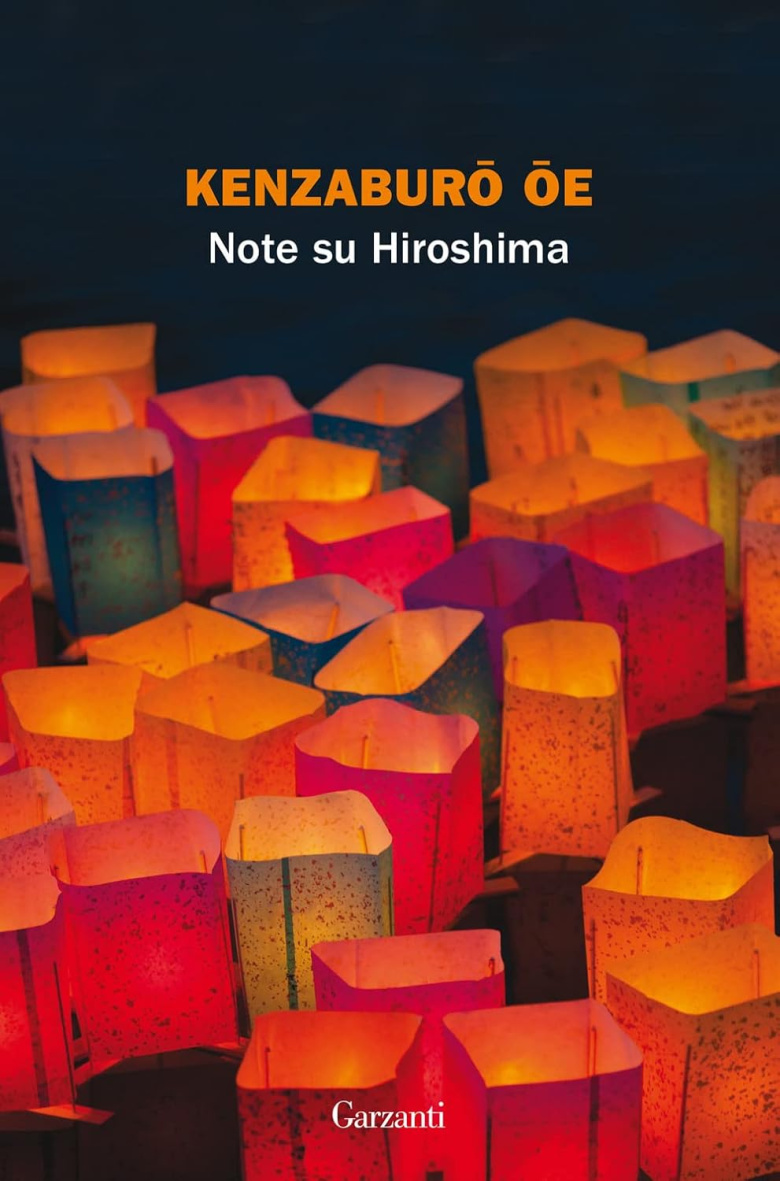
Naturalmente la fantascienza, soprattutto quella americana, non ha mancato di sottolineare, per la gioia dei suoi fan più accaniti, il potere predittivo del genere SF. L’esempio maggiore di questa vera o presunta capacità profetica risiede in alcuni racconti scritti da Robert A. Heinlein all’inizio di una brillante carriera. Nel più citato di essi, “Solution Unsatisfactory”, firmato con lo pseudonimo di Anson MacDonald, e uscito su Astounding Science-Fiction nel maggio del 1941, l’invenzione di una “polvere radioattiva” viene usata in Europa dopo lo sbarco alleato in Francia con risultati micidiali. D’altra parte, nello stesso periodo, un altro giovane autore di grande successo, A.E. Van Vogt, attrezza le sue astronavi in volo nel cosmo con “motori atomici”, riflettendo un atteggiamento vagamente utopico che era condiviso da alcuni partecipanti al progetto Manhattan, e che venne diffuso da William L. Laurence, il giornalista specialista di questioni scientifiche del New York Times, accreditato presso il Progetto Manhattan. Secondo Laurence, che però si guardò bene dallo scrivere sugli effetti delle radiazioni nucleari, l’applicazione dell’energia atomica ai più diversi aspetti della vita sociale avrebbe consentito l’arrivo di un’epoca di prosperità e di progresso su vasta scala. Solo in seguito sarebbe emersa la condizione degli hibakusha, i superstiti dei due attacchi nucleari sul Giappone, che erano affetti da numerose malattie, dalla leucemia al cancro, dal glaucoma alle lesioni della pelle, i cosiddetti cheloidi, che deturpavano in modo irrimediabile il corpo soprattutto dei giovani e delle donne. Uno dei primi resoconti, risalenti agli anni ‘60, che esplorano questo panorama angoscioso, riproposto di recente dal “Corriere della Sera”, nell’edizione Garzanti, è Note su Hiroshima del premio Nobel per la letteratura Kenzaburo Oe. Solo nel 2024 il Premio Nobel per la pace è stato attribuito a una organizzazione umanitaria giapponese che si occupa degli hibakusha e dei loro discendenti.
Molto opportunamente, in contemporanea, la UTET ha ripubblicato nell’ottantesimo anniversario dell’olocausto atomico Hiroshima, la narrazione dello scrittore americano John Hersey, apparsa in origine sul New Yorker nell’agosto 1946. È all’enorme popolarità di questo reportage, apparso infinite volte in volume, che dobbiamo la diffusione di una conoscenza più diretta delle conseguenze del primo e più devastante attacco atomico. L’edizione della UTET aggiunge il sottotitolo “Il racconto di sei sopravvissuti”, che è tecnicamente corretto, anche se circoscrive un po’ la portata dell’esperienza rievocata un anno dopo da Hersey. È vero che Hersey si concentra su sei testimonianze e che esse non pretendono certo di essere rappresentative della composizione di una popolazione di centinaia di migliaia di abitanti: quattro voci su sei sono maschili, e due su sei appartengono a religiosi cristiani (un sacerdote metodista e un gesuita). Ma l’abilità dello scrittore coglie in pieno lo smarrimento individuale nel momento dell’impatto apocalittico e il senso immediato della devastazione circostante, che a poco a poco si trasforma in conoscenza di quanto è successo a un’intera città, sbriciolata e avvolta dalle fiamme. Solo il movimento successivo di alcuni dei testimoni, che vagano tra le rovine, scopre a poco a poco uno scenario immane fatto di carni straziate e di indicibili sofferenze fisiche, raccontato da Hersey senza la minima concessione retorica. Basterà pensare allo spettacolo dell’Asano Park, percorso da creature deformi e bruciate, e attraversato da un fiume su cui galleggiano masse di cadaveri. Nessuno sa quello che è accaduto e presto cominceranno a farsi strada le ipotesi più stravaganti. Dopo qualche giorno, partono i primi soccorsi, ma Hiroshima rimane un cumulo sterminato di macerie, mentre dalla sua terra riarsa spuntano fiori dagli strani colori , a prefigurare un irreversibile mutamento nella percezione della realtà e della natura.
A livello letterario, e all’interno della cultura americana, tra le tante conseguenze di Hiroshima e di Nagasaki vi è anche un radicale ri-orientamento di tutto il genere SF, che del resto verrà rafforzato dall’approssimarsi dell’”età dell’ansia”, dominata dalle ossessioni della Guerra Fredda e dalle notizie sempre più allarmanti sul potenziale nucleare dell’Unione Sovietica. Quasi quarant’anni dopo, uno dei maggiori autori di fantascienza, l’inglese J.G. Ballard, riuscirà a dare una qualità visionaria all’attacco atomico su Hiroshima nel romanzo autobiografico L’impero del sole (The Empire of the Sun, 1984), immaginando che Jim, il suo giovane alter-ego, prigioniero a Lunghua, un campo di concentramento giapponese vicino a Shanghai, venga abbagliato improvvisamente da “un lampo di luce […] come se un’immensa bomba americana fosse esplosa da qualche parte a nord-ovest di Shanghai.” In uno dei saggi biografici apparsi successivamente in La gentilezza delle donne (The Kindness of Women 1991), Ballard ammette che, senza la fine repentina della guerra causata dal lancio delle atomiche americane, i prigionieri del campo di Lunghua sarebbero stati probabilmente uccisi dai giapponesi in ritirata.
In ogni caso, gli scenari nucleari e post-nucleari si moltiplicano nella fantascienza americana post-bellica. Dal momento che questo intervento non ha l’obiettivo di essere esaustivo o compilativo, pur non dimenticando che la rappresentazione dell’apocalisse atomica coinvolge scrittori come Ray Bradbury e Philip K. Dick, mi limito a due esempi estremamente significativi, anche perché segnalano da una parte il tentativo di raccontare in modo realistico e psicologicamente attendibile l’arrivo della Bomba (Merril), dall’altra parte il ricorso a tecniche narrative più vicine alla tradizione del romance, ma anche a una sensibilità postmoderna (Vonnegut).
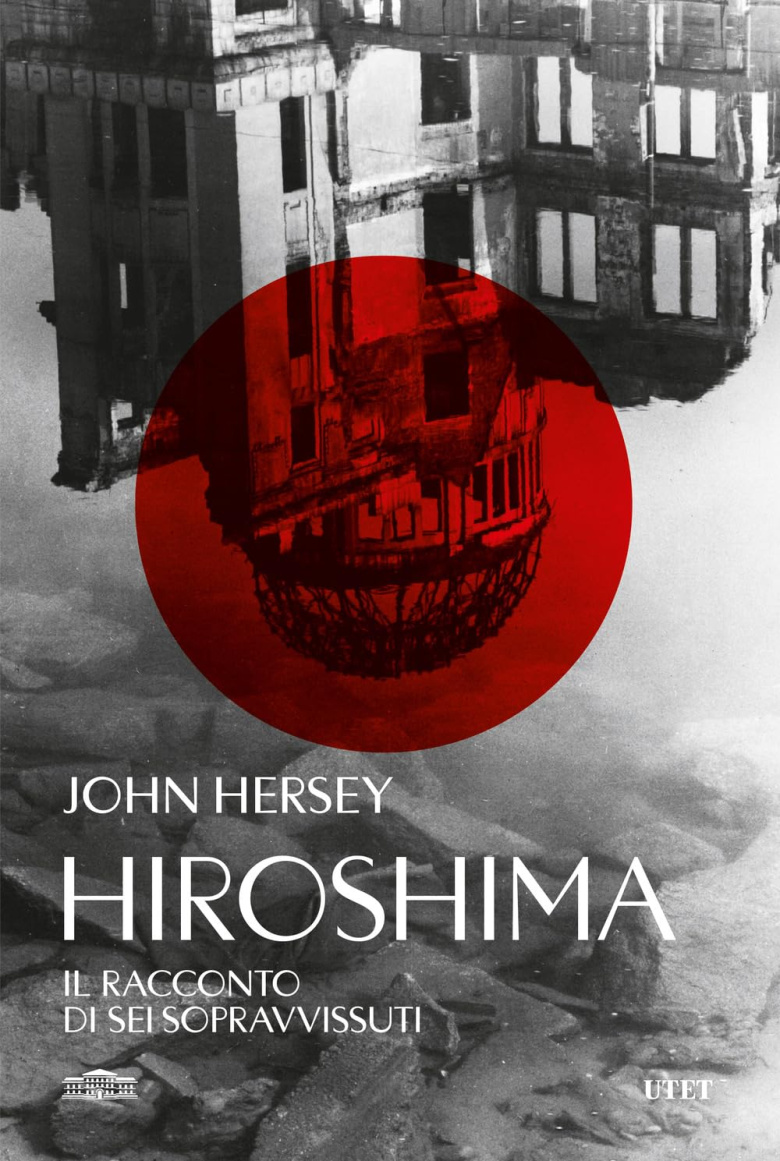
L’1 gennaio 1950 Judith Merril pubblica con Doubleday, una casa editrice importante di New York, Shadow on the Hearth , ovvero L’ombra sul focolare, che, con un tocco quasi dickensiano, rende l’idea della dimensione domestica del racconto. In Italia il romanzo di Merril diviene Orrore su Manhattan nel n.134 di “Urania” (13.9.56). La Merril, che ha avuto un peso rilevante nella storia della fantascienza negli Stati Uniti e poi in Canada, ambienta la sua vicenda in una casa borghese situata in un sobborgo di New York. Sembra una giornata come un’altra, ma su Manhattan, dove il capofamiglia si è recato a lavorare, esplode una bomba atomica. Sembra un anticipo dell’11 settembre, con conseguenze assai più vaste. Tutto cambia improvvisamente, e la protagonista dovrà cavarsela, senza avere alcuna notizia sulla sorte del marito, con i figli e con i vicini, in circostanze che si fanno, con il passare del tempo, sempre più minacciose, anche perché l’acqua è inquinata e il tessuto sociale si disintegra. A mio parere, questo romanzo andrebbe riletto come un sia pur cauto tentativo di radicare sul suolo americano situazioni che i lettori di Hersey avevano conosciuto in un territorio ben lontano, e, nello stesso tempo, come un discorso che valorizza la condizione femminile, capace di far fronte al più drammatico degli imprevisti.
Sul versante della scrittura post-moderna è inevitabile citare Ghiaccio-Nove (Cat’s Cradle, 1963) di Kurt Vonnegut, jr. Qui il linguaggio ironico, continuamente spezzettato e ricco di citazioni (si comincia con l’incipit di MobyDick) di Vonnegut, costruisce una favola nera sull’irresponsabilità del genio scientifico e sulla casualità degli eventi umani. La prodigiosa sostanza chimica ‘ghiaccio-nove’, sfuggita al controllo del suo creatore, finisce in mare, dove produrrà una distesa di ghiaccio destinata ad avvolgere l’intero pianeta in una stretta mortale. Divisa tra la verisimiglianza del novel e il romance sperimentale, la fantascienza americana (e non solo) gioca su diversi livelli narrativi, esaltando uno spessore immaginativo che, alla fine, appartiene a tutta la letteratura significativa.
A conferma delle potenzialità della science-fiction, non può mancare in questo quadro succinto neppure il contributo dell’ucronia, la storia alternativa o contro fattuale, che consente, secondo i casi, esiti utopici o distopici. È giusto menzionare il racconto lungo di Kim Stanley Robinson, The Lucky Strike (1984). Torniamo ai giorni cruciali che precedono il lancio della bomba atomica su Hiroshima. L’Enola Gay, il bombardiere destinato a trasportare l’ordigno nucleare, deve essere sostituito, ma il comandante del secondo apparecchio non ha intenzione di compiere un genocidio e ritiene che una dimostrazione meno sanguinosa della potenza della nuova arma sia sufficiente. Pagherà con la vita il ‘tradimento’ della sua missione di morte, ma forse un nuovo mondo utopico sta per nascere.
Forse, la cosa migliore che nel 2025 si è vista in Italia, o almeno a Milano, riguardo all’apocalisse nucleare del 1945 è stata la mostra Icarus dedicata alle istallazioni di Yukinori Yanagi tenutasi presso l’Hangar Bicocca dal 27 marzo al 27 luglio. Al suo ingresso si erge “Project God-zilla 2025”, un enorme cumulo di macerie, tra cui campeggiano i relitti di una imbarcazione, di varie automobili, di altri materiali, e alcuni sacchi pieni di sabbia. Al centro si colloca un’iride gialla-arancione, l’occhio di Godzilla, il mostro generato dalle radiazioni nucleari negli anni ’50, che trasferisce nella cultura popolare contemporanea gli incubi dell’olocausto del 1945, rinnovati dal disastro ecologico provocato dalla centrale nucleare di Fukushima nel marzo 2011, quando, come ha dichiarato l’artista, “nella ripresa cinematografica dell’11 marzo 2011 si aveva l’impressione di guardare Godzilla che si spingeva fino alla riva. Era come se la tecnologia nucleare e i morti della seconda guerra mondiale sorgessero in rivolta.”
Leggi anche
Marco Belpoliti, Nagasaki, Papa Francesco, Yamahata
Yosuke Taki, Sognando l'atomo
Giuseppe Previtali, Le icone di Hiroshima
Arianna Salatino, Abbiamo davvero già visto Hiroshima?
Claudio Castellacci, Hiroshima: il peso di non sapere
Laura Testaverde, Un Nobel contro l'atomica
Anna Maria Mariani, La bomba atomica e la sindrome del bystander
In copertina, opera di Yukinori Yanagi, Project God-zilla, 2025.







