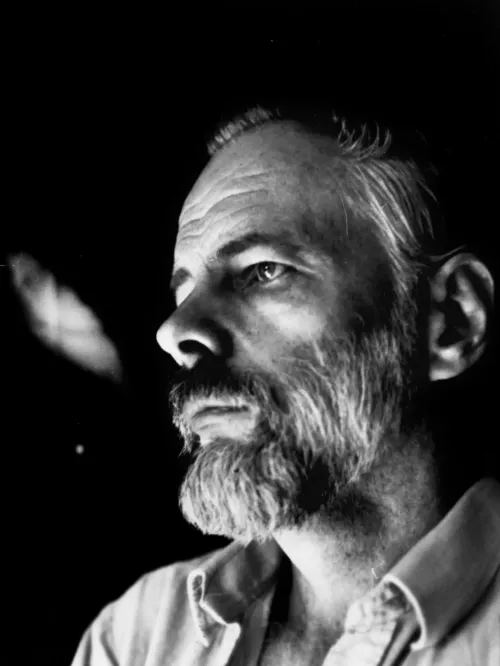La canonizzazione tardiva di P.K. Dick
I lettori che seguono da molti anni la narrativa di Philip K. Dick ricorderanno che nella cittadina americana ricostruita su misura per il protagonista Ragle Gumm, che è al centro di Time out of Joint (Tempo fuor di luogo, 1959), esiste una sorta di crepa stradale, umidiccia e minacciata da nuovi crolli (“The Ruins”), da cui emergono curiosi materiali, tra cui una rivista illustrata nelle cui pagine si esibisce lo splendido corpo di una figura femminile sconosciuta: Marilyn Monroe. Dal momento che il titolo del romanzo di Dick è l’esplicita citazione di una delle battute più famose dell’Amleto shakespeariano (e infatti “Tempo fuor di sesto” sarebbe forse una resa più allusiva), partecipiamo anche noi al gioco di PKD e immaginiamoci che Ragle Gumm non sia quel poveraccio che è, ospitato in casa della sorella sposata, un buono a nulla che passa la sua vita a risolvere giochi a premi, ma – diciamo per dire – un raffinato intellettuale che scopre tra i libri polverosi accatastati su una bancarella un romanzo intitolato Time Out of Joint di Philip K. Dick. Ipotizziamo, insomma, che questo intellettuale sia molto più vicino all’Amleto di Shakespeare (il quale peraltro era in grado di ricoprire vari ruoli, tra cui quello del fool) dell’inconsapevole provinciale americano manovrato da un potere occulto che si serve spietatamente di lui. L’intellettuale in questione sfoglia le pagine stropicciate del paperback e si accorge di avere tra me le mani un capolavoro. “Caspita!” Esclama. “Ma questo sconosciuto signore va valorizzato, collocato in una collana di prestigio, tanto più per il prezzo proibitivo dei suoi volumi. Ci penso io.” Ghe pensi mi, come si diceva una volta in una lingua ormai perduta come il milanese. Siccome è una persona scrupolosa, fa una piccola ricerca bibliografica nella sua lingua, coinvolge un illustre letterato francese, che molti anni prima ha scritto un’autobiografia molto personale dell’autore, avendo avuto la fortuna di incontrare negli Stati Uniti una delle vedove di Philip K. Dick, la più colta e sensibile, Anne Williams Rubinstein, e raccoglie in due grossi tomi alcuni dei romanzi di PKD, diciamo i più noti, arricchendoli di vari apparati bio-bibliografici, e accogliendo il plauso sperticato di altri nomi di primo piano, che si scoprono da sempre appassionati di PKD e che inneggiano al suo “postmodernismo” e quant’altro di più postmoderno, straordinario, sconvolgente si possa concepire.
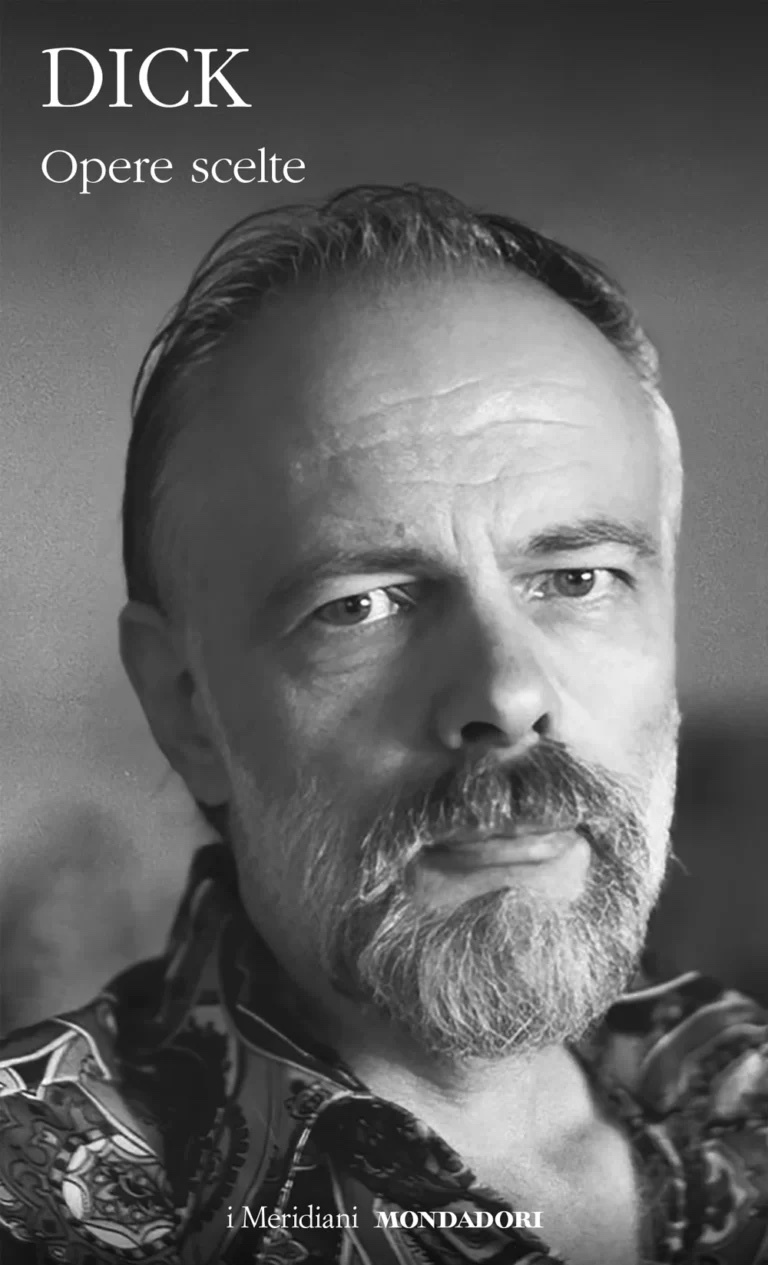
A questo punto, occorre però che anch’io scenda per qualche riga sul piano autobiografico e metta in guardia i lettori… da me stesso. Nelle maggiori riviste letterarie americane e inglesi, come The New York Review of Books e il Times Literary Supplement, è invalsa un’ottima abitudine: quando chi recensisce ha un qualche coinvolgimento personale nell’opera di cui si occupa, egli/ella deve esplicitare questo aspetto che, naturalmente, potrebbe invalidare, o almeno influenzare, il suo approccio critico. Devo, dunque, confessare di essermi occupato di Philip K. Dick almeno dagli anni ’70 del secolo scorso, prima con l’Editrice Nord di Gianfanco Viviani, poi con Sergio Fanucci. Nel primo caso, una mia introduzione a Noi Marziani, incentrata su PKD e la fantascienza come meta-romanzo, fu generosamente intercettata da Darko Suvin, l’autore delle Metamorfosi della fantascienza, in Italia pubblicato da Il Mulino, e trasformata in uno degli interventi che compongono il numero unico di Science-Fiction Studies, uscito nel marzo 1975 (dunque esattamente cinquant’anni fa) su PKD. A quel numero, curato da Suvin, partecipavano fior di studiosi come Fredric Jameson, e di autori di fantascienza come Brian Aldiss e Stanislaw Lem. Non c’è dubbio che il lungo e ricco percorso della critica dickiana cominci da lì. Per quanto riguarda Fanucci, dal 2000 e per una quindicina d’anni, ho scritto un’introduzione a ognuno dei romanzi di PKD, pubblicati periodicamente dall’editore romano e confluiti nella “Collezione Dick”. “Ah!” Esclameranno i lettori che si sono sforzati di seguirmi fin qui, “Bella roba! Ma allora tu c’hai il dente avvelenato!” Fino a un certo punto, dal momento che nel 2022 gli Oscar Mondadori – e di ciò sarò sempre grato a Elisabetta Risari – hanno raccolto in un grosso volume intitolato Il mondo secondo P.K. Dick una trentina di mie introduzioni dickiane accanto a materiali critici più recenti. A proposito di organizzazione critica, non vi è dubbio che la Bibliografia che chiude il secondo volume dei Meridiani sia ampia e ben disposta, ma avrei qualche riserva sull’utilizzo dell’ordine alfabetico puro e semplice, che finisce per mettere sullo stesso piano l’articoletto di un quotidiano, la monografia di Rossi The Twisted Worlds of Philip K. Dick (2011), o la mia raccolta di introduzioni.
Per i motivi qui esposti, non ritengo di poter compiere una ricognizione circostanziata di recensione dei Meridiani dickiani. Mi limito a condividere le osservazioni di Nicoletta Vallorani già apparse su “Doppiozero”. Sono assolutamente d’accordo con lei che la cosiddetta “marginalità” della fantascienza è un valore aggiunto, e che non si può artificialmente estrarre dal corpo (purulento?) di un genere come la detective story o la fantascienza Agatha Christie o Philip K. Dick, per elevarli nell’empireo di una presunta ‘letteratura alta’ o ‘di qualità’, ormai – e forse sempre – costruito da critici e professori universitari come se si trattasse di salvare le mura di Roma dall’invasione dei barbari. Nella cultura inglese e in quella americana i barbari “non privi d’ingegno” (come diceva il neoclassico Voltaire dell’autore di Amleto) hanno sempre banchettato nel palazzo dell’Imperatore: da Shakespeare a Dickens, da Poe a Melville e a Mark Twain.
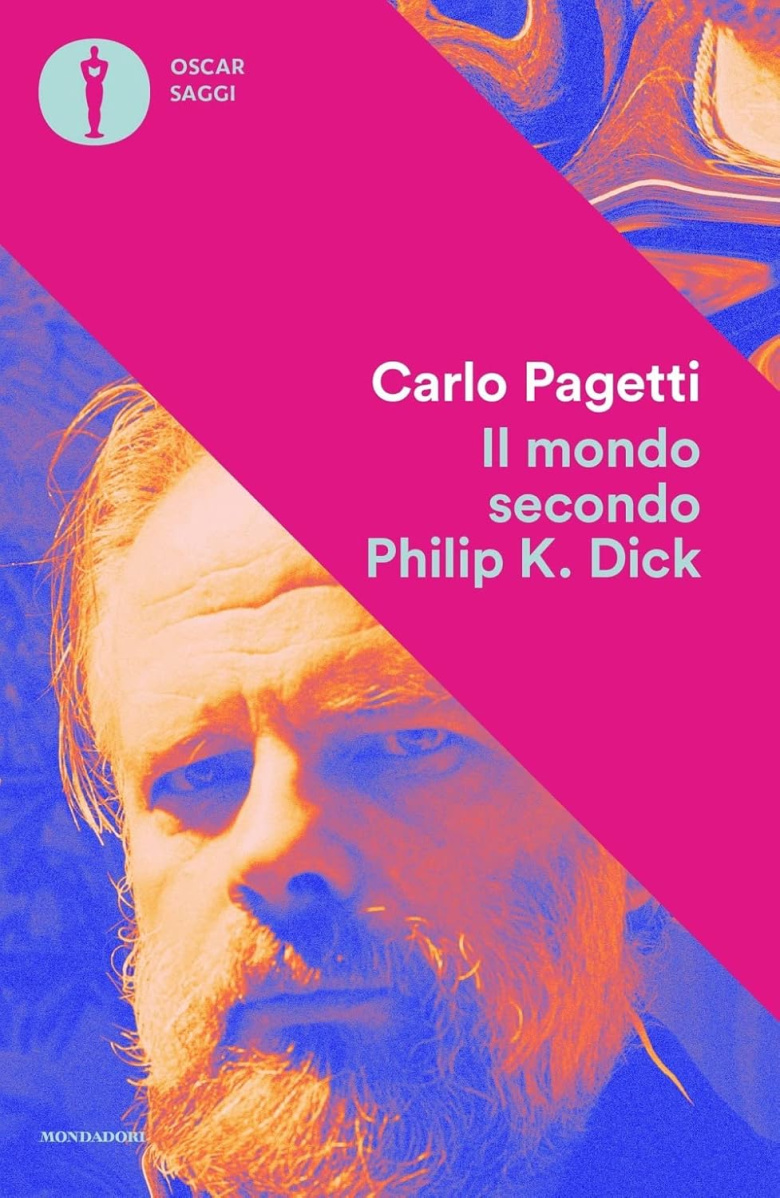
Mi limito ad osservare che, se nel “Profilo” introduttivo ai due volumi dei Meridiani qualche riferimento critico esiste, esso riguarda sostanzialmente opere uscite in Italia. Fa piacere che qualche lode venga giustamente attribuita a Umberto Rossi, di cui però viene trascurata la già citata monografia uscita negli Stati Uniti, che è il suo lavoro critico maggiore. Altri nomi italiani sono ignorati, come quello di Gabriele Frasca (L’oscuro scrutare di PKD, 2007), o appena menzionati. La mancanza di voci femminili, anche italiane, non credo possa essere compensata dalla citazione in nota di un saggio minore di Patricia Warrick, una studiosa prolifica e articolata, su The Man in the High Castle. Per quanto riguarda Dick, benissimo le numerose citazioni dall’Esegesi (pubblicata in Italia da Fanucci), ma perché trascurare i volumi delle Lettere, mai apparsi in Italia? Soprattutto nell’ultimo periodo di vita di PKD, nel primo scampolo degli anni ’80, quando Ridley Scott stava girando Blade Runner e PKD vedeva finalmente avvicinarsi, come mai era successo in precedenza, una fama ben remunerata, le lettere di Dick assumono un’intensità disperata, interrotta da qualche attimo di spensieratezza e dalle dichiarazioni in cui viene riaffermata la volontà di voler continuare la sperimentazione fantascientifica. Ma fino in fondo PKD rimane un poveraccio come Ragle Gumm, più Yorick che il principe Amleto (che però con Yorick giocava spensieratamente da piccolo), il quale, ad esempio, in una lettera, menziona Kurt Vonnegut, come “uno dei grandi” a cui si potrebbe chiedere di spendere una buona parola per pubblicizzare i suoi romanzi. Ma lui Vonnegut non sa come raggiungerlo… Un disperato che quando, nel 1975, sembra poter emergere dall’ombra grazie al numero a lui dedicato da Science-Fiction Studies, sospetta il marxista Suvin e i suoi colleghi di essere emissari dell’Unione Sovietica, e la stessa accusa muove dissennatamente contro Stanislaw Lem (l’unico scrittore di fantascienza allora alla sua altezza), che, avendolo fatto pubblicare in polacco, gli spiega pazientemente che, se vuole riscuotere i suoi diritti, è meglio che si rechi di persona in Polonia. Ma questi sono dettagli biografici curiosi, che nulla tolgono alla grandezza di uno scrittore che si inserisce a pieno titolo nella grande tradizione americana del romance, e che crea non solo situazioni, ma anche personaggi memorabili, come nell’ucronia di L’uomo nell’alto castello, Mr. Tagomi, il funzionario inviato nella San Francisco occupata dai giapponesi, che rifiuta di consegnare agli alleati nazisti un cittadino americano di origine ebrea; o l’astronauta morente del Dr. Bloodmoney, che, ruotando attorno alla Terra devastata dall’apocalisse nucleare, manda in onda brani di musica, per allietare i superstiti. Come ho scritto più volte, PKD non è tanto o solo un post-moderno, ma un vetero-modernista, uno scrittore che crede non solo nella sperimentazione narrativa, ma anche nella persistenza di certi valori etici e nella necessità di continuare a combattere contro l’arrivo del caos, il trionfo dell’entropia, l’annientamento di ciò che rimane del sogno americano.
Non c’è da stupirsi, date le premesse, che i due volumi dei Meridiani siano – malgrado l’indiscussa qualità dei curatori – un’occasione perduta, presentando solo i romanzi più noti di PKD e trascurando opere meno conosciute, ma altrettanto valide. Aspettiamo fiduciosi un terzo volume, che comprenda Counter-Clock World, The Zap Gun, Galactic Pot-Healer. Qualche lettura supplementare non fa male a nessuno.
Leggi anche:
Nicoletta Vallorani | Philip K. Dick: un Meridiano per la fantascienza
Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick
Alberto Mittone | I mondi di Philip K. Dick
Luigi Grazioli | La nuova traduzione di “Io sono vivo, voi siete morti” / Emmanuel Carrère e Philip K. Dick