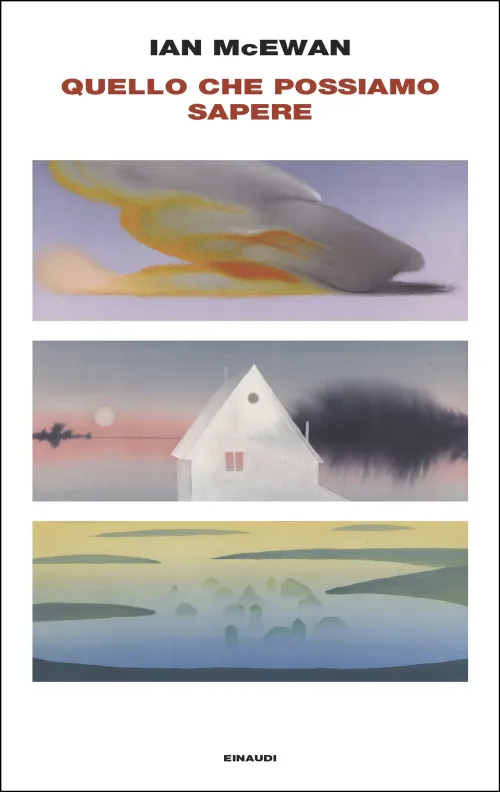Ian McEwan: fantascienza senza scienza
Al Piccolo Teatro di Milano a discutere, sotto la supervisione di Alice Strazzi della rivista Stratagemmi, con studenti e studentesse molto competenti della Statale di Milano e con i bravi attori della compagnia Sotterraneo, Il fuoco era la cura, un raffinato e ironico adattamento di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, da loro messo in scena diciotto anni dopo che Luca Ronconi aveva rielaborato lo stesso romanzo portandolo a Torino e a Milano. La fantascienza non ha una grande tradizione teatrale, ma un’eccezione è notevole: R.U.R. di Karel Capek (Praga, 1921), in cui la ribellione di esseri umani ridotti ad automi allude alla recente rivoluzione comunista in Russia. Diverso è il discorso per quello che riguarda direttamente gli scienziati e la loro spesso controversa esistenza. Chi scrive queste annotazioni ricorda di aver assistito in giovane età, nel 1963, e sempre al Piccolo di Milano, alla memorabile messa in scena della Vita di Galileo di Bertolt Brecht, per la regia di Giorgio Strehler, e con l’interpretazione di Tino Buazzelli. Alla fine del secolo, Michael Frayn, in Copenhagen, fa incontrare nella capitale danese i due fisici nucleari Niels Bohr e Werner Heisenberg, che discutono – siamo nel 1941 ̶ sull’opportunità di costruire una bomba atomica. Ma, a proposito di teatro e di fantascienza, il vero ur-text rimane, a mio parere, La tempesta di Shakespeare, recitata a corte nel novembre 1611, con Prospero nel ruolo di un mago-scienziato rinascimentale, e le creature da lui plasmate – Ariel, Caliban, la stessa Miranda – raggruppate sul palcoscenico di un’isola misteriosa che è quella mediterranea dei miti omerici, e che, nello stesso tempo, è collocata nelle Bermuda, visitate in epoca recente dai viaggiatori inglesi diretti verso le coste americane.
Fahrenheit 451 è stato definito la risposta americana a 1984 di Gorge Orwell, uscito pochi anni prima. Come 1984 il romanzo di Bradbury esalta una prospettiva umanistica, che si traduce nella necessità di conservare il potere sovversivo della letteratura e dei libri. Le riflessioni di Orwell e di Hanna Arendt ci hanno insegnato che tutti i regimi totalitari cercano di cancellare o di manipolare i testi letterari, per rimodellare a loro piacimento il passato. A ben vedere, all’inizio degli anni ’50 non era neppure così lontano il 10 maggio 1933, il giorno in cui, a Berlino, i sostenitori del nazismo avevano dato fuoco a pile di libri scritti da autori a loro sgraditi. Gli stati totalitari o contaminati dal morbo dell’autoritarismo del secondo dopoguerra avrebbero usato sistemi più subdoli, basandosi sia sulle tecnologie avanzate che eliminano il supporto cartaceo, sia su ideologie che, rinunciando al ruolo dell’interpretazione critica e della ricerca storica, preferiscono abolire le narrazioni di un passato sgradito per i più diversi motivi. È molto più semplice cancellare i termini Negro e Nigger, usati da Mark Twain, ma ancora in vigore, anche nel linguaggio letterario, per tutta la prima metà del Novecento, che spiegare che carico di razzismo, di sopraffazioni e di violenze identitarie quei termini portino con sé.
Ad ogni modo, per tornare a Orwell e a Bradbury, ma anche ad Aldous Huxley (sebbene, in Il mondo nuovo, il librone delle opere di Shakespeare, esibito da John il Selvaggio, si dimostri un’arma del tutto inadeguata per contrastare il dominio della programmazione biologica) nella fantascienza e nelle sue varianti distopiche c’è una forte vocazione umanistica, che viene opposta all’avanzata inesorabile delle macchine e dei loro artefici. Questo atteggiamento si accompagna a una difesa convinta delle radici letterarie da cui l’autore trae la sua visione del mondo, e a una diffidenza innata nei confronti del progresso scientifico-tecnologico e dei suoi linguaggi specialistici.
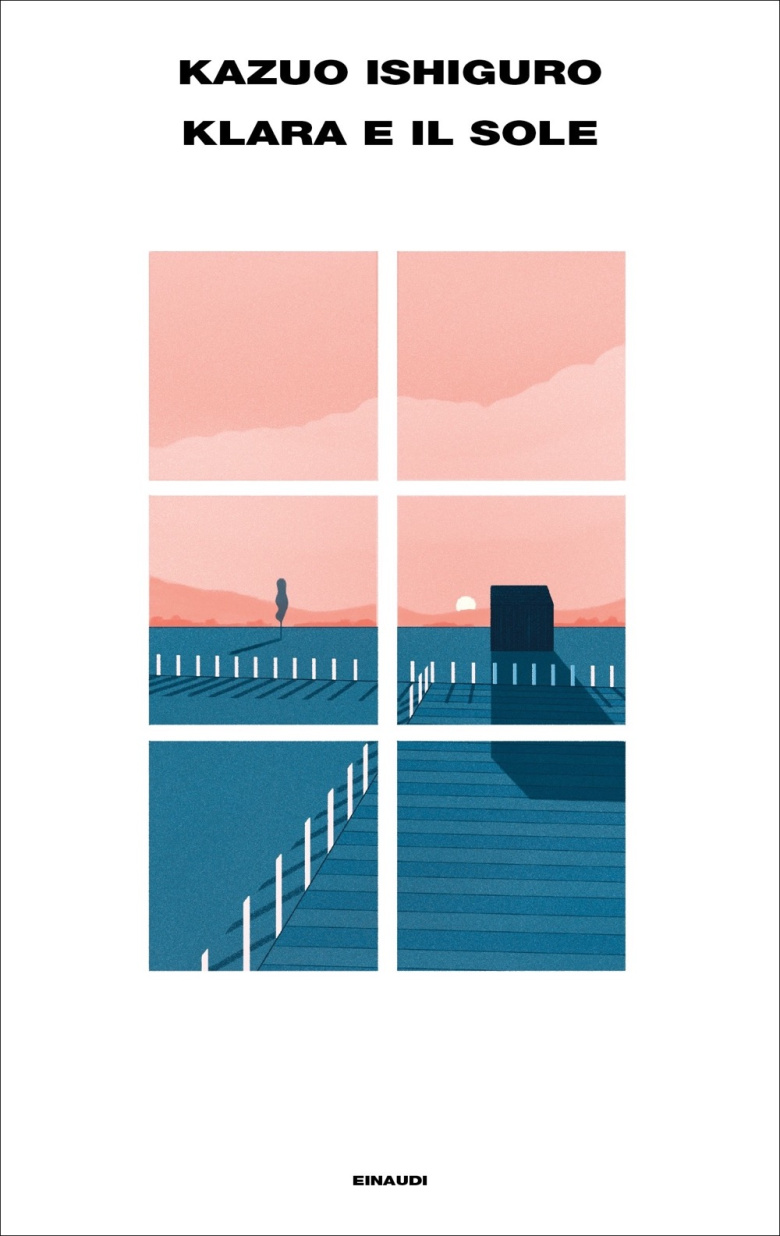
Il quadro si complica ulteriormente nell’ultimo romanzo di Ian McEwan What We Can Know, appena uscito in Italia da Einaudi con il titolo Quello che possiamo sapere nella efficace traduzione di Susanna Basso, a cui si devono alcune ottime soluzioni: così “The Barn”, la casa di campagna, che è al centro dell’azione, dove vivono (o, piuttosto, avevano vissuto) i coniugi Bundy, è “il Casale”, piuttosto che “il granaio”, e “The Derangement”, il collasso dovuto all’innalzamento delle acque, il “il Grande Disastro,” piuttosto che “lo Sconvolgimento”.
Occorre ricordare che Ian McEwan è uno dei maggiori romanzieri inglesi contemporanei, il pretendente non indegno del Premio Nobel per la Letteratura, già assegnato al connazionale Kazuo Ishiguro nel 2017. Una sostanziosa disamina dell’opera dei due scrittori si trova nelle pagine del dizionario letterario di Paolo Bertinetti, Il romanzo inglese del ‘900, recentemente pubblicato da La Nave di Teseo, a cui si può rimproverare solo l’assenza di qualsiasi riferimento bibliografico, certamente in base a una scelta editoriale, non certo per la mancanza di competenze da parte dello studioso.
Val la pena di osservare che, come McEwan, Ishiguro ha, in diverse occasioni, esplorato il mondo ambiguo e intricato delle scoperte e delle applicazioni scientifiche, in Non lasciarmi (Never Let Me Go, 2005 ), la vicenda (spoiler alert) di alcuni giovani che scoprono di essere individui imperfetti, privi di memoria storica e familiare, clonati per soddisfare la richiesta di organi di ricambio, e in Klara and the Sun (Klara e il sole, 2021), la storia di una gentile robot, sfruttata da una famiglia che l’ha acquistata in un negozio di elettronica. In Ishiguro c’è un elemento di pathos, di commiserazione per le sue creature artificiali, che viene modificato in McEwan da un atteggiamento decisamente più ironico, e da una varietà maggiore di situazioni riguardanti la sfera scientifica in senso lato. Personaggi legati al mondo scientifico sono Henry Perowne, il protagonista di Sabato (Saturday, 2005), un neurochirurgo famoso, che scoprirà il potere della poesia in una situazione drammatica per la sua famiglia, e Michael Beard, il Nobel per la fisica di Solar (2010), una figura mediocre e opportunista, premiata per una serie di circostanze favorevoli, il quale si appropria della scoperta fatta dal giovane amante della moglie. In seguito, in Macchine come me (Machines Like Me, 2019), il discorso sull’Intelligenza Artificiale e i Robot antropomorfi si incrocia con i problemi sentimentali di una giovane coppia londinese, in un universo ucronico decisamente parodico. Infatti, la sopravvivenza di Alan Turing, il famoso matematico morto suicida nel 1954 dopo che era stata scoperta la sua omosessualità, porta al perfezionamento dei missili che permettono all’Argentina di vincere la guerra delle Falklands contro la flotta britannica, umiliando il governo di Mrs. Thatcher, uno dei bersagli negativi preferiti da McEwan assieme a Tony Blair. Peraltro, nel suo ultimo romanzo, McEwan si diverte ad alzare la posta delle sue invenzioni geopolitiche, immaginando che, in un futuro a noi molto vicino, dopo aver fatto un solo boccone dell’Ucraina, la Russia abbia annesso anche la Germania.
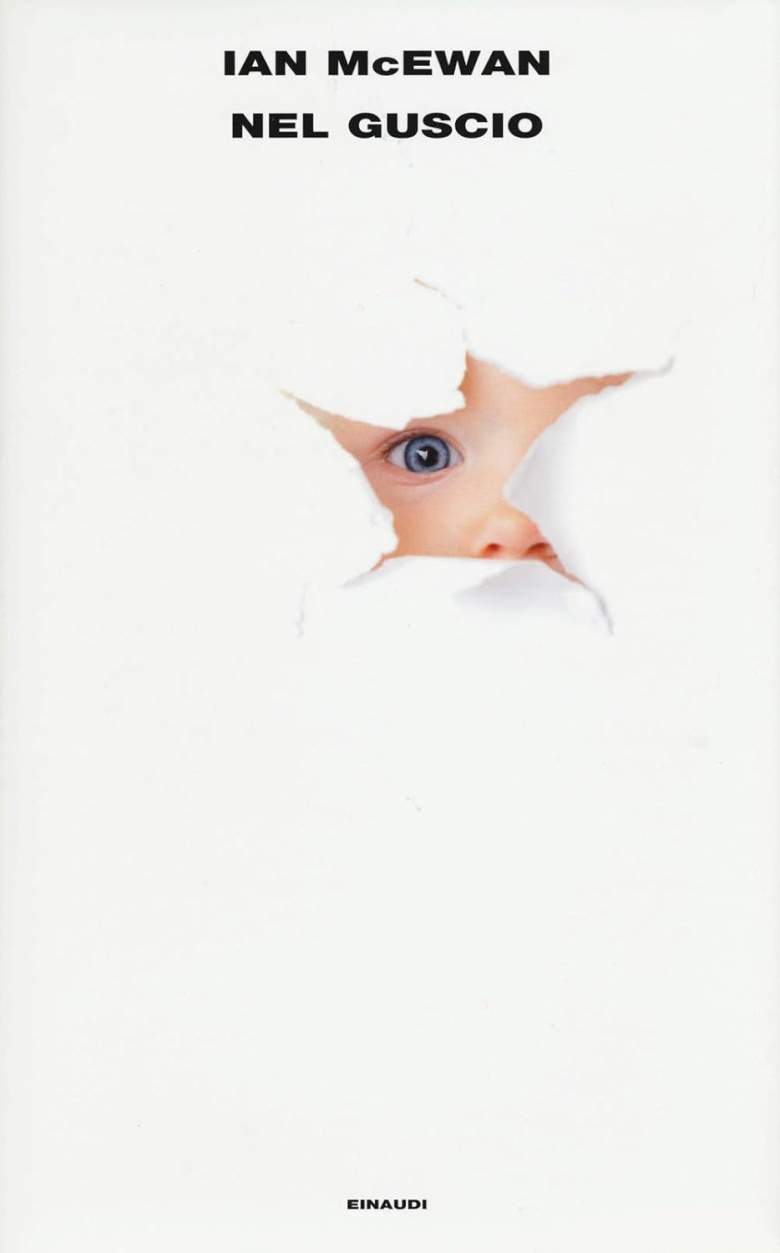
A proposito di Quello che possiamo sapere, McEwan ha dichiarato la sua volontà di scrivere una “fantascienza senza la scienza”, anche se l’impianto narrativo sembra aderire al modello della Cli-Fi (Climate Fiction), la fantascienza che denuncia la devastazione ecologica, causata dal riscaldamento globale delle temperature e dall’innalzamento delle acque. Questo motivo rimane apparentemente sullo sfondo, acquistando tuttavia una sua forza poetica: l’Inghilterra del 2119, sommersa dalle acque, ridotta a un arcipelago, è un omaggio di McEwan alla tradizione britannica della science-fiction di John Wyndham (Il Kraken si risveglia) e di J.G. Ballard (Il mondo sommerso), ma viene vista come uno spettacolo favoloso e straniante, in cui, ad esempio, la splendida Bodleian Library di Oxford è stata spostata sulle pendici del Monte Snowdon, nel Galles, e un’intera città come Glasgow è stata ricostruita sulle alture scozzesi. In realtà al centro del romanzo non c’è tanto la previsione scientifica, ma coesistono la letteratura del passato (il nostro presente) e la critica letteraria del futuro post-apocalittico, che, attraverso le ricerche di Thomas Metcalfe, un accademico anglista, cerca di recuperare una ghirlanda, o corona, di sonetti. Questi preziosi componimenti, mai pubblicati, erano stati letti dal poeta Francis Blundy in onore della moglie Vivien durante una festa di compleanno, tenutasi nell’ottobre 2014 (cinque anni prima della catastrofe ecologica), a cui avevano partecipato un’eletta schiera di amici e parenti. Sulle tracce del poema perduto di Blundy (un artista fittizio che viene accostato ora a T.S. Eliot, ora a Heaney), Metcalfe esamina diari, lettere, altri materiali appartenenti agli intellettuali, uomini e donne, che erano presenti all’occasione. Ciò che emerge (dalle acque metaforiche di una grande alluvione psicologica) è uno scenario complicato di tradimenti, invidie, segreti, ostilità, perfino azioni criminose. Insomma, la letteratura sembra filtrare e purificare – o forse falsifica? – i sedimenti di esistenze per nulla esemplari, così come aveva fatto, cento anni prima, la poesia romantica, rievocata come illustre precedente all’adunata dei (presunti) geni nel Casale. Il passato è sempre idealizzato, e lo stesso si può dire a proposito del rapporto degli artisti con la natura. Come in altre opere precedenti, McEwan usa il romanzo come una rete a maglie larghe in cui si affollano temi diversi. Possiamo lasciare a lettori e lettrici di sprofondare nelle complicazioni della vita sentimentale di ogni personaggio, e invitarli, invece, a pensare alle osservazioni del prof. Metcalfe sul novel come genere inferiore o alle sue riflessioni sulle battaglie accademiche che tentano di salvaguardare l’insegnamento delle humanities in un cultura dove, all’università, gli scienziati hanno uno stipendio doppio rispetto a quello dei poveri letterati. Allo stesso modo, attraverso la voce narrante di Metcalfe, affiorano dalle acque narrative personaggi letterari veri e fittizi: nel primo caso il biografo del periodo romantico Robert Holmes, a cui l’autore di Quello che possiamo sapere rende omaggio con la citazione che fa da exergo al suo romanzo; nel secondo, la romanziera Mabel Fisk, nata nel 2016 a Stockport, sulla quale Metcalfe sentenzia: “Finalmente la civiltà aveva partorito un genio creativo all’altezza di Shakespeare”. Si tratta – azzardiamo – di una battuta parodica riservata a Rachel Cusk, l’autrice di origine canadese elogiata da molti critici per il suo linguaggio fortemente introspettivo, rivolto a esplorare le minuzie dell’esperienza quotidiana. In ogni caso, la letteratura rimane fondamentale, essendo in grado di dare un senso all’esperienza. Così, per Metcalfe (come per il suo creatore), il viaggio da compiere per acquisire nuove prove dell’esistenza e dei significati reconditi del capolavoro di Blundy conserva sempre connotati letterari, tanto da trarre ispirazione dai resoconti odeporici di Robert Louis Stevenson.
E ancora a Stevenson e al modello avventuroso de L’isola del tesoro guarda in modo sorprendente il ‘realista’ McEwan, quando racconta l’ultima fase della ricerca del poemetto perduto da parte di Metcalfe e della moglie e assistente Rose. La ricerca fallisce, ma ciò che emergerà sarà il testo delle confessioni di Vivien Blundy (ovvero la seconda parte di Quello che possiamo sapere), che, tra una citazione di Shakespeare e un riferimento al poeta folle John Clare, riscrivono l’intera vicenda come fosse una (volutamente mediocre) crime story.
Alla fine, il titolo dell’ultimo romanzo di McEwan si risolve in un doppio interrogativo: cosa possiamo sapere noi, lettori e scrittori del 2025, di un futuro dai contorni così mutevoli e sconvolgenti da eludere la nostra immaginazione? Cosa potranno capire gli intellettuali appartenenti a un futuro post-catastrofico della cultura all’inizio degli anni 2000? Il romanzo non risolve certo questi dilemmi, anzi, li complica e sottopone i dati che credevamo di avere acquisito a una continua revisione. La conoscenza, poi, come sottolinea l’exergo di Holmes, non si traduce in una speculazione astratta, ma ha a che fare con “quello che possiamo credere, e, in ultima analisi, quello che possiamo amare.”
Non dovremmo, forse, dimenticare che uno dei classici che McEwan ama di più, tanto da averlo riscritto in Nel guscio (Nutshell, 2016) , è l’Amleto di Shakespeare, un’altra fosca crime story.
Leggi anche:
Paolo Landi | Le lezioni di McEwan
Marco Belpoliti | Lo scarafaggio di McEwan e i coleotteri di Nabokov e Levi
Luciano De Fiore | Ian McEwan. Queste macchine così inumanamente perfette