Nuove mappe della distopia
Nel 1960 usciva in Inghilterra New Maps of Hell, un denso trattatello di Kingsley Amis dedicato alla fantascienza contemporanea britannica e anglo-americana. Due anni dopo sarebbe stato pubblicato in Italia da Bompiani con il titolo Nuove mappe dell’inferno. Kingsley Amis, oggi ricordato ingiustamente soprattutto come padre del più celebre Martin, godeva in quegli anni di una discreta fama, avendo dato avvio con Lucky Jim alla narrativa degli angry young men, i ‘giovani arrabbiati’ inglesi, che ritenevano esaurita l’esperienza del Modernismo e guardavano piuttosto all’impegno sociale di Orwell, a Dickens e alla tradizione vittoriana. Vale la pena di ricordare che nel 1954, l’anno di pubblicazione di Lucky Jim, era apparso anche Lord of the Flies (Il signore delle mosche) di William Golding, che si muoveva in una direzione narrativa diversa, situata tra allegoria e fantastico, ma pur sempre lontana dal canone modernista. In realtà, in Nuove mappe dell’inferno, Amis aveva in mente una certa idea della fantascienza che escludeva sia il fantastico, sia la tradizione della space opera e del viaggio interplanetario, fino ad allora prevalente, sia una robusta vocazione divulgativa. Messi da parte Heinlein, Van Vogt, Asimov, e il connazionale Arthur C. Clarke, ciò che interessava ad Amis, egli stesso autore di The Alteration (1976), un notevole romanzo ucronico, era l’affermazione di un tipo di fantascienza impegnata, polemica nei confronti del potere politico, dello sviluppo aggressivo del capitalismo, e dell’uso spregiudicato della tecnologia. Era la social science-fiction (in Italia la fantascienza sociologica), presente dagli anni ’50 soprattutto sulle pagine della rivista americana Galaxy, diretta da Frederick Pohl, su cui pubblicavano i loro racconti e romanzi brevi, oltre allo stesso Pohl, giovani di belle speranze come Robert Sheckley, Philip K. Dick e Kurt Vonnegut jr. Non vi è da meravigliarsi se questa nuova fantascienza identificasse nello Swift dei Gulliver’s Travels uno dei suoi ispiratori, guardando soprattutto all’ultimo viaggio dell’eroe swiftiano che, nella terra dei Cavalli Saggi, crede ingenuamente di aver trovato una civiltà perfetta, fondata sul raziocinio. Questa molto ambigua utopia, estrapolata dal resto del capolavoro di Swift, è stata riproposta di recente in Houyhnhnmland. L’ultimo viaggio di Gulliver (Ledizioni, con l’introduzione di Giuseppe Sertoli). Swift era anche uno degli autori preferiti da George Orwell, l’autore di 1984.
Consapevolmente o meno, Amis ha il merito di aver collegato fantascienza e distopia, due generi narrativi strettamente affini, che finiscono per fondersi man mano che il Novecento conosce guerre apocalittiche e celebra le folli ‘utopie’ perseguite dai regimi di Stalin e di Hitler, individuati nella loro unicità da Hannah Arendt in Le origini del totalitarismo (I ed. 1951). Orwell ricostruisce una tradizione distopica che ha le sue colonne portanti in When the Sleeper Wakes (Londra 2100. Il risveglio del dormiente) di H.G. Wells, uscito nel 1899, in Iron Heel (Il tallone di ferro) di Jack London (1908), in Noi del fuoriuscito russo Yevgeny Zamyatin (pubblicato per la prima volta in inglese nel 1922), in Brave New World (Il mondo nuovo) di Aldous Huxley (1932), e che culmina nel suo 1984 (1949). L’esempio più significativo che è in linea con la ricostruzione di Orwell è probabilmente A Clockwork Orange (L’arancia a orologeria) di Anthony Burgess (1962), valorizzato nel 1971 dal film di Stanley Kubrick. In A Clockwork Orange il regime repressivo passa in secondo piano rispetto al racconto delle malefatte di alcuni criminali adolescenti, fatto da Alex, il loro capo, in un buffo gergo anglo-russo.
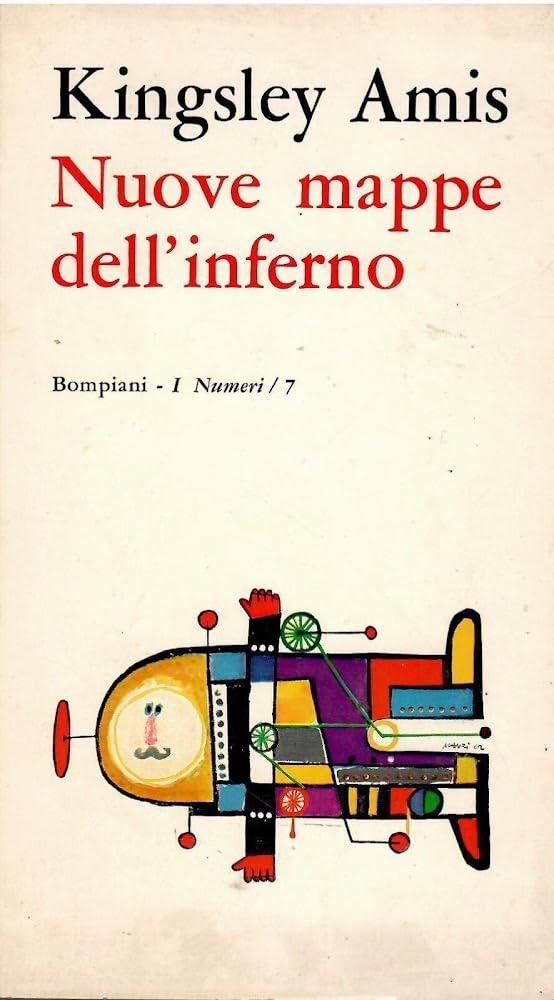
Tra i demeriti dello Orwell saggista vi è quello di aver trascurato la produzione femminile che, negli anni ’30-’40 si era già espressa attraverso le voci di Storm Jameson (In the Second Year) e di Katharine Burdekin (Swastika Night), entrambe femministe e anti-fasciste, e di Ayn Rand, che sarebbe diventata esponente di spicco di un individualismo libertario visceralmente anti-comunista. La cultura femminile si accosta alla distopia nel secondo dopoguerra in modo trasversale, puntando subito sulla de-costruzione del linguaggio patriarcale piuttosto che sulla elaborazione rigorosa del mondo del futuro. Gli anni ’70 del secolo scorso sono cruciali: Doris Lessing esce con Memoirs of a Survivor (1974), Memorie di una sopravvissuta, ambientato in una Londra alla deriva, attraversata da bande giovanili, mentre la voce narrante, chiusa in casa, scava nel proprio passato; Angela Carter, la principale autrice inglese post-moderna, immagina in The Passion of New Eve (1977) il suo protagonista, Evelyn, poi sottoposto a un mutamento di sesso, in viaggio per un’America apocalittica e devastata dalla guerra civile. Il romanzo di Carter, secondo l’autrice “una commedia nera femminista,” esce in Italia nel fatidico 1984 con il titolo La passione della nuova Eva e la traduzione di Barbara Lanati, una delle nostre maggiori americaniste.
Tuttavia la distopia delle donne ha avuto un apprezzamento unanime soltanto nel 1985, quando Margaret Atwood ha pubblicato in Canada The Handmaid’s Tale (Il racconto dell’ancella, 1988). Il seguito, The Testaments (subito tradotto come I testamenti, 2019) non ha avuto uguale fortuna. Seppur riconoscendo il suo debito nei confronti di Orwell, Atwood accentua il carattere soggettivo della testimonianza dell’ancella Offred, una voce narrante che vive sul proprio corpo l’esperienza della violenza sessuale, legalizzata dal sistema politico di Gilead, mentre riconosce l’ambiguità di una condizione sociale che le garantisce alcuni vantaggi. Offred è in grado di comprendere a poco a poco, e poi di combattere, le caratteristiche dello stato totalitario in cui è costretta a vivere. Nelle distopie tradizionali l’eroe viene inghiottito dall’incubo totalitario. Nell’opera di Atwood Offred sopravvivrà a Gilead. L’interesse per The Handmaid’s Tale si è rinnovato di recente grazie al volume di saggi curato da Alessio Musio (Mimesis 2025). Tra gli interventi spicca quello di Arianna Visconti sulla “struttura castuale” di Gilead, in cui “se la suddivisione in caste interessa anche gli uomini […] sono tuttavia le donne nel loro insieme a costituire la classe sociale in assoluto inferiore, condizione sancita nettamente anche a livello giuridico.”
In sostanza, l’affermazione sempre più convinta di una coscienza femminile che si riconosce nei modelli e nelle invenzioni della distopia ha portato a una revisione non solo ‘ideologica’ dell’intero genere, ma anche alla ricerca di nuovi linguaggi che tendono a smantellare le solide architetture della tradizione orwelliana. In Wells, in Huxley, in Orwell la costruzione distopica si articola in uno scenario che, a poco a poco, delinea fin nei dettagli il paesaggio repressivo e autoritario del futuro. Al suo interno si colloca la ribellione di un personaggio condannato al fallimento (Graham, il dormiente wellsiano, il Selvaggio di Huxley, Winston Smith in 1984), coinvolto in una love-story trasgressiva e priva di speranza. Anche in Noi di Zamyatin, che pure utilizza la forma diaristica, ovvero una modalità di scrittura fortemente soggettiva (in questo senso l’espediente del diario sarà ripreso da Orwell in 1984), la grottesca rigidità espressiva di D-503 cancella, almeno all’inizio, qualsiasi slancio emotivo. D’altra parte, D-503 è solo un “alfanumero” (secondo l’efficace traduzione di Alessandro Niero nell’edizione degli Oscar Mondadori, 2018): “Mi limito a cercar d’appuntare ciò che vedo e penso: o meglio, ciò che noi pensiamo (noi, ecco; e sia proprio questo NOI a intitolare i miei appunti).”
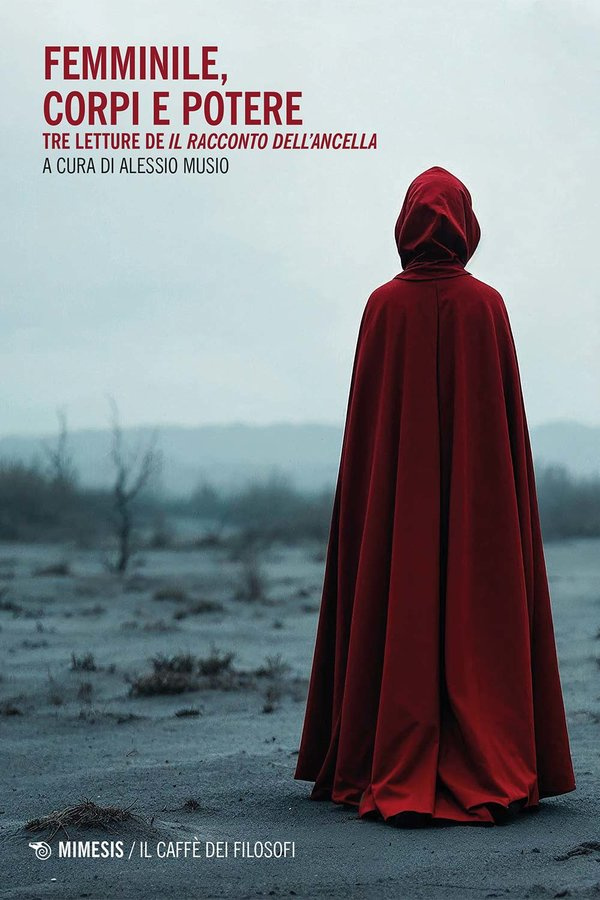
Sia pure limitandomi a pochi testi recenti, vorrei dare un’idea della varietà degli approcci narrativi che confermano come la rappresentazione del femminile abbia preso il sopravvento nella distopia contemporanea. Ciò avviene anche nel caso dello scrittore irlandese Paul Lynch, l’autore di Prophet Song (Il canto del profeta), tra i romanzi selezionati per il Booker Prize nel 2023. Sebbene la ribellione all’inasprimento progressivo delle misure repressive riguardi un insegnante di scuola, è attraverso il punto di vista angosciato e partecipe della moglie biologa che i lettori seguono le vicende di una famiglia borghese, in bilico tra la resistenza e la fuga in Canada. Nello stesso anno l’americana Sandra Newman, che si muove di solito tra ucronia e fantastico, pubblica Julia, una riscrittura di 1984 in cui le vicende della donna amata da Winston Smith nel romanzo orwelliano acquistano una loro autonomia, prima di concludersi con due incontri sconcertanti, il primo con il ‘vero’ Grande Fratello, il secondo con i membri della Fratellanza, che dovrebbe combattere lo stato dittatoriale. La traduzione (Julia, 2024) è di Claudia Durastanti, una scrittrice italiana che conosce bene la tradizione della fantascienza e della distopia.
Si potrebbe considerare Gliff di Ali Smith (appena pubblicato in Italia da Sur con la traduzione di Federica Acero) come un ulteriore passo avanti verso la disgregazione della tradizione distopica inglese di Wells, Huxley, Orwell. Autrice, tra l’altro, di un quartetto di romanzi che prendono il titolo dalle stagioni dell’anno, la scozzese Ali Smith ama destabilizzare i livelli temporali, alternando bruschi passaggi narrativi che passano dalla citazione della narrativa vittoriana (la prima riga di Autumn, 2016, riprende l’incipit di Le due città di Dickens) ai riferimenti all’Inghilterra della Brexit, dall’evocazione della natura all’indagine sui sentimenti e le emozioni individuali. Soprattutto, Ali Smith ha assorbito la lezione di Virginia Woolf, e i ritmi della sua prosa fluida, ricca di tensioni interiori. Il suo Gliff si presenta come una lettura impegnativa, tanto è sfilacciato il racconto di un/a adolescente, Bri o Briar (Rovo), dall’incerta identità di genere, che, assieme a Rose, la sorella minore, viene abbandonata/o dalla madre e dal suo compagno, detenuti probabilmente in una struttura governativa. Se i contorni dell’Inghilterra totalitaria sono quanto mai sfumati e privi di consistenza ideologica, è pur vero che una larga parte della popolazione sembra costituita di unverifiable, cioè di individui tenuti al margine del sistema e sottoposti a varie forme di vessazione e di controllo. I tentativi di conservare la loro indipendenza da parte delle due figure principali, aiutate da altri personaggi, come l’anziana Oona, portano Briar e Rose in una comunità di reietti ospitata in un antico edificio scolastico. E lì che Rose guiderà il cavallo Gliff, che sembra uscito da un quadro del pittore settecentesco George Stubbs, un potente simbolo di libertà, ma anche corpo materiale del mondo animale. (Per dirla in parole povere, Gliff passa il tempo defecando e urinando sul pavimento dell’edificio). Dopo il brusco passaggio di cinque anni, Briar finisce ingabbiata nel sistema con quei compiti di sorveglianza che sembrano essere una delle maggiori attività svolte nell’Inghilterra del futuro.
Spoiler alert: l’incontro con Ayesha, un’altra reietta, spingerà Briar a eliminare qualsiasi traccia ufficiale della sua identità e a mettersi alla ricerca di Rose: “Ora che non esisto più torno finalmente a esistere.”
Alcune delle invenzioni narrative di Ali Smith sono efficaci: ad esempio, una ragnatela di strisce di vernice rossa delimita gli edifici sottoposti a sequestro o a demolizione dalle autorità, modificando radicalmente il paesaggio urbano. A questo proposito, la traduttrice italiana, in generale da elogiare, lascia in inglese supera bounders, il nome dei congegni che compiono l’operazione di circoscrivere gli spazi. Considerato che bound indica un confine e che il termine appariva nel discorso utopico di Gonzalo nella Tempesta shakespeariana (“bound of land”, II.1), una delle opere direttamente citate da Smith nel suo romanzo, si sarebbe potuto tradurre “macchine – o supermacchine – confinatorie”. Un altro oggetto, l’educator, che, indossato dai singoli individui, assolve a una funzione di controllo, avrebbe potuto essere reso con “istruttore”. Il bisticcio behemot/moth, messo in bocca a un/a Briar capace di giocare con il linguaggio (come la sua creatrice), si trasforma nell’assonanza tra ciclope e ciclista. Mi permetto, stando al gioco, di suggerire kraken e criceto. In generale, la traduttrice riesce a disinnescare, talvolta restituendo alle frasi una concretezza che esse occultano nell’originale, le mine vaganti del linguaggio precario e frammentario, eppure accanitamente reclamato e indagato, entro cui i personaggi di Gliff iscrivono le loro esperienze di fuga, di solitudine, di ribellione. Così, il gioco delle variazioni comprese nell’ultima parte del romanzo di Ali Smith sul titolo Brave New World, che è la citazione della Tempesta di Shakespeare, ripresa nel titolo della distopia di Aldous Huxley, è recuperato da Federica Aceto con indiscutibile perizia.
Un’ultima annotazione che ci riporta alla contemporaneità. È notizia di questi ultimi giorni che il governo laburista di Starmer ha deciso di introdurre nel Regno Unito, sia pure in modo parziale, la carta di identità, invisa a una parte dell’opinione pubblica britannica, che considera l’imposizione di questo documento come l’annuncio di una svolta autoritaria. De te distopia narratur.
Leggi anche:
Carlo Paggetti | Le metamorfosi dell'immaginario fantascientifico
I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani
Niccolò Scaffai | Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne
Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick
Alberto Mittone | Che cosa è reale? / I mondi di Philip K. Dick
Alberto Mittone | Lino Aldani, maestro di fantascienza
In copertina, opera di Simon Stålenhag.







