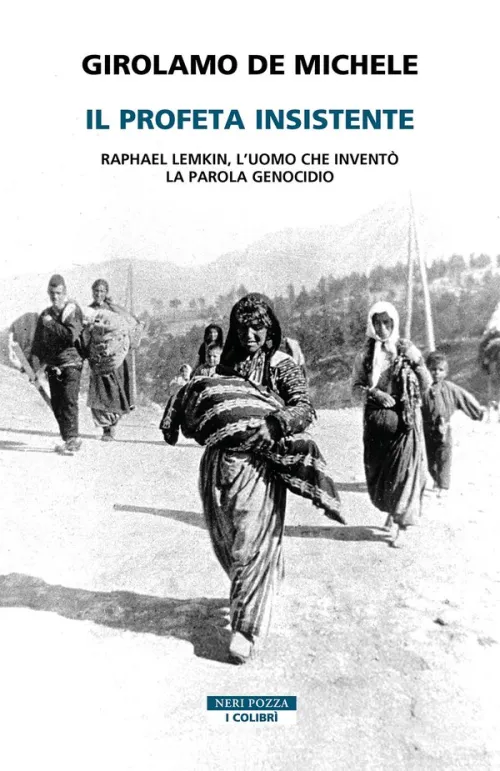Genocidio: storia di una parola
Il termine ‘genocidio’ è sorto nel novecento quando gli omicidi in massa delle popolazioni civili assunsero una dimensione non solo quantitativa ma anche qualitativa. Da essi emergeva cioè il carattere ideologico per la natura totalitaria dei regimi che li attuarono, per l’essere il risultato di politiche ipernazionaliste (la pulizia etnica degli armeni ad esempio) o di programmi rivoluzionari (l’epurazione di classi o gruppi sociali in Unione Sovietica, in Cina, in Corea del Nord, in Cambogia). Questa riflessione, e cioè l’essere espressione di rapporti di potere, vale anche di fronte alla specificità tragica della Shoah, pianificata con la creazione di “apparati di distruzione di massa”, l’organizzazione “industriale” dello sterminio, l’installazione di ‘fabbriche della morte’ e cioè i campi di annientamento.
La definizione genocidio venne coniata e approfondita dal giurista Raphael Lemkin, nato in un villaggio russo, oggi in Bielorussia, nel 1900 e morto nel 1959, uno dei tanti ebrei segnati dall’emigrazione e dallo sradicamento, vissuto lontano dai riflettori, mite, solitario, poco noto tanto che Hannah Arendt non lo ricorda (Meyer, Hannah Arendt. Una vita filosofica, Feltrinelli, 2025). Era però coriaceo, instancabile, impegnato per tutta la vita a perseguire un obiettivo: disegnare le linee normative del reato e farlo inserire tra i crimini penalmente perseguibili. Fu un “profeta insistente”, così come definito in un saggio recente che, corredato da preziosi documenti non facilmente reperibili, lo accompagna negli anni (De Michele, Il profeta insistente, Neri Pozza, 2025).
Gli approfondimenti di Lemkin si sono sviluppati in varie tappe. Nel 1944 pubblica il volume Axis Rule in Occupied Europe avente come oggetto non già lo sterminio degli ebrei, ma come la Germania riuscì a dominare l’Europa anche attraverso la legislazione emanata nei territori occupati. Nel capitolo 9, dopo aver esaminato come la politica nazista si sia distinta nel progetto di cancellare l’identità dei popoli, illustra e approfondisce il concetto di genocidio. Si tratta di un neologismo ottenuto dall’incrocio del termine greco ‘genos’ (razza o tribù) con quello latino ’caedere’ (uccidere), e definito dal saggio come un “piano coordinato di differenti azioni mirante alla distruzione dei fondamenti essenziali della vita di gruppi nazionali, con l’intento di annientarli con la disintegrazione sociale e la distruzione biologica del gruppo”. Gli individui non vengono cioè perseguitati per le loro azioni, ma in quanto appartenenti a un gruppo inteso come stirpe, popolo. L’obiettivo è la distruzione della loro identità e il loro annientamento fisico, e a tal fine vengono adottate “tecniche’, cioè misure appositamente studiate per quelle finalità. Vi rientrano atti quali l’uccisione dei membri del gruppo, le lesioni gravi alla loro integrità fisica o mentale anche attraverso lo stupro, la creazione di condizioni di vita funzionali alla distruzione fisica anche parziale, l’impedire nascite all’interno del gruppo, il trasferire con la forza fanciulli da un gruppo a un altro. Il reato rende punibile l’accordo o anche solo la complicità nel commettere queste azioni, la loro istigazione diretta e pubblica, il tentativo di realizzarne gli obiettivi anche se non si raggiunge il risultato.
Fra il 1945 e il 1946 Lemkin fu consulente di Robert H. Jackson, nominato procuratore capo nel processo di Norimberga, cioè in quella Corte militare internazionale (International Military Tribunal) istituita nell’agosto del 1945 dall’Accordo di Londra per giudicare i nazisti. Nello Statuto la fattispecie di genocidio non compare (cfr. “Norimberga e i tribunali internazionali” in questa rivista 2022) forse per l’influenza di un altro giurista, Lauterpach, anche egli studente a Leopoli come Lemkin (cfr. “Philippe Sands, gestire la memoria”, in questa rivista) che, ispirato da H. Kelsen, celebre giurista di quegli anni, insistette con successo per inserire un altro reato, i “crimini contro l’umanità” in base al quale i criminali nazisti risultano “hostis generis humani”, cioè nemici del genere umano. Al di là di questa controversia davanti alla Corte di Norimberga furono sollevate questioni processuali di non poco peso. Alcuni difensori rilevarono che con questa imputazione veniva vulnerato il principio di legalità secondo cui si può essere puniti solo per i reati vigenti al momento delle azioni commesse e non per quelli introdotti successivamente. L’eccezione fu respinta osservando che i crimini da giudicare rappresentavano una violazione di leggi internazionali preesistenti quali la Convenzione dell’Aja, di Ginevra e il Patto Briand-Kellogg. Si replicò che quei trattati non erano vincolanti per Germania, Italia e Giappone essendo nazioni che non li avevano ratificati, ma anche questo argomento fu superato con una decisione a dir poco eccentrica. Si notò che una convenzione internazionale, se ratificata da un certo numero di Stati per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, può considerarsi vincolante per ogni nazione e non solo per quelle che l’hanno recepita. L’obiettivo dei giudicanti, neppure troppo nascosto, era punire i crimini richiamando presupposti “naturali”, cioè ‘leggi non scritte’ applicabili sempre in quanto presupposti decisivi e necessari per il vivere civile. Ma le obiezioni non mancarono, anche provenienti da voci autorevoli come quella di Carl Schmitt, uno dei maggiori giuristi tedeschi di quel periodo, secondo cui la Corte alleata era ispirata da motivi politici e non giuridici (Risposte a Norimberga, Laterza 2006). La stessa Hannah Arendt non trovò validi argomenti per ribattere: “le motivazioni di solito addotte per giustificare il Tribunale di Norimberga sono piuttosto deboli. È vero che dopo la Prima guerra mondiale Guglielmo II fu citato dinanzi a un tribunale delle potenze alleate, ma il reato contestato non era la guerra, ma la violazione dei trattati. È anche vero che il patto Briand-Kellogg del 1928 condannò la guerra come strumento di politica nazionale, ma non conteneva un criterio per stabilire che cos’è un’aggressione, né accennava a sanzioni” (La banalità del male, Feltrinelli 1963). In Italia Piero Calamandrei, lasciati i panni del giurista per indossare quelli del polemista, sentenziò: “Qualche anima bennata si sente offesa e impietosita dinanzi a queste forche e a questi giustiziati. […] Non sarebbe stato possibile, di fronte a milioni di martirizzati innocenti, adottare cautele che avrebbero trasformato la legge in uno sterile legalismo…. Norimberga aveva dimostrato che la spietata inumanità è sempre esposta al castigo”. (Le leggi di Antigone, 1946). Nel luglio del 1947, all’Assemblea Costituente, Benedetto Croce fu tagliente come un rasoio: “Segno di turbamento sono i tribunali …che il vincitore ha istituito per giudicare, condannare, impiccare… abbandonando la diversa pratica, esente da ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere al vinto o ai suoi uomini e se ne richiedeva la consegna per metterlo a morte”. Il tribunale dei vincitori “offende la verità e la moralità perché cela l’utile”. Questo non fu il solo inciampo giuridico a Norimberga in quanto si pose anche il problema dell’imparzialità, principio antico secondo cui la giustizia deve essere neutra, al di sopra delle parti in conflitto, mentre nella Corte traspariva dominante la giustizia politica. Nacquero dibattiti anche di alto livello (su questi profili, tra i molti, Portinaro, I conti con il passato, Feltrinelli 2011) e un eccellente giurista, il Kelsen dianzi citato, sostenne che: “solo una corte costituita da un trattato internazionale del quale anche gli stati sconfitti siano parti contraenti non incontrerà le difficoltà con cui dovrà invece confrontarsi una corte nazionale” (Il processo di Norimberga ed il diritto internazionale,1989). Qualche anno dopo, nel 1946, la risoluzione n. 96 delle Nazioni Unite qualificò il genocidio “crime under international law”, e nel dicembre del 1948 fu approvato dall’Assemblea Generale il testo finale della Convenzione sul genocidio cui Lemkin aveva fornito indefessamente il suo contributo (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide). Esso qualifica il genocidio come “crimine di diritto internazionale” stabilendo il dovere per gli stati contraenti di perseguirlo (art.1), mentre l’art. 2 definisce che le vittime devono appartenere a un gruppo definito in base a nazionalità, etnia, razza o religione. Con questa categoria anche giuridica il baricentro si sposta dall’ambito militare (i crimini di guerra) a quello politico, affiancando alla criminalità individuale quella di sistema che ricomprende quanto commesso per ordine o per compiacenza delle autorità politiche. Inoltre vengono elencati gli atti genocidari (‘il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale e parziale, l’uccisione di membri del gruppo, le lesioni gravi alla loro integrità fisica o mentale, il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica; l’adottare misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro). E sono punibili gli atti finalizzati a commettere uno o più dei cinque crimini previsti; l’intesa (conspiracy) diretta a commettere il genocidio; l’incitamento (ossia l’istigazione) pubblico; il tentativo e la complicità nel porlo in essere. Va sottolineato che la punibilità scatta se esiste l’intenzione di distruggere anche parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e deve esistere una pianificazione di cui l’esecutore è a conoscenza, quindi un nesso tra l’atto individuale e l’azione collettiva. Nella sostanza il reato del genocidio mira a difendere i gruppi umani o meglio difende il singolo in quanto appartenente a un gruppo specifico. La Convenzione però non include i motivi politici o sociali in quanto qualche stato (Stati Uniti, Inghilterra, Sovietici) osservò che solitamente si tratta di ribelli alle autorità costituite e quindi da considerare nemici dello stato secondo criteri sociopolitici e non etnoreligiosi. È stata una decisione destinata a incidere sull’efficacia della Convenzione dal momento che le politiche genocidarie potevano e possono includere la liquidazione di élite e attivisti politici, come la storia ha dimostrato.
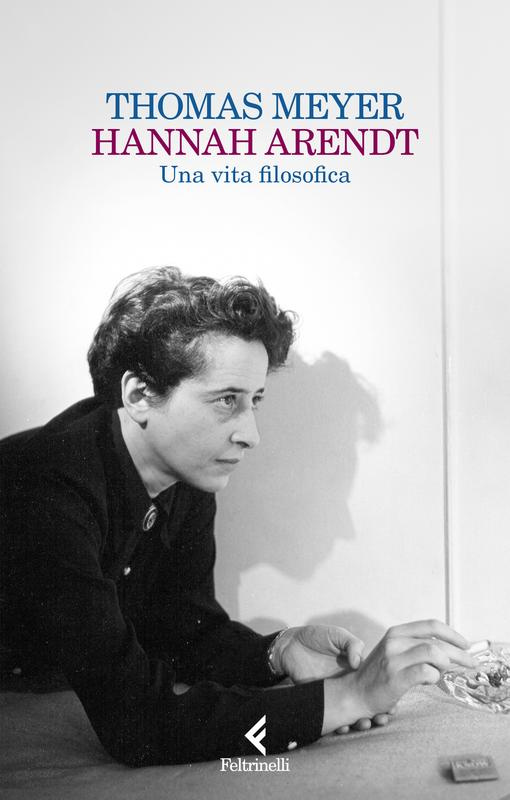
È rilevante sottolineare che la Corte penale internazionale dell’Aja, istituita nel 1998 e operativa dal luglio del 2002, prevede il genocidio all’art.6 definendolo come “l’uccisione, in tutto o in parte, intenzionale e deliberata, di persone appartenenti a un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Essendo punibile soltanto la responsabilità personale e non quella collettiva, per i lavori della Corte si apre un delicato scenario di indagine: occorre individuare i vertici che hanno ordinato quei crimini e se l’ordine è stato emanato in quei termini o se gli esecutori se ne sono distaccati operando autonomamente? Problema non lieve per i crimini di guerra e contro l’umanità, più agevole forse per il crimine d’aggressione e per il genocidio eseguito automaticamente seguendo le iniziative del vertice. La Corte non sostituisce la giurisdizione nazionale, ma la affianca (Su questi temi, tra i molti, Archibugi-Pease, Delitto e castigo nella società globale. Crimini e processi internazionali, Castelvecchi 2017; Baldissarra - Pezzino, Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra, L’Ancora del mediterraneo 2005) creando un problema non secondario, cioè lasciando trasparire un vizio procedurale in quanto potrebbe essere violato il principio secondo cui l’imputato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato, in questo caso dalla giustizia nazionale e da quella internazionale. Oggi sono 123 gli Stati che hanno aderito alla Corte dell’Aja anche in tempi diversi, la Corte, in decenni di attività, ha aperto numerose indagini incriminando però poche decine di persone e concludendo non molti processi. Ha incontrato spesso difficoltà per l’inedia o la freddezza degli stati membri, ma anche per un difetto genetico, in quanto grandi potenze come Russia, Cina, India, ed USA non vi hanno aderito e quindi non ne sono tenuti al rispetto. Lucida e senza fronzoli è la notazione di autorevoli commentatori: “dopo vent’anni di attività la Corte presenta purtroppo un bilancio miserevole: cinque condanne, due terzi dei dossier contro mestieranti della sopraffazione internazionale si sono dissolti in insufficienza di prove, tredici imputati latitanti. Molto gesticolare inutile.” (D. Quirico, Karim Khan e l’illusione del giudizio universale, La Stampa 22.5.2024).
Dopo il 1948 il concetto di genocidio è stato definito come un “significante fluttuante” per le numerose oscillazioni, ampliamenti e distorsioni rispetto alla sua storia. Questo avviene soprattutto nel contesto della guerra fredda, che viene combattuta anche sul terreno dei diritti umani, ad esempio con campagne anticomuniste rispetto ai programmi di repressione promosse da fuoriusciti dall’Unione Sovietica, mentre Lemkin volendo mantenere il concetto originario si oppose alla proposta di attivisti afroamericani di tutelare la popolazione nera. Una sorta di mutamento genetico che ne dilata i confini, etichettando con quel termine anche violenze che non comportavano necessariamente discriminazioni di minoranze, politiche di espulsione, pogrom, includendo in esso le politiche di sopraffazione (i cosiddetti “olocausti coloniali”), i bombardamenti su Hiroshima o sul Vietnam, gli eccidi con motivazione politica dando sempre maggior spazio al conflitto sociali, ad esempio il genocidio “indiretto” per carestia politicamente indotta come nel caso dell’Holodomor, la grande fame in Ucraina conseguente alla collettivizzazione forzata di Stalin nei primi anni trenta. Si discute sul controverso neologismo ‘democidio’ cioè la persecuzione per ragioni politiche, l’epurazione sociale, le forme di omicidio di massa compiute da organi governativi, il ‘politicidio’ cioè gli eccidi con motivazione politica, e così l’‘indigenicidio’, il ‘femminicidio’, il ‘gendericidio’. Altre espressioni non implicano necessariamente l’eliminazione di esseri umani come l’‘etnocidio’ (la cancellazione di una cultura), ‘ecocidio’ (la catastrofe ambientale), il ‘memoricidio’ (la cancellazione della memoria), l’‘olocidio’ o ‘urbicidio’ (distruzione da bombardamenti anche su città). Negli anni novanta con sempre maggior forza il concetto si lega ai conflitti derivanti dalla colonizzazione e si avvia a diventare quello che è oggi, strumento potente di denuncia della violazione di diritti umani. E in quel stesso periodo tende a diffondersi una ‘politica di riconoscimento’ allorché si affermano sempre più le rivendicazioni per il riconoscimento di identità specifiche (genere, etnia o altro) oltre a quelle più tradizionali.
Come osserva Di Michele, l’elaborazione del ’genocidio’ ha presentato così problemi di natura storico-politica. Esso è divenuto e si è consolidato come regime di memoria ereditato dalla Seconda guerra mondiale, centrato sull’Occidente per cui altre forme di violenza verso i civili, pur condannabili, sono tendenzialmente considerate meno gravi, come quelle in cui mancherebbe l’ideologia di sterminio e l’intento specifico. Sembra cioè che l’Occidente detenga una sorta di ‘sovranità intepretativa’ definendo cosa è e cosa non è, mentre rimangono irrisolti i profili della categoria oscillanti tra crimini contro l’umanità, pulizia etnica, sterminio di una etnia o razza.
Non solo: questo processo di ampliamento del termine conduce a un tema cruciale nei rapporti storici e tradizionali tra lo stato, la punizione, il riflesso sulla collettività, cioè l’uso, ampliato o ristretto, del diritto penale. Si tratta del noto fenomeno del cosiddetto ‘panpenalismo’, secondo cui l’intervento del penale e la punizione dominano, sono appoggiati perché indicati come la risoluzione di ogni problema conflittuale. Non solo: il genocidio comporta complessi problemi applicativi come le difficoltà di accertamento, l’individuazione dei colpevoli in un mondo spesso gerarchico e, non da meno, la scarsa collaborazione degli Stati che può condurre, come spesso verificatosi, a scarsi risultati. Di qui l’amarezza della sconfitta dopo tante dichiarate aspettative.
Leggi anche:
Alberto Mittone, Norimberga e i tribunali internazionali
Alberto Mittone, Philippe Sands, gestire la memoria
Marco Ercolani, Norimberga, I gerarchi e lo psichiatra