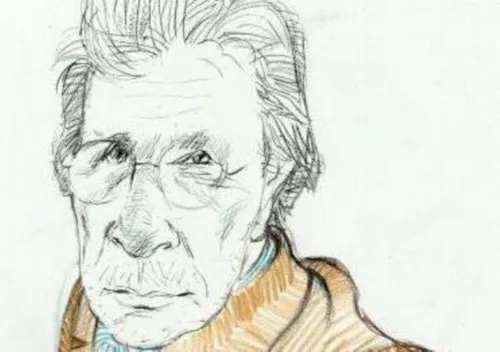Il comico come strategia in Gianni Celati
L’ultimo numero della rivista Nuova prosa, Le strategie del comico in Gianni Celati & co, raccoglie gli atti del convegno di Copenaghen dedicato a Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni.

Lo presentiamo attraverso un’intervista di Aurora Capretti a Gianni Celati ed un breve video, di Gianni Canali, in cui Nunzia Palmieri introduce il volume.
Nuova prosa è edita da Greco&Greco (info@grecoegrecoeditori.it) che ringraziamo per averci concesso di pubblicare l'intervista a Gianni Celati.
Negli anni Sessanta inizia a collaborare e a scrivere su una serie di riviste; tra queste, molte delle quali vicino alla Neoavanguardia, anche “il Caffè” diretta da Giambattista Vicari. Può parlarmi della sua esperienza a riguardo?
L’avanguardia aveva uno sfondo ideologico, anche se questa tendenza era evitata da molti, oppure astratto-fenomenologico, con tendenze abbastanza accademiche. Nelle poche volte che ho avuto a che fare con i suoi promotori, mi sono trovato a disagio. “Il Caffè”era invece una nave in mezzo al mare, senza dottrine, veramente anarchica perché sfuggiva a tutte le classificazioni, dando luogo a fervide amicizie, e in questo senso mi sono trovato subito come a casa mia, con una grandissima simpatia per G.B. Vicari.
Che ruolo pensa abbiano avuto le inchieste nate attorno ai temi del grottesco, della satira e dell’irrisione per la nascita di una linea comica nella letteratura sperimentale italiana, dopo il Sessantotto?
In quegli anni stavo molto in Inghilterra e leggevo molto Swift, traducendo certe sue cose mai arrivate in Italia (ad es. La Favola della botte). Quelli di Swift sono i massimi capolavori della satira e dell’irrisione. Vicari mi ha dato carta bianca e mi sono entusiasmato per questi sventolamenti d’una bandiera da alieni, come Swift con il suo Gulliver, che è l’epitome di tutti gli alieni a venire. (L’alienità del singolo e il demonismo sociale nelle società moderne).
E quali sono stati i suoi rapporti di scambio con il direttore Vicari?
Non riesco a ricordarmi come sono entrato in amicizia con lui, ma attraverso lui ho incontrato Calvino, Manganelli, Frassineti e altri. I rapporti con Vicari per me si concentravano nel piacere di andarlo a trovare e stare con lui e ascoltare i suoi ricordi (era stato un grande amico di Ezra Pound). Persona d’una generosità spericolata, più d’ogni altro ha messo in me una certa voglia di scrivere.
Quando avviene e sulla base di quali interessi l’incontro con la scrittura di Antonio Delfini?
Delfini ha trovato in Vicari una grande sintonia. Avevano qualcosa in comune, come la tendenza a scappar via da tutto quello che era la letteratura ufficiale, la letteratura del “pensare bene”.
La tematica della sessualità ha occupato uno spazio rilevante nelle diverse isotopie che attraversano la sua produzione degli anni Settanta. Le prime volte che ho letto i suoi libri di narrativa, conoscendo solo vagamente quale fosse la sua costellazione critica di riferimento, ho subito pensato che lei avesse in mente i lavori di M. Foucault sul rapporto tra sessualità, sapere e potere, salvo rendermi conto in seguito che il primo volume uscì nell’edizione francese solo nel 1976; senza parlare del suo allontanamento da un certo modo di essere intellettuale e di praticarlo.
Attraverso quali filtri letterari o più genericamente culturali ha dato voce alla tematica sessuale? E con quale funzione?
Bene, parliamo del tema sessuale. Al liceo ero comunista e una delle cose che ho imparato frequentando gente del partito era una censura su questo argomento. Ti dicevano: “È pericoloso”. Volevano dire che si poteva far l’amore con la moglie e con una compagna ufficiale, ma non con chicchessia solo per la passione carnale, perché questo ti allontanava dalla dottrina leninista facendoti diventare un sensuale nevrotico borghese. Tra l’altro questa accusa mi è stata lanciata da un vecchio compagno quando ho pubblicato Guizzardi. L’altra cosa da dire è che tutto l’apparato umano riguardante la vita emozionale, fantasie, sogni, nevrosi da vita domestica o da ufficio, desideri amorosi etero-o-omosessuale, per tutta la mia giovinezza sono stati considerati argomenti fuori luogo, non assimilabili a ciò che chiamano “la cultura”. Si capisce perché quando mi sono messo a scrivere, ho tirato in ballo volentieri quegli argomenti, tra cui la passione carnale senza le trivializzazioni italiane dell’eros – per lo più prodotte dall’altra incombenza dottrinaria del cattolicesimo. Mi piaceva inventare storie erotiche da ridere (come in Guizzardi) per mandare al diavolo i tabù dell'argomento. Quanto a Foucault: l’ho frequentato in America nel 1972 quando lui faceva un corso su Sade nella mia università. Il suo libro che mi ha più orientato a quei tempi è stato L’Histoire de la folie - e più tardi, il bellissimo La Volonté de savoir.
Visto il suo esplicito interesse verso il “teatro della crudeltà” di Artaud, mi chiedevo che tipo di sguardo avesse avuto nei confronti dell’esperienza del movimento Panicodi Arrabal, Jodorowsky e Topor.
Io non ho mai avuto un preciso interesse per il teatro della crudeltà, perché quello di Artaud è stato un sussulto dopo il suo viaggio in Messico, con la sua idea di confrontare il teatro occidentale (“pervertito” diceva) con un ritorno alla sacralità degli antichi rituali. Questo ha prodotto ai suoi tempi molta carta stampata e molte adesioni di moda, ma nessuna vera impresa di sovversione, perché Artaud è stato sempre bloccato dall’alta cultura ufficiale. Bisogna leggere Pour en finir avec le jugement de dieu, l’ultima sua impresa senza conseguenze. Artaud è una figura straordinaria nello scenario alla fine del XX secolo, ma l’alta cultura francese (tra cui Gallimard) l’ha messo in mostra come un vero matto, senza altri pregi. Tra tutti i suoi tentativi di trasformare l’idea della lingua, del corpo, della famiglia (ripudiata in toto), della letteratura e del teatro, c’è stata una passione per i film meravigliosi e strampalati dei Marx Brothers. Quello che più apprezzava, mi sembra, era la bagarre – il fatto che nei film dei Marx Brothers si arrivasse sempre o quasi sempre ad uno scontro comico di tutti contro tutti, che voleva anche dire uno stato di anarchia trionfante (come anche in molti film di Stan Laurel e Oliver Hardy), che era la vera musa e utopia di Artaud. E quando ho scritto il mio primo libro (Comiche, 1971) la bagarre era anche per me l’utopia massima, la gioia della confusione irrimediabile, il modo per abolire tutte le bandiere statali e dottrinarie.
Come in parte abbiamo già detto, il suo lavoro di ricerca si intreccia con il rifiuto di un certo modo di intendere la “Cultura ufficiale”. Questa spinta ha un suo corrispettivo temporale nel fermento di idee che attraversa gli anni Sessanta e Settanta, ma continua nella sua opera in forme diverse anche nei decenni successivi per arrivare fino ai nostri giorni. C’è una tendenza comune ad un certo filone artistico di matrice comica che ribadisce l’importanza di mantenere una “fedeltà alla strada”, non intesa in senso pasoliniano, quanto invece come naturale necessità di mantenere un rapporto vivo e di scambio con la “vita”. Credo che uno dei problemi dell’intellettualità italiana, forse per troppo provincialismo e arretratezza anche nel pensare i sistemi di potere, sia questa scissione totale dalla realtà di tutti i giorni. Non possono bastare letture quotidiane di saggistica e prosa, così come forse non è possibile pretendere una coincidenza totale tra l’attitudine intellettiva e quella del cuore. Ha mai vissuto come un conflitto il rapporto tra la sua spinta intellettiva e quella prettamente esistenziale? Cosa pensa e come si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad oggi, la sua riflessione su questo “vizio storico” della cultura italiana?
Qui mi propone qualcosa di molto difficile da dire, e comincerei dal fatto che stiamo parlando d’un argomento sempre più astratto e sempre meno afferrabile: stiamo parlando d’un artigianato, in un’epoca in cui la maggior parte degli umani vede tutto sub specie d’un funzionamento industriale. Stiamo parlando dell’artigianato delle parole, delle forme immaginative e del pensiero sensitivo – cosa che nell’approccio cartesiano e razionalista è un ossimoro, una contraddizione in termini, dunque un errore. La maggior parte della vita degli uomini segue questo errore, ma nei rapporti quotidiani deve presentarsi come un essere puramente logico. Ormai tutto l’apparato industriale che regola le forme letterarie è di tipo manageriale, e i manager non hanno modo di riflettere su questo senza diventare perplessi. Io non entrerò in questo problema troppo difficile, ma per capirci dico solo che l’artigianato delle parole e delle forme immaginative deve sempre più scrollarsi di dosso le sovrastrutture logiche e affidarsi all’errore, agli stati del corpo, ai voli di testa spregiudicati, e soprattutto evadendo dai modelli della comunicazione di massa. Queste sono deviazioni che pagheremo di nostra tasca, a volte con stati depressivi, altre volte con scritture strampalate. Ed è un modo per affidarsi all’errore – che non credo sia neanche una scelta, ma piuttosto qualcosa come spinte ventose che sorgono dal nostro passato, dalle situazioni in cui maturiamo e dal libero corso
dei pensieri.
Nel suo esordio letterario un posto rilevante è occupato dalla critica al concetto di “autorialità”, che colpisce tutto il mondo delle arti, soprattutto a partire dagli anni Sessanta. In che modo e secondo quale orientamento ha continuato a rapportarsi con la messa in discussione dell’idea di “Autore”, terminati gli anni Settanta? Che effetti ha avuto sulla sua prosa?
La prima risposta è questa: nell’ultimo secolo si è affermata sempre più nei paesi occidentali la trasformazione del vecchio soggetto che si diceva “trascendentale” (legato a un pensiero metafisico) a ciò che chiamerei soggetto autoreferenziale e pubblicistico. Questa parabola ha raggiunto livelli impensabili per l’infinita ripetibilità dei prodotti industriali, sempre sul filo dell’attualità che diventa l’unica attrattiva delle cose scritte. L’autore diventa la figura che garantisce l’attualità del “nuovo”, ed una figura autoreferenziale: un “io” come simbolo d’una privatizzazione dell’esperienza. Perché la letteratura diventa molto simile ai prodotti Ikea: l’una e l’altra simboli della vita senza errori, ognuno nella propria casetta, con la moglie, i figli e il proprio “io”, scrivendo 500 parole al giorno. Che effetti ha avuto tutto questo sulla mia prosa? L’instabilità totale, senza salvezza.
Se dovesse fare un confronto tra l’esperienza della Neoavanguardia e quella più recente del Luther Blisset Project dal punto di vista del rapporto con l’industria editoriale e mediatica, in che chiave leggerebbe le differenze o le similarità?
Non ho mai letto neanche una riga di Luther Bisset, dunque non posso rispondere.
Nei suoi esordi narrativi la ricerca linguistica si sviluppa all’insegna di un netto rifiuto del logocentrismo della parola scritta. All'inizio ad esempio attraverso filtri quali la “scrittura dei matti”, l’assenza di ogni volontà significante di Beckett e la parola spettacolare. Lei si definisce uno scrittore non di professione e più volte ha sottolineato la funzione espurgante del suo modo di intendere l'atto scrittorio (Le avventure di Guizzardi come testo nato dall’esigenza di liberare le malinconie). Ci sono stati dei blocchi mentali legati alla sua prosa che ha dovuto superare per riuscire ad assecondare l’“errore” scrittorio perseguito nelle prime prove narrative? Dei limiti culturali e quindi linguistici con i quali ha dovuto fare i conti per andare oltre?
A un certo punto (dopo Lunario del paradiso) avevo deciso a smetterla con la scrittura letteraria, perché i miei libri erano già assegnati alla categoria dell’umorismo, dunque io assegnato a un certo ruolo. Si configurava la necessità di passare al professionismo, che implicava la necessità di regolarizzare le mie fantasie e “piacere al pubblico”. Ero arrivato a un blocco mentale. Anche le nuove tendenze della linguistica, soprattutto francesi, non m’interessavano. In quegli anni c’è stata una diffusione di sigle della professionalità umanistica, come quelle della narratologia, in cui io vedevo la nascita d’una nuova sterilità accademica. Nel 1979 ho passato un periodo a Los Angeles, dove ho scoperto le ricerche di allievi di Goffman come Harvey Sachs, sui sistemi di conversazione, di narrazione e sui rituali quotidiani. Per due anni mi sono dedicato a questi studi, che trovavo stimolanti. Poi è avvenuto l’incontro con Luigi Ghirri, fotografo che andava elaborando un’idea del pensare per immagini. Qui il mio blocco mentale si è sciolto perché ho trovato nuovi amici, i fotografi, con idee più pratiche, meno astratte. Con quali risorse sono andato avanti? Per quanto ricordo: la convinzione che non sarei mai stato capace di “piacere al pubblico” come fanno gli autori di bestsellers; il fatto che l’invecchiamento ci stabilizza un po’ rispetto ai furori giovanili o medio-maturi; e insieme un’attrazione per le filosofie orientali, più illuminanti delle nostre filosofie post-socratiche.
Lei è uno studioso di letteratura angloamericana, oltre ad avere ovviamente un’ampia conoscenza di quella italiana. A partire dalle differenze linguistiche fino ad arrivare a quelle culturali, quali sono nel complesso le maggiori diversità riscontrate? Quale la natura caratteristica di entrambe?
Dipende molto dal tipo di lingua con cui parliamo e dal punto di vista da cui la vediamo. C’è un punto di vista diffusissimo per cui si ritiene che una lingua sia qualcosa di unitario, un insieme compatto, e che ad esempio la “lingua inglese” corrisponda a una parlata con confini precisi. Questa è l’idea d’una forma standard della lingua scritta: l’idea scolastica e dell’attualità. Quello che viene messo da parte sono le parlate specifiche, che riguardano più che mai la pratica letteraria (penso ai nostri Tozzi, Campana, Svevo, Gadda. Delfini, Landolfi, Saba, Anna Maria Ortese, Calvino, Manganelli, Baldini, ognuno con una sua parlata, sganciata dalla lingua standard). Ma a parte la pratica letteraria, qualsiasi parlante ha una parlata specifica più o meno marcata. In Inghilterra ce ne sono moltissime che io non riesco a capire: come quella di Birmingham, di Liverpool, di Manchester, di New Castle, oppure quella di Brighton dove abito da vent’anni e ancora non mi raccapezzo. Tra l’inglese standard e queste parlate c’è un salto, perché le due cose sono usate in situazioni diverse. Per questo ogni parlata fuori contesto fa risorgere la questione dello xenos, lo straniero, con possibili reazioni xenofobiche, più o meno mascherate. Lo stesso avviene se un lettore di bestsellers legge Gadda o Delfini o Manganelli: per lo più vedi una reazione para-xenofobica. Tutto questo fa anche sì che io, in quanto straniero, in Inghilterra sia ascoltato in modo diverso rispetto a un indigeno. C’è un atteggiamento giudicante da parte di chi mi ascolta, per capire a quale livello sociale mi colloco e se sono un tizio rispettabile o meno. Questa è un’esperienza che non riguarda soltanto me in quanto non-anglofono: anche i miei amici americani in Inghilterra si sentono ascoltati con criteri di sorveglianza per classificare la loro posizione sociale. Al contrario, il parlare americano presuppone subito una solidarietà linguistica con l’ascoltatore, qualunque sia il suo accento o la sua competenza nella lingua. L’enorme quantità di parlanti con origini diversissime fa sì che tutti si adeguino a un parlare medio, da cui si esclude ogni valutazione del livello sociale. Queste differenze linguistico-culturali determinano diversi tipi di discorsività e di conseguenza diversi modelli letterari. Ad esempio la “lingua Americana” si forma nella seconda metà dell’800 come una forma di solidarietà democratica che mette da parte le valutazioni del livello sociale: dunque un criterio di solidarietà di base (il grande maestro di questo è Mark Twain, seguito da Walt Whitman). Mentre la letteratura inglese, dopo Dickens, diventa sempre più scolastica. Non è un caso se le narrative inglesi più interessanti della fine ottocento siano quelle d’un autore scozzese (Stevenson), d’un autore d’origine polacca (Conrad), d’un americano stanziato in Inghilterra (Henry James), e nella straordinaria fioritura di autori irlandesi moderni (Joyce, Flann O’Brien, Beckett).
Lei ha iniziato a viaggiare sin da giovane, sbarcando negli Stati Uniti così come in Inghilterra, in un periodo storico in cui il viaggio era, se vogliamo, meno comune. In generale penso che la stessa esperienza del viaggio avesse durante gli anni Sessanta e Settanta un sapore di novità e di scoperta individuale molto diverso rispetto a ora, dove una sorta di colonizzazione dell’industria turistica ha invaso ogni angolo del mondo, togliendo in parte il gusto del viaggio come possibilità di stupirsi. Che effetto le ha fatto vivere certe esperienze in quegli anni? Ha mai dovuto fare i conti con una specie di “lutto dei luoghi”, magari rivisitandoli anni dopo?
Il “lutto dei luoghi”, come dice lei, comincia a diventare quasi assoluto negli anni 70-80. Questo è stato il punto d’incontro con Ghirri, perché i lavori che ho fatto con lui e altri venti fotografi avevano questo tema: “il nuovo paesaggio italiano” (allora chiamato postindustriale). Non so come, appena tornato dagli USA, nel 1980, m’è venuta l’idea di andare a cercare il minuscolo borgo vicino alle foci del Po dove era nata mia madre. Da quel momento ho cominciato a esplorare tutte le zone attorno al Po e fino al mare, prendendo appunti su quello che vedevo. In particolare mi colpiva la straordinaria fioritura di case rurali abbandonate, con una desertificazione delle campagne e nuovi villaggi-dormitorio. Lei ha rievocato i miei viaggi giovanili, che però risalgono a vari decenni prima. Il mio viaggio e soggiorno in Germania da cui è nato Lunario del paradiso risale al 1959, quando avevo ventudue anni; dopo di quello mi è venuto un fanatismo parigino, che è durato molti anni; dalla metà degli anni Sessanta mi sono innamorato della Tunisia, ed è stata una grande parentesi in cui volevo imparare l’arabo e ho viaggiato fino all’Algeria; poi ho avuto una borsa con cui ho studiato per due anni a Londra; e dopo, all’inizio degli anni Settanta, sono partito per gli Stati Uniti dove per due anni ho insegnato in un’università ai confini del Canada. Come dice lei, questi viaggi sono stati “scoperte individuali”, ma nel complesso ho l’impressione di aver vagabondato sempre in uno stato di stordimento, come credo siano tutti i viaggi turistici. E quando io e Jean Talon abbiamo fatto quel viaggio africano, dal Mali al Senegal alla Mauritania, da cui è nato Avventure in Africa, tutto quello di cui io e Jean parlavamo era appunto il nostro stato di stordimento come turisti. Solo quando ho soggiornato in un piccolo villaggio nella savana del Senegal, andando avanti e indietro per tre anni, non ho sentito quello stato di obnubilamento turistico, perché ero in una collettività e dovevo adeguarmi ai suoi movimenti quotidiani.
Nel “Il corpo comico nello spazio” lei analizza i comportamenti fisici del cinema muto americano attraverso le due categorie di movimento di Merleau-Ponty, quello astratto e quello concreto. Entrambi dipendono, come lei dice, da un diverso modo di utilizzare il corpo “come strumento di occupazione dello spazio” e questa è una riflessione che, credo, emerga soprattutto in Comichee in Le avventure di Guizzardi, nell'ambito dei territori del comico. A partire dagli anni Sessanta e Settanta si assiste ad una tendenza generale di rivalutazione della componente corporea, o meglio vengono messe in luce le pratiche di esclusione, perpetuate a scapito della fisicità. Penso da un lato alla rilettura di Artaud, agli studi di Foucault, a cui abbiamo accennato in una precedente discussione, agli studi di genere che hanno decostruito, e continuano a farlo, quelle che sono le pratiche di simbolizzazione operate sui corpi. Una diversa attenzione nei riguardi del suo uso avviene anche in altri ambiti, come quello della danza con il Tanztheaterdi Pina Bausch. Infine non posso non pensare alla nascita di un diffuso interesse della recente cultura occidentale verso alcune filosofie orientali (anche se spesso il nostro logocentrismo ha finito col creare delle deviazioni che poco hanno a che fare con lo spirito originario che le contraddistingue), nelle quali il corpo riveste un ruolo primario, perché sede fisiologica delle energie sessuali e emotive, vero motore dell’umano. Filo comune di questo calderone esperienziale è la rivalutazione della nostra natura primigenia, relegata ai margini della cultura o completamente distorta. Lei è partito da considerazioni proprie di un ambito ben specifico, come quelle sul comico, ma credo possa sussistere un legame con questa riscoperta dell’ultimo cinquantennio. Nel corso della sua attività le è capitato di tornare a riflettere sull'argomento del corpo, magari da altri punti di vista all'apparenza anche solo tangenziali? Se sì, in quali occasioni?
Il doppio registro delle mosse corporee di cui parlava Merleau-Ponty, quello astratto e quello concreto - marcati dal doppio gesto di mostrare (o indicare da lontano) e di afferrare (con vicinanza assoluta a un altro corpo) - per me era incarnato da due grandi attori comici: Buster Keaton (movimenti più astratti, prevalenza di gesti da lontano su quelli ravvicinati) e i Marx Brothers (movimenti concreti, prevalenza del gesto di afferrare o comunque di avvicinarsi al massimo a un altro corpo). Circa dieci anni dopo aver scritto quel testo sulle mosse corporee, ho pubblicato Narratori delle pianure, cambiando direzione rispetto alla mia maniera narrativa precedente. La differenza consisteva in un’inversione dell’atteggiamento corporeo – che, nei miei primi libri nasceva da una passione per la bagarre (il caotico aggredirsi tra umani, con mosse di scontro e vicinanza assoluta), e in Narratori nasceva da un guardare tutto a distanza, con mosse più astratte. Mi sembra che questa inversione di rotta dipenda molto dalla mia nuova frequentazione dei fotografi e in particolare di Luigi Ghirri, e dal lavoro fatto con loro sul nuovo paesaggio italiano. Questo lavoro è culminato in un bellissimo libro fotografico, col titolo goethiano di Viaggio in Italia. C’è una idea particolare, elaborata da Ghirri, che spiega lo stile fotografico prevalente in quel libro. Secondo questa idea ghirriana, la cosa più importante d’una fotografia non è ciò che sta dentro all’inquadratura fotografica, ma ciò che sta fuori: perché la fotografia non serve a rappresentare il mondo, bensì come metro o misura del guardare quello che ci sta attorno nello spazio. Così nelle foto di Viaggio in Italia non vediamo una rappresentazione del nuovo paesaggio italiano: vediamo solo suggerimenti di vedute qualsiasi con cui guardare il “qualsiasi” (la “qualsiasità” diceva Zavattini) nello spazio attorno a noi. E questa è una visione marcata da gesti del mostrare o indicare a distanza: il contrario della fotografia che afferra al volo le vedute esterne come bottino turistico. Io credo che questa sia stata la più importante influenza sul mio modo di scrivere, cominciando da Narratori delle pianure.