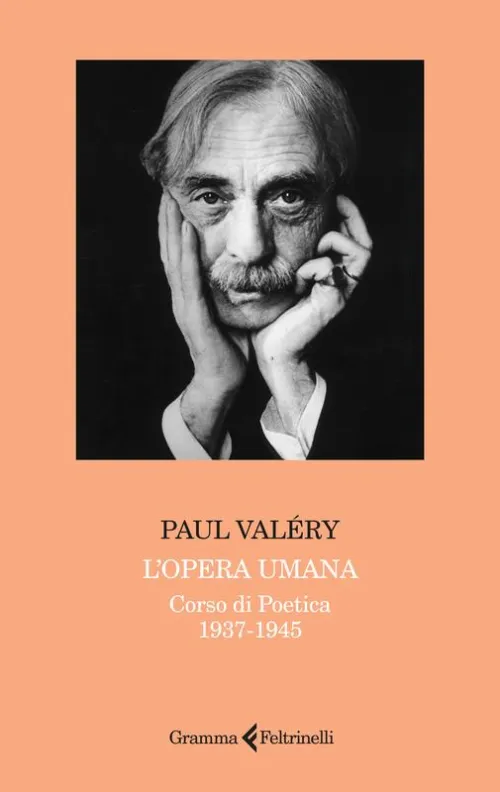La società-macchina fragile di Valéry
Si deve forse ai versi apollinei di Paul Valéry uno dei gesti più dionisiaci del Novecento europeo: incrinare per sempre l’evidenza della perfezione dell’universo, introducendo attraverso la poesia l’idea radicale della contingenza. Ciò che è in un modo potrebbe essere altrimenti e l’intero piano del reale apparire non come un compimento necessario, ma come un difetto provvisorio, una delle forme possibili che il mondo assume per necessità momentanea. Nel suo poema più noto, il Cimitero marino, alla perfezione immobile dell’ordine del mondo Valéry oppone l’esistenza mortale dell’umano. Segreto mutamento e mistero cangiante, conservato in terra, essa non è una sostanza, ma un vibrare continuo, un affiorare e un dileguarsi, un moto che nessuna metafisica può davvero trattenere. In questo contrasto si trova già l’anticipazione della sua filosofia: solo ciò che muta resiste; solo ciò che resiste può essere pensato. Una tensione che attraversa anche le lezioni del Cours de poétique tenute al Collège de France e ora raccolte da Gramma Feltrinelli sotto il titolo L’opera umana. Corso di Poetica 1937–1945, nella curatela di Maria Teresa Giaveri e Paola Cattani, con traduzioni di Maria Francesca Davì, Maria Teresa Giaveri, Antonietta Sanna e Paola Sodo.
Dall’intero florilegio, che attraversa tutti i temi della poetica di Valéry, da Leonardo a Monsieur Teste, con una interessante rivalutazione di un poco amato Voltaire, recuperiamo qui la lezione civile. Nell’incontro del 5 gennaio 1945, intitolato La società umana, Valéry torna all’idea che guida anni di corso: trovare, “di lezione in lezione, non propriamente l’oggetto, ma la sostanza stessa della lezione”. Non si tratta dunque di un semplice restauro filologico: a guerra ancora aperta il corso è l’occasione per rimettere a fuoco una delle riflessioni più lucide sulla fragilità dell’impresa europea e sulla necessità, oggi fin troppo evidente, di ricostruirla contro i totalitarismi mercantili e il rischio di nazionalismi risorgenti. Una nuova educazione europea, si potrebbe dire, parafrasando il titolo di uno degli autori solo in apparenza più distanti dall’opera di Valéry: Romain Gary. Il punto di partenza è una metafora economica: mettere in parallelo la fisiologia della produzione e del consumo delle opere dello spirito con l’economia materiale. Produzione, consumo, domanda, offerta, valore: le stesse parole, ma piegate a un altro regime di funzionamento. Nel mondo materiale i bisogni dipendono dal corpo; nel mondo spirituale i valori sono più soggettivi, tanto che “si può assolutamente fare a meno di nutrimento spirituale” (p. 277).
Nel farsi della conferenza, Valéry si accorge poi che tanto l’economia materiale quanto quella intellettuale sono impossibili in isolamento. Ed è così che lo comunica al pubblico: un Robinson può ancora fabbricarsi gli strumenti, gli artefatti materiali; ma un Robinson “pensoso” che si costruisca da solo la sua scienza o la sua teologia è assolutamente inconcepibile. Ogni produzione dello spirito, ogni artefatto astratto diremmo oggi, è immersa in ciò che chiamiamo società, benché l’uomo d’ingegno tenda a immaginarsi autosufficiente nel cerchio di luce della propria lampada.
Per affrontare il problema, Valéry diffida delle definizioni. La mente, avverte, “si accontenta di poco”: nel credere di capire c’è sempre un margine di rischio, un hazard, per riprendere le parole della poesia visiva di Mallarmé. Non si tratta di spiegare, ma di rappresentare: farsi una carta geografica della società che consenta di ragionare senza pretese metafisiche. Per farlo serve un osservatore situato e paradossale: un individuo immerso nel mondo ma dotato del privilegio di “non capire niente”. Solo così può vedere davvero. Come un Aristotele che osservasse qualcuno infilare una lettera in una cassetta: non vedrebbe un gesto ovvio, ma un rito incomprensibile, un’offerta a una divinità metallica. Gli sfuggirebbe la catena invisibile di convenzioni che trasforma un gesto minimo in un effetto distante (p. 282).
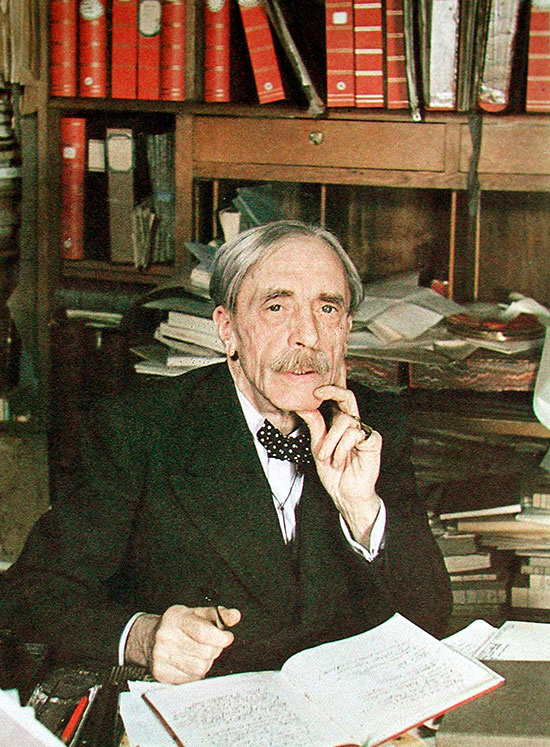
Su questo sfondo nasce la tensione tra simile e dissimile: riconosciamo negli altri una somiglianza — “hanno mani come noi” — ma li percepiamo anche come separati. La società si costituisce nella modulazione di questa oscillazione: diventare un po’ simili quando serve, ritornare dissimili quando occorre. Il contributo del poeta, dell’inventore, del matematico nasce proprio dal dissimile che offre qualcosa agli altri simili; e tuttavia, scendendo abbastanza in profondità, anche il dissimile dipende dalla lingua ricevuta, dai relè sociali che rendono possibile il suo gesto. Valéry introduce la nozione di relè: dispositivi che trasformano un impulso minimo in un effetto amplificato. Premo un interruttore e si accende una lampada; una pressione sugli occhi provoca uno svenimento; una parola altera uno stato affettivo. In tutti questi casi, “non c’è alcuna relazione quantitativa” né pertinente tra il gesto e il suo effetto (p. 288). Il nesso è qualitativo, non misurabile: un ponte tra ordini diversi. Il relè capitale è il linguaggio. È qui che il discorso di Valéry sfiora, senza ancora formularla, un’intuizione decisiva dell’ontologia sociale contemporanea: se il relè capitale è il linguaggio, allora ogni realtà sociale prende forma solo quando un gesto viene fissato in una traccia. Nulla di ciò che chiamiamo sociale esiste senza un segno che lo stabilizzi: un atto deve essere registrato da qualche parte per durare, per circolare, per essere riconosciuto. Senza una forma d’iscrizione — una firma, una nota, una regola messa per iscritto — gli atti non diventano oggetti sociali, restano effimeri, destinati a svanire come pura intenzione. È la traccia che dà realtà al gesto, che lo rende condivisibile e attribuibile. In filigrana si delinea quella che, in Maurizio Ferraris, diventerà la tesi della documentalità: l’oggetto sociale coincide con l’atto in quanto inscritto, con la sua possibilità di essere conservato, ripetuto, interpretato. Una società vive dunque non solo dei suoi relè, ma delle sue iscrizioni: la rete discreta di documenti, registrazioni, protocolli che permette alla vita collettiva di protrarsi oltre i singoli individui e di mantenere una forma riconoscibile nel tempo.
Un’idea che dialoga sorprendentemente con un'altra genealogia, di alcuni anni successiva alla lezione di Valéry: lo scambio intellettuale, ricostruito oggi da Etienne Anheim e Paul Pasquali per i tipi delle Éditions de Minuit, tra Pierre Bourdieu ed Erwin Panofsky: Bourdieu et Panofsky. Essai d’archéologie intellectuelle. Nel 1967, nella collana “Le sens commun”, Bourdieu traduce personalmente Architettura gotica e filosofia scolastica di Panofsky, pubblicata in inglese nei primi anni Cinquanta. Nella postfazione, il sociologo mette a fuoco il suo concetto di habitus: schemi pratici, forme che orientano senza determinare, iscrizioni incorporate che tengono insieme un mondo sociale. La forma come principio operativo, come traduzione sensibile di un ordine di pensiero: il nesso con la logica dei relè è evidente.
Da questa linea si arriva anche alla filosofia di Gilbert Simondon (1924–1989), che interrogava il problema della tecnica non come insieme di utensili, ma come processo di individuazione: un divenire che coinvolge macchine, individui e collettivi. Un artefatto funziona perché può essere acceso e spento, perché risponde a un comando e poi si interrompe. Un organismo, invece, si accende per sopravvivere: il suo “acceso” è la vita stessa, la risposta continua all’ambiente; quando si spegne, lo fa per sempre.
Ecco. La società, suggerisce Valéry, appartiene sorprendentemente a questo secondo ordine. Pur essendo fatta di atti, norme, relè, la sua durata non è quella delle macchine. E, diversamente da quanto si pensa in un mondo dominato da paradigmi che riducono il sociale a ciò che è parametrabile e ottimizzabile — una società si comporta come un organismo vivente: esiste solo finché rimane attiva, solo finché produce il prossimo istante. Sta a noi impedirne lo spegnimento.
Qui il volume di Gramma Feltrinelli, edito con attenzione e lungimiranza dalle curatrici, torna a parlarci con urgenza. Per Valéry, nel gennaio del 1945, la salvezza dell’Europa non stava in un ritorno ai miti identitari, ma nella ricostruzione di una società dello spirito: linguistica, relazionale, transnazionale. Oggi, nuove spinte neonazionaliste attraversano il continente e, agitate dal trumpismo — con la sua visione delle nazioni come contenitori chiusi, popolati da oggetti sociali enumerabili e scambiabili — pretendono di ridurre la politica a una lista chiusa di slogan lastricata di buoni propositi propagandistici. Ma una società pensata come inventario chiuso è una società già spenta: una macchina senza vita, un insieme di pezzi inerti.
La lezione di Valéry indica invece una costruzione che vive soltanto se si rinnova, se conserva il linguaggio, se tiene aperti i relè, se mantiene attivo il processo che consente agli individui di essere simili e dissimili, contigui e distanti. I nostri relè sociali sono diventati digitali. Le opinioni, spacciate per modelli politici, attraversano i circuiti opachi della persuasione, orientando le passioni sociali. Gli attacchi all’Europa si presentano come algoritmi, disinformazione, chiusure doganali.
Tornare a Valéry significa allora ricordare che ogni società è un’opera umana. Un artefatto vivente, fragile e tenace; una costruzione che si difende continuandola; una promessa che si rinnova ogni volta che qualcuno parla, scrive, interpreta, crea. Nulla di ciò che chiamiamo umano esiste senza un relè che lo trasmetta. E nessuna società sopravvive se lascia che il proprio funzionamento si spenga.