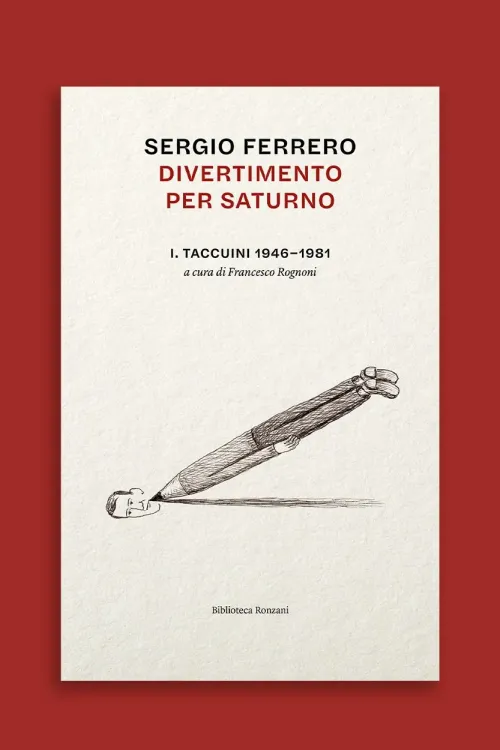Sergio Ferrero: i taccuini di Saturno
Esce per la prima volta, in un’edizione di elegante fattura il diario, o forse sarebbe meglio chiamarli carnet, appunti, di Sergio Ferrero, Divertimento per Saturno, che infatti reca come sottotitolo Taccuini, 1946-1981, I t.; 1982-2008, II t., a cura di Francesco Rognoni, Dueville, Biblioteca Ronzani 2024, con il contributo dell’Università Cattolica di Milano. Corredati da un dovizioso apparato iconografico e da note, i due volumi recano le stigmate di un’antica e quasi persa sapienza editoriale, nella qualità e grammatura della carta, nella cura complessiva dell’impaginazione, nella grafica stilizzata e arguta delle due copertine a opera di Franco Matticchio e infine, in un risvolto, il lucido, affettuoso e sincero ricordo dell’amico poeta Basilio Luoni.
Sergio Ferrero (Torino 1926-Lezzeno 2008), negli anni giovanili commesso di libreria, redattore, traduttore, giornalista, instancabile viaggiatore, ha conosciuto ed è stato sodale di molti esponenti della vita culturale italiana: Saba, Sereni, Erba, Bo, Cattafi, Citati, Soldati, Praz, Testori, Baldacci… Ha scritto romanzi e racconti: Gloria (1966), Il giuoco sul ponte (1971) finalista al premio Strega, apprezzato da Cesare Garboli, Anna Banti e Natalia Ginzburg, A moscacieca (1985); La valigia vuota (1987), secondo al premio Campiello; Il ritratto della Gioconda (1993), premio Comisso; Gli occhi del padre (1997), premio Bagutta; Le farfalle di Voltaire (2000); Il cancello nero (2003).
Come tutti i libri non volontari (epistolari, diari, taccuini), Divertimento per Saturno, riproduce in mera sequenza cronologica appunti, sogni, letture, riflessioni, biglietti, o anche solo elenchi di nomi e incontri, viaggi, film visti, canovacci di racconti, fatti di cronaca nera, recensioni, bon mot, tutto ciò insomma che nella vita filtra e si affastella in ordine sparso, per deporlo con levità sulla pagina, dove finalmente prende forma e si placa. In un’osservazione del giugno 1967, scrive non a caso Ferrero, pensando a un trasloco, ma non solo a quello: «Mi sono domandato se non servirebbe a impedire che proprio tutto, di questa mia casa, scompaia, un elenco, un inventario. Non altrimenti, di una vita si fa un’autobiografia, un’opera letteraria: ancora una volta mi sono proposto la scrittura come esorcismo». Pagine dunque fitte di nomi, genealogie di personaggi noti o sconosciuti, ricostruite con amabile pedanteria, per creare un sottofondo, un chuchoter discreto, un via vai di voci, di volti, di comparse che attraversano tutte le stanze della vita, senza alcuna intenzione esemplare, mettendo a dimora quelle illuminazioni che una scrittrice, presente in queste pagine, in un bel libro definì «i disincanti lucidi» (Clotilde Marghieri Amati enigmi). Questa è la magia della scrittura di Ferrero, per cui in un libro di misurata sapienza letteraria e umana, i giorni di una vita, la vita di tutti, trascorrono come proiettati sul concavo cielo del Planetario: albe e tramonti che lentamente sfumano le une negli altri, in assorta penombra.

Sul versante prettamente letterario incontriamo “recensioni” di opere del passato, per lo più, ma anche del presente, e perfino qualche stroncatura di grandi autori, come quella di un romanzo giovanile di Balzac, autore da lui per altro amato, o di un grande film come Otto e mezzo di Fellini, e non rinuncia neppure alla staffilata: «Quelle di Ibsen, più che tragiche donne sono tragici capponi», alternando citazioni non di rado preziose: «Si tu ne m'aimes pas, aime au moins l'amour che tu m'inspires» (M. Sachs). Non mancano i giudizi taglienti, o quantomeno le sue riserve, su alcuni mostri sacri (Yourcenar, Moravia, Pasolini, Cioran, Cecchi, Calvino, Pavese…), e sull’eterno mainstream (convenzioni e convinzioni) che lo induce a riflettere: «Non conosco uno scrittore importante che abbia accettato di agire tra le coordinate e le ascisse tracciate dall’ideologismo e della retorica correnti al suo tempo… Quante volte invece si osserva oggi in chi scrive l’orientamento preliminare sui luoghi convenuti della cultura. E come il lettore lo va subito ricercando a sua volta». I pezzi migliori, e di gran lunga più frequenti, riguardano succosi episodi che coinvolgono scrittori colti in circostanze non paludate o accademiche, compreso sé stesso. Ad esempio la cantatina in casa Sereni, dove Ferrero giovane si reca accompagnato da un Saba entusiasta delle sue doti canore: «Mi fece cantare certe vecchie canzoni francesi che conoscevo, ma poi anche Lili Marlene … e dovetti ripeterla anche a casa di Vittorio Sereni… Era l’ora di cena, ormai, e la moglie di Vittorio era indaffarata, le bambine avrebbero già dovuto essere a tavola, ma Saba volle lo stesso che io cantassi e che tutti stessero a sentire, anche Vittorio …l’intero mio repertorio e Lili Marlene, tanto che ancora a distanza di anni rabbrividisco all’idea di ritrovarmi davanti alla signora Sereni». Memorabile il ritratto del vecchio Penna: «Un po’ curvo di spalle, incerto, ormai, sulle gambe. Muovendosi spinge in fuori una pancetta puntuta che i pantaloni a vita altissima, sorretti da bretelle, non bastano a nascondere. In camicetta, con gli occhiali neri, pare un pensionato delle poste, un vecchio attore del variété». E nei molti passi che riguardano Umberto Saba, spicca quello sulla correzione delle sue poesie, a cui il poeta lo costringe in un caffè di periferia a Milano, tra il vociare degli avventori. Per non parlare della visita fatta a Parigi, accompagnato da Citati, a un Cioran che abita in una casa con il cesso sul ballatoio, circostanza che sembra avere estasiato Citati!
Dalla congerie di appunti, scorci e riflessioni, emerge il carattere, o meglio il particolare timbro della voce di Ferrero: attento ai minimi dettagli, incuriosito da tutto, non appartiene alla genia dei memorialisti che ripercorrono la propria vita consapevoli che sia una vita degna di essere ricordata, si limita a riprodurre le sensazioni di cui è costellata, lasciandole in una perplessa e a volte attonita sospensione. Sotto questo profilo, il tempo non viene di volta in volta rievocato o interrogato, ma avvolto in un eterno presente, circoscritto nell’attimo, in quello che lì, in quel momento, fu in grado di assorbire la vigile testimonianza di un uomo, come in questo ragguaglio di un semplice stato d’animo: «Il passo di chi, al mattino, entra senza neppure tentare di evitarle in pozzanghere di malumore». Capita che Ferrero colga al volo un gesto sgarbato, un’intenzione che non sfugge alla sua moralità istintiva, priva di pregiudizi e dogmi, ma non indifferente: «A Venezia, il bottegaio che annaffia gli scalini del ponte accanto alla sua bottega perché i turisti poveri non ci si possano sedere a consumare le loro merende».
A questo frenetico viaggiatore, spessissimo sulla rotta Parigi-Grecia, le occasioni di registrare caratteri, situazioni e paesaggi non sono certo mancate. Tra le tante, la bella cartolina da una Varsavia (1968) immota che «conserva ancora qualcosa di particolare, proprio come in una impronta della campagna che la circonda, della immensa campagna che è la Polonia». O il ritratto preciso, da Wanderer accorto, senza la smania del baedeker o dell’esotismo à tout prix, di Singapore: «La città piacevole anche dove è nuova. La città vecchia pulita. I giardini dappertutto. E magnolie, ma a grappoli di fiori piccoli e senza profumo. Senza profumo è un po’ tutta l’isola che altrimenti mi ricorderebbe la Polinesia. Bugis Street, di sera, gremita di bancarelle festose che poi sgomberano per lasciare il posto, dai marciapiedi al centro della strada, ai tavolini dei ristoranti-bar. Ma allora non è più allegra. Torva, anzi. Con la gente che viene decisa a divertirsi e gli invertiti in abiti da donna che si aggirano, torvi anche loro, perché nessuna incertezza, nessun brivido neppure di conquista, tenta ormai la loro follia». Non tutto gli piace, si capisce, ad esempio in una lettera a Gianni Clerici confessa la sua insofferenza totale per Napoli, città vivace e teatrale che, al contrario, si pensa avrebbe dovuto essergli congeniale!
Col passare degli anni, fatalmente, qua e là affiora il pensiero della morte e della vecchiaia, non senza un tocco di valoroso stoicismo: «Mentalmente vado da stanza a stanza come un antico mercante di schiavi. Mi guardo in giro con occhio gelido … Persino i libri sono troppi, ormai, per me. E venderli, lasciarli, dimenticarli, sarà una specie di prova generale per la volta in cui dovrò lasciare tutto. Un tempo era una vertigine, per me, pensare di staccarmi dalle cose che amavo. Adesso so che non me ne importerà più niente». Ma anche il pensiero della fine è legato alla concretezza dei luoghi, all’immaginazione fattiva dello scrittore che vuole rappresentare ciò che, ovviamente, non è rappresentabile: «Dal treno, in un lampo, vedi un posto: una strada di città, un viottolo di campagna, una scogliera che si scopre nell’intervallo tra due gallerie. Lo noti appena, ma lo noti, anche se subito te ne dimentichi. È il posto dove morirai, dove sarai ucciso, magari, qualche tempo, qualche anno dopo» (come Zola che, ad ogni trasloco, individuava subito dove mettere il letto in cui sarebbe morto). L’approssimarsi della fine evoca una processione, ma non sono le nere figure della danse macabre nel famoso film di Bergman, bensì un’altra, più domestica sfilata di piaceri semplici e concreti: «Le cose che rimpiangerò morendo: gli amici, i libri, i pomodori, il basilico, il rosmarino, la menta, l’aglio, il pane, il profumo dei gelsomini, i cani, i gatti, le pesche a pasta bianca, l’olio, il tè, il riso».
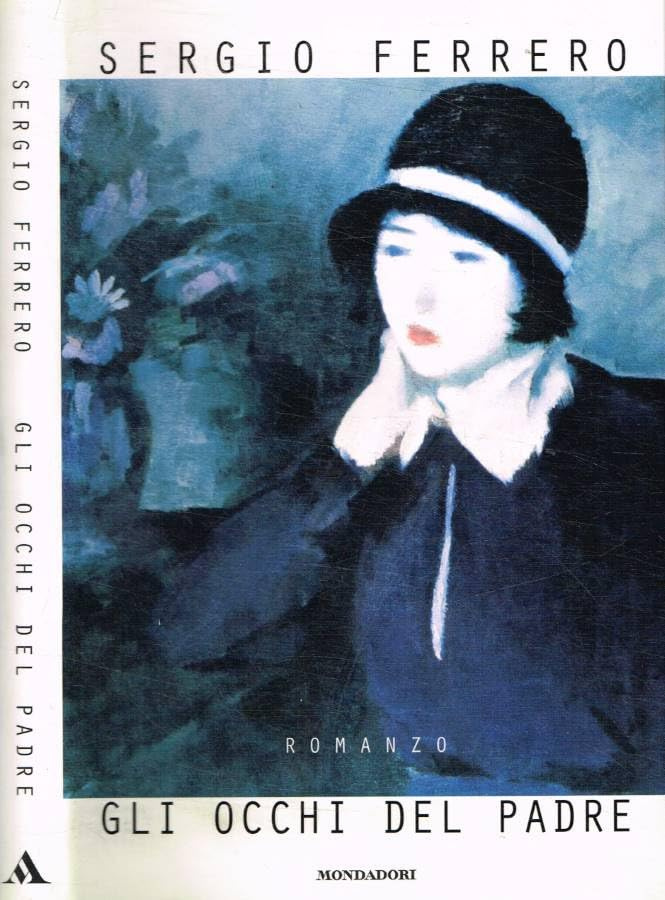
I carnet di Ferrero sono una miniera di nomi, fatti, letture, da cui è quasi del tutto assente, come nota in modo opportuno Rognoni, ogni accenno ai fatti politici, mentre abbondano le spigolature di fatti minimi, inessenziali, quasi a ricordare che la vita, quella vera, di questi si compone, in un inesausto caleidoscopio: il grande pugile Sugar Ray Robinson che entra in Galleria a Milano per sfuggire ai fan nel negozio di Borsalino, e si compra tutti i cappelli che ci sono ringraziando la commessa come la “Signora Borsalino”; le infinite storie di gatti, Mascherina, Bruttina, Draghino… che entrano ed escono dalle case, si arrampicano sugli alberi, scompaiono e ritornano; l’anziana suorina che si guarda riflessa in un quadro che riproduce il Cristo come se fosse uno specchio dove aggiustarsi il trucco; il tema spassoso di un bambino su Gioberti «Gioberti era un uomo, anzi un prete»; la vecchia snob che accusa i gladioli di non essere commestibili come gli spinaci; Erri De Luca che «sembra un personaggio di un romanzo di Hermann Hesse tradotto da un germanista napoletano».
Il bricolage poetico di Ferrero trova riscontro nel suo sguardo sulla realtà, e nei momenti di grazia fonda soggettività e oggettività in una mirabile sintesi metaforica: «Non mi voltare le spalle, non stancarti di guardarmi, non annoiarti di me, non lasciare la mia mano, non slacciarti dalle mie braccia: l’albero pare sempre uguale, se lo guardi, eppure vive, cresce, si trasforma. Cosa ti aspetti: che diventi una statua? Perché non vuoi che io sia l’albero della tua attenzione? Avrei potuto, in altri tempi, farne un sonetto». C’è come una lieve malinconia nello sguardo di Ferrero, a tratti ilare, irrispettosa, animata da uno scanzonato senso della burla, che non gli permette mai di dimenticare di essere ciò che è, un operaio di parole, né di occultare la vanità della sua bislacca vocazione o professione: «Mi sono ingozzato di parole e non so più, non saprò mai più cosa farmene».
Capita, infine, che un autore incontri il suo mentore postumo, quantomeno editoriale, qui nella persona di Francesco Rognoni, anglista di vasta competenza, fine e appassionato lettore e scrittore, che a questo zibaldone si è dedicato con partecipazione, meglio, con trasporto. Non solo lo ha accompagnato con note sempre discrete ed essenziali, ma lo ha impreziosito di un’introduzione magistrale che, ecco il piccolo miracolo della letteratura, si ricongiunge spontaneamente, fin quasi a mutuarne la trasparente filigrana, alle pagine dell’autore curato. Perché leggere Rognoni, prima o dopo Ferrero, è la conferma che esiste una civiltà delle lettere, esiste ancora, in un ideale passaggio del testimone, dove la vigoria di chi lo consegna e di chi lo riceve contano forse meno del testimone stesso, pegno di una nobile fedeltà. Ciò che Ferrero fa con le innumerevoli sfaccettature della sua vita, Rognoni lo fa con Ferrero, ricostruendone il ritratto umano e letterario. Certe osservazioni valgono per l’uno come per l’altro: «Il suo gusto nello stendere biografie minime, il quasi automatismo con cui – forse per accertarsi della sua stessa realtà – tracciava le coordinate della vita di personaggi reali, artisti, avventurieri, scrittori o uomini o donne di spettacolo, spesso sullo spunto di un loro ritratto, un disegno o una foto appiccicata negli album di ritagli che fino all’ultimo avrebbe arricchito, colla e forbici sempre a portata di mano, come fanno o facevano quasi tutti i bambini». Quel gusto Ferrero e Rognoni lo condividono e rende il saggio introduttivo un’ideale prosecuzione del libro nel suo complesso, quasi a confermare che i veri libri, la vera letteratura, genera e viene generata dalla vita e dai libri che la rispecchiano con onestà, libri e vite colti in una concordia discors che ci affascina e ci guida in tempi da cui, ancora e più che mai, sembra levarsi l’accorata esclamazione di Hölderlin : Wozu Dichter in dürftiger Zeit?