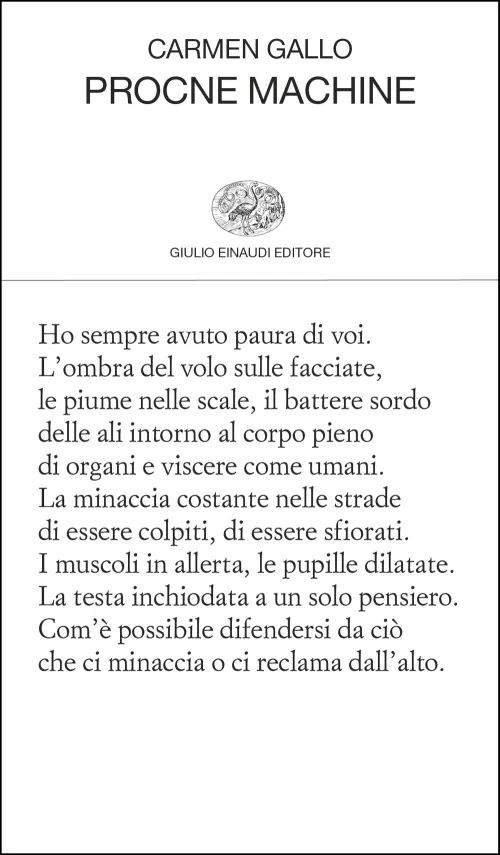Carmen Gallo e la macchina del mito
La scena è sempre la stessa: la violenza, l’ambiguità, la paura. I libri di Carmen Gallo portano con sé questo tratto distintivo e Procne machine (Einaudi, 2026) non fa eccezione: insieme a Stanze per una fuga. Poesie 2014-2024 (La vita felice, 2025) e a Tecniche di nascondimento per adulti (Italo Svevo, 2024) formano la cartografia di una dimensione oscura del nostro tempo, di fronte alla quale non riusciamo più a evadere, perché tutti gli strumenti della rimozione (narcisistica, capitalistica) sono crollati. Non resta che metterci davanti all’orrore e camminarci dentro, trovare strategie di acclimatamento per comprenderne la storia, la mitologia, la presenza pervasiva nei nostri immaginari esplosi.
Procne machine si colloca come logica continuazione di un’opera di poesia fra le più coerenti degli ultimi anni, che nondimeno non smette, a ogni prova di scrittura, di esplorare forme nuove per indagare ciò che non abbiamo il coraggio di vedere, di accettare. In questo senso, Procne Machine ha un rilievo speciale: non solo perché rappresenta l’approdo per l’autrice alla storica collana Bianca, ma anche perché fra le sue opere è senz’altro il più audace – e riuscito – marchingegno formale. Procne Machine è una macchina di scrittura che, pur nella concisione, dispiega una polifonia impressionante: per ampiezza di riferimenti culturali (dalla scienza all’antropologia, dalla mitologia alla musica rock), per varietà dei generi (dalla prosa alla poesia lirica, dal poemetto all’ekphrasis, passando per la riscrittura e la traduzione) e infine per la geometria dei capitoli grazie a cui le parti del volume, pur distinte, convergono insieme al senso globale di un’esplorazione poetica mai convenzionale.
Il libro si apre subito con un precipizio: il verso «Ho sempre avuto paura di voi». Da qui deriva l’intensità straniata della poesia di Procne machine, dal fatto che il libro prende le mosse da una paura personale (l’ornitofobia) che nondimeno subito si connette a una dimensione più vasta, profonda, collettiva, come se le pagine del libro fossero lo sviluppo di un’indagine e al contempo il farmaco segreto che possa scacciare la paura iniziale. Così, se la prima parte, la sezione Aprile (nell’eco continua dell’amato T. S. Eliot) indaga i cambiamenti climatici che hanno mutato irrimediabilmente il nostro pianeta e che trasformano il comportamento migratorio dei volatili, ormai incongrui e sempre più violenti ospiti delle nostre città, nella seconda parte che porta il titolo del volume, Procne machine, si dà spazio all’esplorazione profonda dei miti e delle riapparizioni culturali (da Sofocle a Ovidio, da Viriglio a Shakespeare, fino a J. M. Coetzee e Laurie Anderson) che hanno al centro il canto degli uccelli e, in particolare, le figure di Procne e Filomena, vere e proprie guide del volume.

Come è noto, al centro del mito c’è un episodio di indicibile violenza e di trasformazione: Tereo, marito di Procne, stupra Filomena in un bosco e le taglia la lingua per impedirle di rivelare l’orrore che ha compiuto. Nondimeno, Filomena riesce a raccontare ciò che ha subito («il dolore ha molto ingegno, dice Ovidio», p. 20) e le sorelle, per vendicarsi, decidono insieme di uccidere il figlio di Procne e Tereo, Iti, e di darlo in pasto al marito. Tereo, una volta compreso ciò che è accaduto, vuole uccidere le sorelle e si mette al loro inseguimento, ma gli dèi li trasformano in uccelli: Tereo in upupa, Procne e Filomena, in rondine e usignolo. Il libro si mette dunque a indagare il legame – ancestrale per l’Occidente – fra stuprum e silenzio, fra la violazione del corpo femminile, la privazione del linguaggio e il canto, indecifrabile compensazione della violenza subita.
Non solo sulla figura del doppio dunque – uno degli elementi caratteristici della poesia di Gallo –, Procne machine lavora, come mai prima nei suoi libri, sulle lacune, gli omissis e le sostituzioni simboliche e i refrain che popolano i miti occidentali, mettendone a nudo i più reconditi divieti e i gesti archetipici, le contraddizioni e i paradossali ritorni figurali che ancora oggi ci perseguitano: «Susan pensa alle figure, a quanto siano necessarie per coprire ciò che non riusciamo a raccontare» (p. 58). In una miriade di personaggi e di microstorie, questa poesia evoca davanti a noi una sterminata sequenza di episodi di cui siamo, per lo più, portatori immemori e ci costringe a riconoscerne il peso, il marchio, lo stigma: quanto gravano sulla nostra presunta libertà di agire e sul nostro rapporto di felicità con il mondo che abbiamo di fronte. Procne machine è in fondo una macchina mitologica che cerca di rivelare sé stessa: «Quanto pesano i padri nella testa. L’allodola continuò il suo volo esausta, gravata dal peso e dal ricordo, nel canto assordante di un’infinità di uccelli costretti a fare grandi cerchi nell’aria, senza mai toccare terra.» (p. 38) Al cuore del volume, siamo così messi di fronte a una meditazione sull’orrore della memoria collettiva e sui suoi luoghi comuni, sul filo segreto che lega nei millenni il sopruso, il silenzio e il privilegio del racconto.

Non per caso, però, è a questo punto che si apre la seconda, sorprendente, metà del libro. Nell’economia di Procne machine, la seconda parte risponde alla pars destruens della prima: se il mito è una macchina che riproduce e tramanda violenza, una macchina che replica sé stessa e le sue figure, è anche il luogo che offre il materiale di una trasformazione. La materia mitica e letteraria del passato diviene strumento per una ricreazione, una palingenesi che non cancella il dolore e la povertà di ciò che significa trasformarsi. Di questo tratta il poemetto di 473 versi Le metamorfosi (forse, il vertice dell’intero volume e dell’opera di Gallo), in cui si narra la storia di due uccelli impagliati, il cui canto – a differenza di quello delle mummie di Federico Ruysch di leopardiana memoria – è sciolto dal ripetersi nel ciclo dei millenni e è invece integralmente compiuto solo grazie alla propria combustione. Dal fumo del loro olocausto («tutto era fumo e bruciava/ lentamente e nero», p. 75) sorge la sequenza finale di testi: una teoria di traduzioni e riscritture che indaga come il mito del canto degli uccelli abbia lavorato nello specifico della poesia (maschile) e se ne riappropria.
Se nel finale di Paura degli occhi (2014), Gallo aveva scritto che si trattava di «sostenere lo sguardo/ del disastro», qui ora si tratta di farlo, stando negli ingranaggi stessi del linguaggio. La poesia, proprio in quanto traduzione, esce dal ciclo delle ripetizioni e diventa capace di redimere, in un minimo gesto, tutta «la complessità del fango e del sangue» (p. 85) di cui è fatta la storia della parola occidentale. Nella voce che ritrova, rilegge e trasforma Keats, Shelley, Arnold, Tennyson, Hardy, Yeats e Éluard, siamo come messi di fronte a un discreto lavorio alchemico di conversione; e così a Shelley che scriveva «Le nostre canzoni più dolci raccontano/ i pensieri più tristi» risponde nei secoli Éluard: «La nostra primavera è una primavera che ha ragione». Nel linguaggio della poesia, la traduzione dischiude una possibilità nascosta, la possibilità di un sovvertimento minimo, di un balenio di consapevolezza liberatoria. E forse la paura che avevamo provato all’inizio era solo una paura da nulla, si tratta in fondo soltanto – come canta Lou Reed – di Turning time around, di far girare in tondo il tempo per ritrovare le sue figure al nostro fianco: «E a quel punto/ qualcosa mi ha spinto/ e sono caduta anche io/ con lo stesso volo,/ con lo stesso doppio schianto/ e le sono rotolata accanto/ e ci siamo ritrovate di nuovo/ in un angolo fianco a fianco» (p. 66).