Straniamento / Edgar Hilsenrath, Notte
Edgar Hilsenrath lavora al suo primo romanzo per circa tredici anni, dal 1944 al 1957. Scrive ovunque, nei ritagli di tempo, senza alcun ordine; prima in Palestina, poi in Francia, poi negli Stati Uniti. Non conosce i ferri del mestiere, non ha modelli letterari, è uno dei tanti ebrei tedeschi deportati in Ucraina e sopravvissuti per miracolo. Nel 1954, in mano, ha 1.250 pagine manoscritte che diverranno la metà solo tre anni dopo, questa volta dattiloscritte, peccato che manchi un editore disposto ad accogliere un testo del genere. Nel 1964 un’importante casa editrice di Monaco di Baviera si fa avanti, ma poi quasi tutte le copie finiscono fuori commercio, poiché molti sopravvissuti all’Olocausto si sentono offesi dal ritratto che Hilsenrath fa degli ebrei. In Germania, pensate, Nacht riapparirà solo 14 anni più tardi, dopo essere stato tradotto in Olanda, in Inghilterra, in America. Edgar Hilsenrath è scomparso quando questo articolo era già stato consegnato, il 30 dicembre scorso: aveva 92 anni e indossava con fierezza un paio di irsuti baffi bianchi. La notizia è che a più di mezzo secolo dalla prima pubblicazione Notte (Voland, pp. 576, euro 20) arriva in Italia, nella traduzione di Roberta Gado.
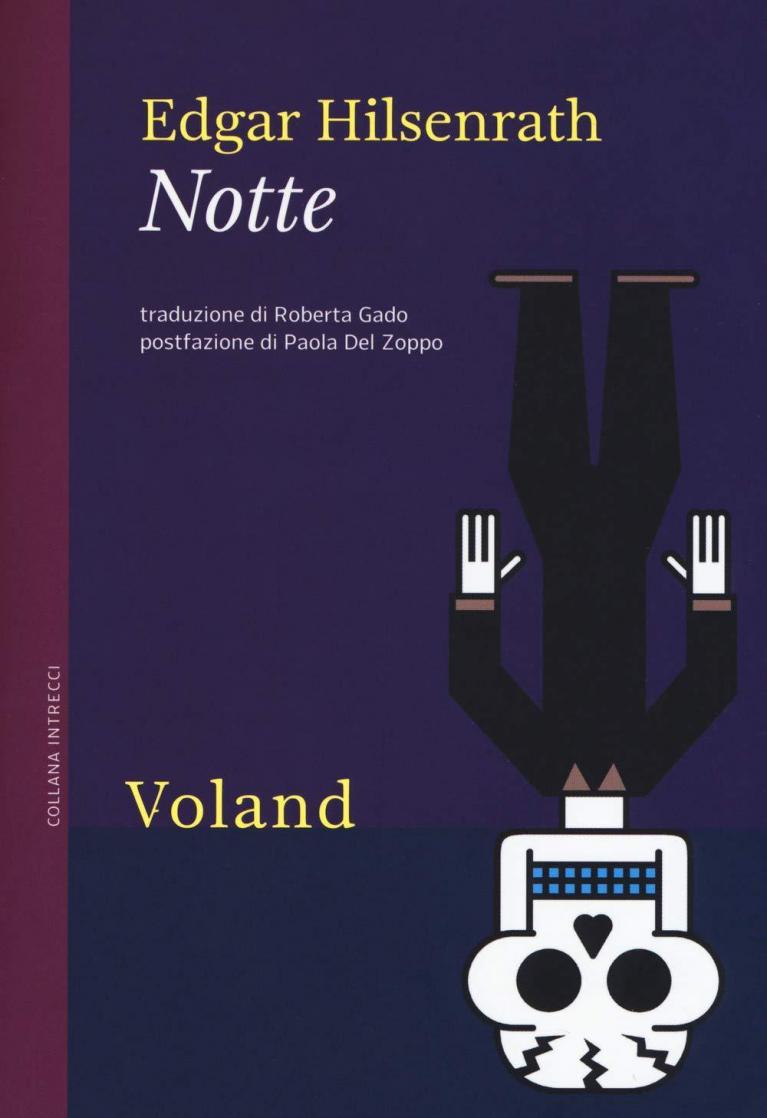
Anche il lettore italiano, da qualche mese, può trovarsi di fronte all’esperienza di Ranek nel ghetto di Prokov, nell’Est romeno. È difficilissimo non pensare alla vita di Hilsenrath leggendo le vicende raccontate nel libro, ma attenti a non giustapporre la figura del protagonista a quella del suo autore. Certo, tutto fa pensare che le due esperienze possano in qualche modo somigliarsi. Sfogliando le pagine di Notte si è davanti a una carrellata cinematografica di esistenze ai limiti. L’asilo notturno è il posto nel quale Ranek sosterà più a lungo. Non è nient’altro che un rudere malmesso nei pressi della stazione vecchia, ed è a pochi passi dal bordello del ghetto, non molto lontano dal fiume Nistro. All’interno si muovono i personaggi, come fossero pedine di una scacchiera. C’è chi dorme sotto al pancaccio, o vicino alla stufa; c’è chi trascorre la notte attento a non toccare le pustole del vicino, a non contrarre il tifo petecchiale; c’è chi non apre la bocca da molto tempo, letteralmente, perché ha dei denti d’oro e nel sonno può capitare che qualcuno glieli strappi, perché i denti d’oro corrispondono, in una logica di scambio, a molti sacchi di farina e se va bene anche a un buon brodo. Gli spicchi di luce che entrano nel dormitorio sono minimi, si smorzano dopo il primo albeggiare.
La vicenda di Ranek, in sé, è la storia di uno straniamento, di un lento sottrarsi alla logica dell’umano e del sentimentale. La spersonalizzazione costante del protagonista non rivendica né rinnega nessuna morale, è quel che è e basta. Conta solo cosa travalica la bocca dello stomaco di un uomo con il minimo sforzo; conta solo dove restare una notte per proteggersi dal freddo. Lo sguardo è vivo esclusivamente quando gli occhi di qualche personaggio si posano su una merce con valore oggettivo di scambio: delle patate, un pettine, un paio di scarpe non ancora del tutto consumato, un portacipria perduto per strada da una prostituta, del tabacco che non sia vecchia erbaccia intumidita.
I personaggi ombra che orbitano intorno al protagonista a volte restano incagliati nelle loro fisionomie – la vecchia, la gobba, il Rosso – per poi caratterizzarsi lungo il corso della storia grazie a dettagli triviali legati alla loro disumanità. La gobba, ad esempio, sembra essere dannata fin dall’inizio, a prescindere da ogni disgrazia contingente; muove i suoi passi all’esterno del bordello e scorge negli occhi di Ranek quelli di un malvagio innocuo, a cui offrire se stessa in cambio di una mela. Hofer e Blum, invece, sono i due medici della comunità (ci si chiede se vale ancora avere un titolo in quel posto, se la stessa parola comunità abbia ancora un valore semantico attendibile). Sono due momenti molto forti quelli in cui i due medici dovranno districarsi tra un parto e un aborto in condizioni miserabili, senza un tavolo d’appoggio, senza illuminazione, senza strumenti, con un secchio d’acqua che va economizzata, perché altrimenti non potranno lavarsi per giorni. A un tratto Hilsenrath scrive che uno dei medici aveva «la strana sensazione» di non controllare più «il respiro della donna, ma la dentatura di una cavalla non più giovane al mercato nero».
Le donne del romanzo, compagne dell’abisso nel quale Ranek si muove, sono anch’esse manichini prestati alla Storia. Molte di loro sono costrette a fare i conti con la sua impotenza, sintomatica, ancora una volta, di una vulnerabilità più profonda, non circoscrivibile soltanto all’atto sessuale. Debora, forse, è l’unico personaggio della narrazione non del tutto irrisolto e sconfitto. È la cognata, ossia la moglie del fratello del protagonista, che resta per troppo tempo moribondo nel sottoscala del dormitorio, prima che qualcuno, finalmente, gli estragga con forza e cinismo quei molari d’oro.
Già con Orgasmo a Mosca (Voland, 2016) Edgar Hilsenrath aveva dimostrato di essere un autore lontano da quelli che si possono definire gli scrittori «socialmente utili».
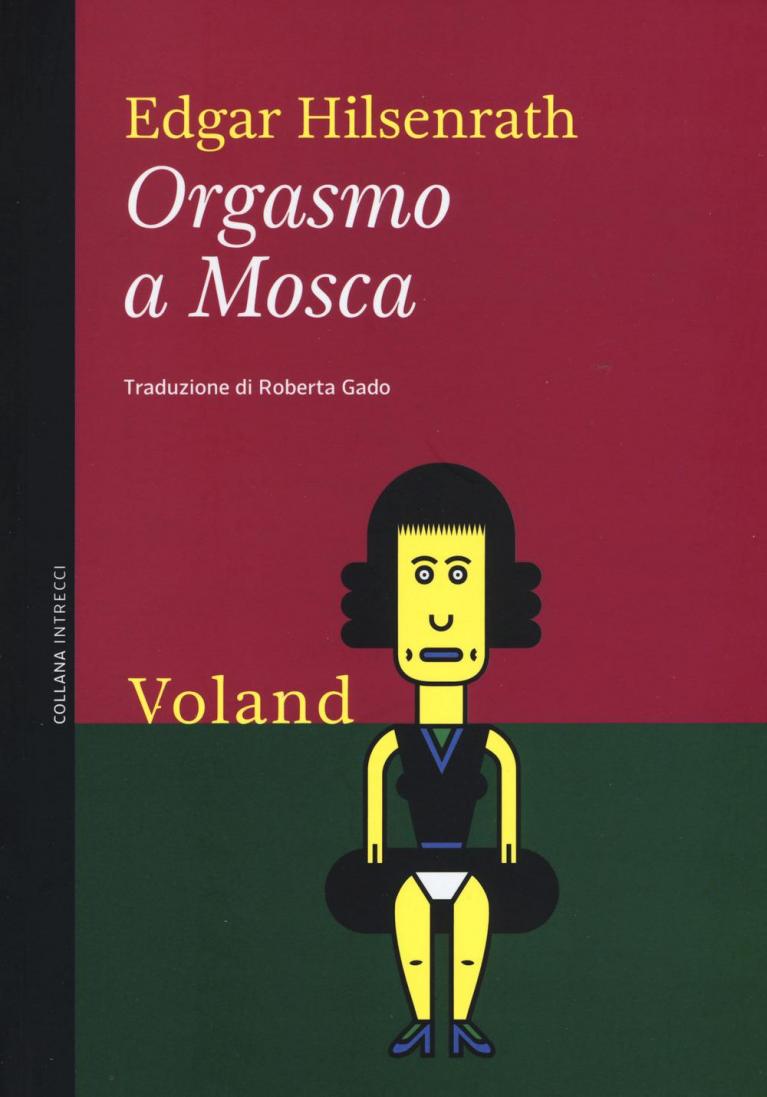
In quel romanzo la figlia di uno dei più potenti boss mafiosi imbastisce una fuga con l’unico uomo che le ha fatto avere un orgasmo in vita, peccato sia uno scienziato ebreo che non può oltrepassare i confini russi legalmente. L’intreccio, anche in quel caso, può fermarsi davanti alla reale narrabilità della storia. «La questione della narrabilità», infatti, è un elemento di peso sollevato anche nella sapiente postfazione di Paola Del Zoppo. È questo, a ben pensarci, il motivo per cui il testo ha fatto fatica prima di essere accolto da un editore. Di là di ogni appiglio retorico e di ogni forzato riferimento all’Olocausto, si ha la tangibile sensazione che la resa scenica del terrore sia percorribile anche attraverso il mezzo letterario, ma questa volta attraverso una narrazione orizzontale che mostra come gli ebrei subivano un doppio sfratto rispetto alla loro identità: la paura dei rastrellamenti nazisti e l’istinto di sopravvivenza che portava all’odio del vicino. Hilsenrath fa una scelta: racconta la banalità del male, non per lasciare un documento storico ai posteri, non per il solletico di un memoir letterario, bensì perché perdere la capacità di narrare – anche in maniera asettica, per carità – quello che si è visto e vissuto sarebbe un ulteriore smacco fascista ai danni di chi è sopravvissuto.
Notte è stato paragonato ad alcuni romanzi moloch del Novecento. Si è fatto il nome di Céline, ricordando il Voyage, ma si è tirato in mezzo anche l’eterno Furore di Steinbeck, o le storie di Maksim Gor'kij. È vero che questi romanzi abbiano diversi aspetti in comune tra di loro (a partire dalla densità e dal numero delle pagine). È indubbio anche che Blum, il medico, a un tratto ricordi molto il dottor Bardamu, protagonista di Viaggio al termine della notte, in preda al panico circondato da bisognosi, messi non meglio di lui. In Notte, però, è assente una verticalità della narrazione, un respiro ampio che dia luogo ad assiomi, a frasi indimenticabili che il lettore sottolinea con forza con la matita. Questo non c’è perché non è questo quello che Hilsenrath chiede a se stesso. Un romanzo del secondo Novecento che può essere affiancato a Notte è Cecità di Saramago, pubblicato molto più tardi, nel 1995. È curioso, ad esempio, come Feltrinelli all’epoca abbia avuto cura di non tradurre Ensaio sobre a Cegueira, come Saggio sulla cecità, per paura che i lettori fossero scoraggiati in partenza. Peccato che poi dopo qualche pagina ci si ritrovi in un ex manicomio nel quale sono costretti a sopravvivere tutti gli abitanti di una città colti da una inspiegabile e improvvisa cecità. La descrizione del male, anche in quel caso, era spesso gratuita. Si consumavano stupri efferati e si era costretti a fare il passo largo per non calpestare i cadaveri ad ogni pagina. Possiamo dire che raccontare la gratuità della sopraffazione tra gli uomini, anche lì, era esso stesso un metodo efficace per raccontare le vicende di un mondo di vivi che non aveva coscienza di essere un mondo di morti. Chissà se Lars Von Trier, ad esempio, ha letto Notte prima di mettere sullo schermo la scena in cui la protagonista di Nymphomaniac opera un aborto su se stessa con una stampella appendiabiti.
Alla fine della lettura sarà difficile dimenticare le acque del gelido Nistro, la cui corrente feroce e vorticosa travolge chiunque non si regga saldamente in piedi, così come non è semplice lasciare andare Ranek. Durante il corso della narrazione ci si chiede spesso quand’è che tocca a lui morire, e cosa chiederà in cambio chi trasporterà il suo corpo, se dieci sigarette o una manciata di miglio. Non di più.







