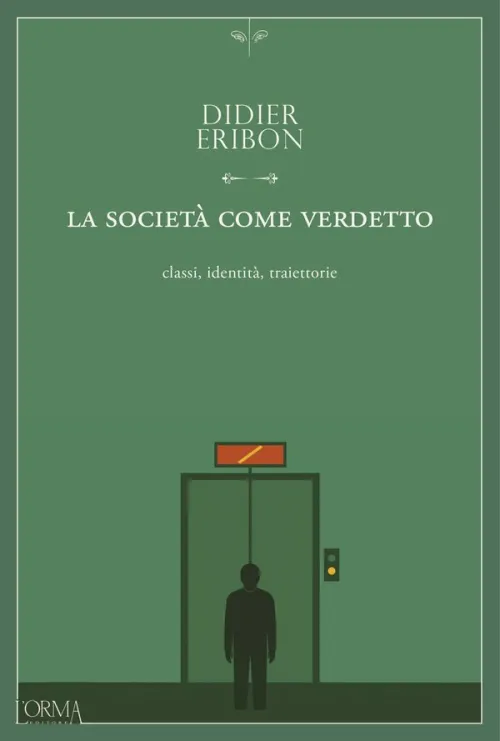Didier Eribon: la società è una trappola
C’è un dolore che io trovo tematizzato solo nei libri di Didier Eribon e di Annie Ernaux. Sono stati loro tra i primi autori a coglierlo, a esplicitarlo, a dare ad esso voce, parola e senso e, dunque, a renderlo visibile: è il dolore legato alla vergogna delle proprie origini.
Si tratta di un sentimento complesso, un nodo a tratti inestricabile, difficile da sviscerare ed esprimere attraverso la scrittura, loro però vi riescono egregiamente utilizzando due generi letterari differenti: la forma narrativa e quella saggistica, sebbene in fondo le opere di entrambi rappresentino un ibrido, una sorta di contaminazione letteraria.
Nelle prime pagine di La società come verdetto. Classi, identità, traiettorie, pubblicato da L’orma editore nell’attenta traduzione di Annalisa Romani, Didier Eribon fa riferimento a una foto strappata che si fa metafora e atto di un tentativo di cancellazione. A tal proposito l’autore racconta un episodio autobiografico: la casa editrice gli chiese una fotografia di famiglia da porre come immagine di copertina all’edizione tascabile del suo libro più celebre, Ritorno a Reims. Qui Eribon rivela la propria reticenza: «Non ne ho» risponde al principio in un inatteso rigurgito di vigliaccheria, salvo poi decidersi a cedere la foto – ma tagliando una figura fondamentale, quella del padre operaio. «Mosso da una strana e irreprensibile pulsione, sono stato portato a cancellare la sua immagine» scrive in una sorta di autoaccusa. Lo strappo della fotografia svela la ferita ancora aperta, sanguinante, il dolore mai lenito della vergogna che chiunque si sia distaccato dalle proprie origini familiari può comprendere. «Si può aver scritto un libro sulla vergogna e non essere mai riusciti a superarla» riflette l’autore dando avvio a un saggio che si propone e orienta da subito come «un’operazione di introspezione sociologica».
Negli anni Sessanta il sociologo Pierre Bourdieu, maestro e mentore di Eribon (oltre che figura cardine per comprendere l’opera di Ernaux), coniò la definizione di «transfuga di classe» per descrivere la condizione di chi si affranca dal proprio milieu d’appartenenza compiendo il salto sociale, solitamente da una provenienza proletaria a un ambiente borghese. Bourdieu ha tematizzato il concetto, ma sono stati Annie Ernaux e Didier Eribon a dare voce al dolore del processo di trasformazione e, soprattutto, a descrivere il distacco con il termine altisonante e rivelatorio di «tradimento». Nell’esergo di Il Posto, libro fondamentale di Ernaux dedicato al padre in cui è sancita la nascita della cosiddetta écriture plate, troviamo una citazione di Jean Genet particolarmente significativa: «Scrivere è l’ultima risorsa quando abbiamo tradito». In quelle pagine Ernaux afferma di «scrivere per rivendicare la propria razza» e conia un peculiare stile di scrittura che sia «al di sotto della letteratura» per mantenere vivo il legame con il proprio mondo di provenienza, in cui le parole sono percepite alla stregua di oggetti materiali, pietre e coltelli.
Lo stesso doppio movimento – la fuga e il ritorno – attraversa l’opera di Eribon che compie un percorso analogo a quello di Ernaux: alla presa di distanza radicale dall’origine segue un processo di riconciliazione con i luoghi di appartenenza. Pierre Bourdieu parla a tal proposito di «un’odissea della riappropriazione» ed Eribon in queste pagine sottolinea il suo legame con il maestro, definendolo il proprio «padre intellettuale».
L’analisi compiuta da Bourdieu è infatti stata determinante per l’autore poiché, nella prima gioventù, è ciò che gli ha permesso di prendere coscienza della violenza che l’ordine sociale esercita sugli individui. Cancellare l’immagine del padre per Eribon significa porre una distanza tra il mondo operaio di provenienza e il mondo intellettuale cui è giunto; ma è un tentativo fallace, poiché alla domanda «Cosa resta in me di mio padre?» per quanto lui desideri rispondere «Nulla» è costretto ad ammettere «Tutto». Deve infine riconoscere che il padre «vive ancora in me e mi ha costituito in modo molto più profondo di quanto volessi ammettere»; eccolo dunque esplicitato il dolore invisibile della vergogna e l’impossibilità di una vera riconciliazione.
Tanto in Eribon quanto in Ernaux, il trauma presenta la duplice connotazione di vergogna sociale e vergogna sessuale. Nel caso di Eribon non si tratta di parlare di violenza o forme di abuso, ma di sfidare un vero e proprio pregiudizio. «Essere una persona gay significa essere vulnerabile (…) significa essere una persona definita nell’intimo da una vulnerabilità quasi ontologica» riflette l’autore, facendo riferimento alla propria difficoltà a vivere la condizione di omosessuale in un contesto sociale in cui ciò era percepito come uno stigma. Il rifiuto della propria famiglia diventa, in quest’ottica, il principio necessario della costruzione individuale di sé e rappresenta la rottura utile a spezzare la catena dell’identica trasmissione dei ruoli. Ma non basta, poiché alla rottura (alla fuga) deve seguire il ritorno, che spesso è un processo lungo e doloroso e non sempre appare definito e compiuto.
Didier Eribon riesce a dare voce a una scissione peculiare, a un sentimento di differenza, esprimendo proprio la lacerazione: «Portiamo in noi un’identità sociale tramandata da diverse generazioni, ovunque andiamo, e ci viene ricordata e imposta dal modo in cui altri espongono la loro, la proclamano, “per dirvi chi siete attraverso chi non siete”».
Nonostante il proprio riscatto personale, intellettuale, di individuo, Eribon in La società come verdetto rivendica la propria appartenenza al mondo dei dominati: «La mia genealogia è quella degli oppressi». Quindi osserva come persino la scolarizzazione, ciò che più di ogni altra cosa gli ha consentito di emanciparsi, di fatto continui a perpetuare questa differenziazione accentuando le disuguaglianze economiche: le scuole private per i figli della borghesia. Il saggio La société comme verdict fu pubblicato in Francia nel 2013, ma il ragionamento sviluppato da Eribon è valido ancora oggi e appare attuale in maniera disarmante: l’istruzione non è democratica, soprattutto non lo è per quanto riguarda l’accesso alle professioni culturali. Le università statali non offrono le stesse opportunità di quelle private, inoltre vige una ulteriore soglia di sbarramento rappresentata da master e scuole di specializzazione che spesso hanno dei costi proibitivi per chi proviene da classi sociali meno abbienti. In poche parole, lavorare nel mondo della cultura è un privilegio di pochi e, ancor più di ieri, è una prerogativa strettamente borghese: di rado chi proviene da ambienti meno agiati diventa sociologo, riflette Eribon, mostrando come la violenza della classe sociale dominante operi anche in un ambito che, di fatto, dovrebbe essere democratico, come quello dell’educazione e dell’istruzione. In Italia poi questa prospettiva appare amplificata, poiché la continuità tra mondo universitario e professionale è pressoché assente e raramente viene premiato il merito (o riconosciuta la competenza) e ci sono persone cui l’ingresso in certi spazi “nobili” della cultura è rifiutato proprio in virtù della provenienza. Eribon medita su questo potere di perpetuazione dell’ordine sociale da parte della classe sociale dominante, notando come l’accesso all’insegnamento rappresenti l’orizzonte di realizzazione cui aspirano parecchi figli delle classi popolari, ma poi di fatto pochi davvero vi riescano a causa dei costi proibitivi delle varie specializzazioni richieste. Dunque non è vero che il successo dipende dal merito individuale, ma è vincolato in ogni caso alle condizioni di partenza. «È sempre facile» chiosa l’autore «per chi occupa una posizione dominante non vedere, o non voler vedere, gli effetti del dominio» e sottolinea come i nostri cognomi, le nostre ascendenze definiscano ciò che siamo in ogni istante, a dispetto di quello che facciamo e otteniamo. Eribon si fa beffe della cosiddetta «uguaglianza repubblicana», mostrandola come un ideale utopico: «Il gran tranello della borghesia è stato quello di convincere che valeva la pena tradire i padri operai per la borghesia e che la vita sarebbe stata appagata dalla cultura». Tra le righe emerge la denuncia di una società che tende a perpetuare inesorabilmente sé stessa.

Esiste un varco, una via d’uscita? Sia Eribon che Ernaux sono stati i primi della loro famiglia a frequentare l’università, quindi ad avere accesso a un livello privilegiato di istruzione affinando la scrittura, la letteratura, la cultura, intese come «le armi del nemico» che tuttavia sono le sole a disposizione del “transfuga di classe” per varcare la soglia dal mondo dei dominati a quello dei dominanti. La riuscita negli studi, in tal senso, diventa un primato, una responsabilità e, infine, una colpa perché implica il distacco e quindi il tradimento della cultura di appartenenza. I libri sono parte fondamentale del processo di cambiamento, di metamorfosi di sé, infine del transito da un mondo all’altro.
Un bellissimo elogio è dedicato al potere trasformativo della letteratura, che qui viene mostrata nella propria duplice accezione: seducente musa e strumento di rottura con la classe sociale d’origine. Per Eribon, proprio come accade a Ernaux, il legame con i libri si associa a un sentimento di totale devozione nei confronti dei loro autori. Entrambi concepiscono la letteratura come «dono a propria volta elargito» e in particolare Eribon fa riferimento alla propria pratica letteraria come a «un’etica e a una politica della generosità». La lettura viene presentata come un’esperienza di «rivelazione», una sorta di culto segreto: «Ho venerato Sartre, ho venerato Beauvoir. Mi hanno aiutato a liberarmi; mi hanno liberato». Da questo punto in avanti l’analisi prende un’altra piega e vengono menzionati due mostri sacri della letteratura francese: Simone de Beauvoir e Marcel Proust.
Eribon propone ai lettori una geniale sfida critica, mettendo in relazione il vissuto delle proprie nonne con quello di Beauvoir. Avevano la stessa età, sottolinea, erano nate nella stessa epoca, eppure in contesti culturali diversi – e questo ha fatto tutta la differenza. Le sue nonne, osserva beffardo, non avrebbero mai potuto scrivere Il secondo sesso, poiché le donne delle classi popolari erano in larga misura estranee alle istanze del femminismo, addirittura l’autore si chiede «se conoscessero la parola femminismo». Erano persone che non avevano neppure il tempo materiale per dedicarsi alla lettura perché metaforicamente «maltrattate dalle leggi di una condizione sociale e sessuale che le sovrastava e plasmava le loro esistenze». La riflessione dedicata a queste due donne di classe operaia – pur così diverse tra loro e, per certi versi, agli antipodi – è molto toccante, poiché viene mostrato come entrambe ignorassero l’esistenza di altre strade, altre vite: «Com’è stata la loro giovinezza? Cosa pensavano, di cosa parlavano, cosa sognavano?». E d’altronde, queste donne l’hanno poi avuta una giovinezza? Si interroga l’autore, prima di giungere a una conclusione simile a uno strappo: «La giovinezza come periodo della vita non è, in fondo, un privilegio borghese?» La frase squarcia la pagina.
Ciò consente a Didier Eribon di ribadire e rafforzare la propria tesi: l’identità è un prodotto sociale, spiega, facendo riferimento al tribunale invisibile di cui parla Kafka, in cui si avverano delle sentenze che ci hanno preceduto, che ci accerchiano e ci seguono senza alcuna ragione apparente. Ecco la spiegazione del titolo del saggio La società come verdetto.
Paradossalmente è proprio la distanza favorita dalla posizione di «transfuga di classe» che consente a Eribon questa peculiare lucidità di sguardo: può scavare nella ferita solo chi avverte ancora quella ferita aperta. Persino nella propria personale rilettura della Recherche di Marcel Proust l’autore non manca così di notare quella doppia oscenità che lo perseguita: sociale e sessuale. «È innegabile che ci siano pochi libri scritti dal punto di vista dei domestici» osserva, facendo riferimento a Françoise, la domestica cui Proust dedica tanto spazio, eppure «non conosciamo il suo cognome»: a differenza di Oriane De Guermantes, Françoise è solo Françoise ed è mostrata come invadente, curiosa, spesso inopportuna. E che dire di Morel? L’ascesa sociale del violinista è vincolata alla relazione con il barone de Charlus e il giovane supplica il narratore di non rivelare le proprie origini «che suo padre era un valletto di camera». Nella figura di Morel si intrecciano quindi due forme di vergogna che, infine, sfociano in una vera e propria paura: teme al contempo l’outing sociale e l’outing sessuale. Eribon, a differenza di Paul Nizan che pure cita, non mette in discussione Proust per la sua rappresentazione letteraria puramente borghese, ma ne salva il genio, perché riconosce la capacità dell’autore della Recherche di abitare la contraddizione.
Ma il vertice emotivo del saggio La società come verdetto è racchiuso nello scontro generazionale: è commovente la pagina in cui Eribon riflette sulla figura del padre, che era stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava perché accusato di istigazione allo sciopero. In seguito l’uomo diventa più prudente e rinuncia alle lotte sindacali, perché ha bisogno di soldi per mantenere la propria famiglia e consentire al figlio di proseguire gli studi – lo stesso figlio che poi lo accusa, puntando il dito contro la sua vigliaccheria. «E capisco quanto possa essere stato esasperato dal mio gauchismo rivoluzionario nel periodo in cui, tra i sedici e i diciassette anni, pontificavo sullo sciopero generale insurrezionale» riflette l’autore. La consapevolezza del tradimento riecheggia, come un grido sommerso, in ogni riga e trova sfogo nella dirompente citazione di Nizan: «Avete cercato invano di farmi credere nella coincidenza tra il borghese e l’umano».
Didier Eribon, a differenza di Nizan, però è in grado di andare oltre la scissione che lo abita interiormente e ad affermare, tramite il suo saggio, che è necessario rivendicare un altro modo di “essere umani” e lo si può fare, anche, attraverso la letteratura.
Se è vero che la società è un verdetto, è però altrettanto vero che sono i singoli individui a comporla e, al di là dell’opposizione strutturante tra “noi” e “loro”, è possibile proporre una nuova percezione che sfugga alle sbarre stringenti di una gabbia asfittica. Le narrazioni dei transfughi di classe stanno proponendo proprio questa rivoluzione: l’atto linguistico conferisce esistenza e dà nome a sentimenti, come la vergogna, che prima non potevano essere nominati. La parola permette di ricucire lo strappo. Un autore come Didier Eribon, alla stregua di Annie Ernaux con la sua écriture plate, è in grado di farsi portavoce di un mondo sommerso la cui memoria è rimasta esclusa, per lungo tempo, dall’ambito letterario. La scrittura diventa strumento di riscatto; e non è mai neutra. Se non si può curare il dolore del tradimento, si può almeno lenirlo. Alla fine della lettura de La società come verdetto io la foto strappata la rivedo intera – e la figura bistrattata di quel padre operaio ha finalmente ritrovato la sua luce e il suo senso.
Leggi anche:
Paolo Landi | Didier Eribon: chi parla per gli anziani?