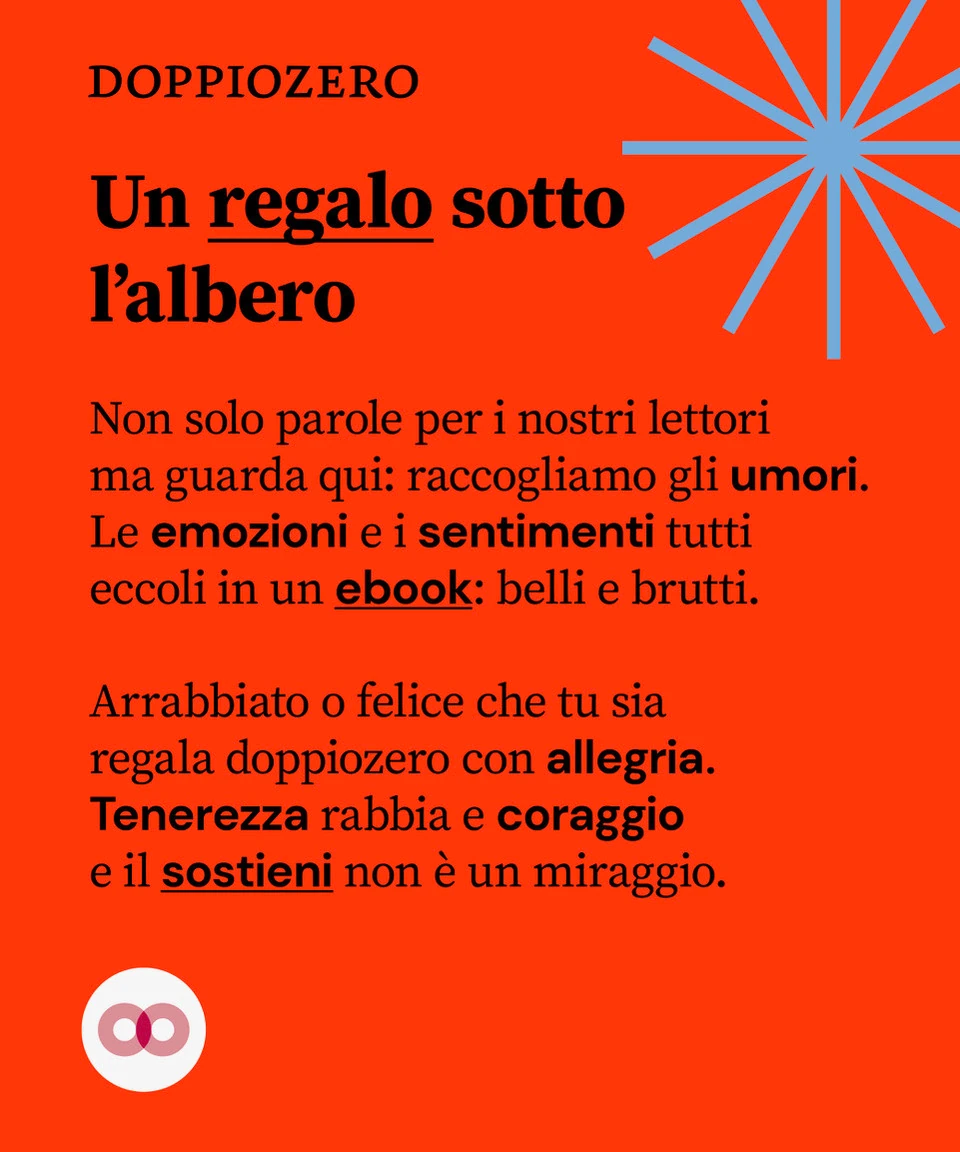Letizia Battaglia / Let (it) B
Non è facile scrivere su Letizia Battaglia. Sul suo modo di fotografare, su quello che ha ritratto e sui risultati che ha ottenuto. Specialmente dopo aver visto la mostra dal titolo Anthologia (fino all’8 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo) che raccoglie 140 fra le sue fotografie migliori. Bisognerebbe essere oggettivi, entrare nel merito del livello estetico dei suoi scatti, della composizione, dell’uso sapiente del bianco e nero, ma anche del loro valore politico e sociale: finestre su un’umanità spesso inquietante e terribile in cui magicamente l’occhio del fotografo riesce a scoprire lampi di bellezza e di verità. Ci sono gli anni terribili delle guerre di mafia a Palermo, quelli di Falcone e Borsellino, che Letizia immortala lavorando come reporter per il quotidiano L’Ora, e c’è la città, con i suoi eterni, stridenti contrasti, ma soprattutto ci sono le persone, le donne in particolare, come si è potuto vedere in un'altra sua mostra, Qualcosa di mio, a cura di Laura Barreca e Alberto Stabile, conclusasi qualche settimana fa al Museo Civico di Castelbuono e centrata appunto su figure femminili colte nei loro scenari quotidiani (un consiglio, se dovesse capitarvi di imbattervi nel lavoro di Letizia Battaglia, soffermatevi sulle scene della quotidianità: è lì che si vede tutta la sua grandezza).
Bisognerebbe farlo, ma significherebbe costringere il suo lavoro dentro una griglia di lettura che, per quanto ampia e rispettosa, finirebbe per essere comunque riduttiva. L’alternativa – la più seria ed efficace – sarebbe lasciar parlare le immagini, magari proprio quelle di questa mostra che meriterebbe di girare il mondo. La possibile terza via l’ha indicata a suo tempo Umberto Eco, che nelle sue postille alla prima edizione del Nome della rosa, scriveva che di tutto ciò che non si può teorizzare bisognerebbe narrare.
Era il 21 dicembre 1986 e a Palermo faceva freddo. All’appuntamento si presentarono puntuali tutti gli allievi del Laboratorio d’IF (Informazione Fotografica), un centro voluto da Letizia Battaglia in cui oltre a fare fotografie e stamparle (già, la stampa analogica, ci torneremo), si poteva vederne e parlarne.
C’era gente di tutti i tipi, ma soprattutto di tutte le età. Non solo giovani desiderosi di apprendere da una grande fotografa a tenere la macchina in mano, ma anche persone più avanti negli anni, che di apparecchi fotografici ne avevano in mano da tempo, e magari di buona qualità anche. Ecco un’altra cosa: non si parlava quasi mai della qualità della macchina fotografica, dell’importanza dell’attrezzatura. Né in aula, quando si facevano delle lezioni teoriche, né quando si andava in giro a fotografare. Si potrebbe pensare agli appassionati di fotografia come agli appassionati di motori, che non fanno altro che parlare dell’ultimo modello, dell’efficacia di questa o quest’altra soluzione. Con Letizia questo non succedeva quasi mai. Unico requisito fondamentale, portare con sé tante pellicole. Si può risparmiare su tutto, diceva sempre, ma non sulle pellicole. Il luogo dell’appuntamento era piuttosto variabile, in qualche caso era il centro di Palermo, in qualche altro un quartiere periferico più o meno disastrato.
Quel 21 dicembre si era molto vicini al fiume Oreto, già allora ridotto a poco più di un torrente che scorreva in un letto troppo ampio, testimonianza di un passato glorioso. L’idea era proprio quella di muoversi verso quelle sponde per vedere cosa ci fosse. Già, perché nessuno dei presenti ne aveva la minima idea, né sapevamo se poi qualcosa l’avremmo trovata davvero. Ecco, era questo che si faceva in quegli incontri, si esplorava. La sensazione era piuttosto strana, e sospetto che non fosse poi troppo dissimile da quella che provano gli esploratori veri, quelli che vanno nelle foreste o cose del genere. In un caso come nell’altro andavamo verso l’ignoto, solo che nel nostro caso l’ignoto era a pochi metri da casa. Un ignoto vero intendo, non solo non sai cosa troverai, non sai se troverai qualcosa, ma soprattutto non hai idea di cosa potrà capitarti, né quanto pericoloso potrà essere. Parlo di un pericolo fisico, non di essere sgridati. Spesso si finiva in zone piuttosto problematiche, popolate da gente che a guardarla non avresti detto di potergli puntare impunemente un obiettivo in faccia. E qui entrava in scena Letizia.
Immaginate un esercito di una ventina di fotografi assatanati di scatti che invade un mondo parallelo che non hai mai sospettato di poter vedere a 20 minuti da casa. Non soltanto Letizia ci portava lì, ma doveva fare qualche tipo di magia perché dopo pochi minuti la gente chiedeva di essere fotografata. E non perché avesse riconosciuto la prima fotografa europea a ricevere il prestigioso premio W. Eugene Smith, figurarsi, ma perché Letizia Battaglia gli parlava. È lì che ho capito che la storia per cui il fotografo non c’è mai nelle fotografie che scatta è una stupidaggine. È vero l’esatto contrario, e nel caso di Letizia ancora di più. È il fotografo che crea le condizioni umane perché una fotografia prenda forma.
Il fatto è che un fotografo non è semplicemente un uomo. È una creatura strana, un ibrido. La sua umanità è alterata da un’apparecchiatura che non soltanto ne muta le capacità – poter conservare la memoria di 1/125 di secondo – ma anche il modo in cui si pone nei confronti di ciò che gli sta intorno. Tutte le volte che a Eco si chiedeva di parlare di fotografia, lui rispondeva sempre che l’unica macchina fotografica che aveva posseduto l’aveva data via dopo averla usata una sola volta. Aveva dovuto farlo quando, ritornato dal viaggio in cui l’aveva portata, aveva scoperto di non ricordare nulla. E per uno che aveva una memoria come la sua doveva essere un trauma non da poco. Più fotografava più dimenticava. C’è poco da fare, la macchina fotografica ci cambia. Per qualcuno le sensazioni che dà possono essere spiacevoli, per altri, invece, tramutarsi in un occhio che guarda il mondo può essere esaltante.
L’unica cosa che non può succedere è che non cambi nulla. Il punto che Letizia Battaglia coglieva perfettamente è che questa trasformazione ha delle conseguenze anche su ciò che sta intorno al fotografo, agli oggetti della sua attenzione, specialmente quando sono altri esseri umani. Perché nasca una fotografia bisogna che il fotografo si presenti in quanto tale. Come diavolo facesse a farlo non ne ho idea, ma la situazione cambiava davanti agli occhi dei suoi allievi. Nello spazio di pochi minuti si passava da un’ostilità rabbiosa a un’apertura totale, alla voglia di farsi ritrarre. E non erano le parole a convincere, le promesse di chissaché, ma le fotografie. Le persone fotografate erano di colpo tutte interessanti, tutte belle davanti all’obiettivo di Letizia. A questo proposito, una puntualizzazione: non è vero che l’obiettivo diventa l’occhio del fotografo, funziona al contrario, l’occhio del fotografo diventa un obiettivo. Un fotografo vero vede immagini, l’obiettivo è solo quell’affare che gli ha insegnato a farlo e per il tramite del quale altri potranno vedere ciò che il fotografo vede.
Come stavo dicendo, stavamo andando verso l’ignoto e nessuno immaginava quello che avremmo potuto trovare. Il paesaggio che dopo qualche vicolo ci si presentò davanti era surreale. Sulle rive del fiume c’erano delle case abitate, e in queste case c’erano degli uomini e delle donne, molti uomini e donne che vivevano spesso in spazi piccolissimi. E bambini, tanti bambini. Alcuni vestiti, altri in mutande, alcuni vivaci come ci si aspetterebbe da un bambino, altri già vecchi che si prendevano cura dei più piccoli. Tutti con uno sguardo negli occhi che riuscivi a sostenere solo se lo guardavi attraverso un obiettivo. Il fotografo-ibrido non vede solo cose diverse, ha una sensibilità diversa. Trasformata forse dal valore testimoniale che la fotografia che scatterà, indipendentemente dalla sua qualità, possiede. E poi c’erano gli animali. Maiali per la maggior parte che, come in epoche molto più remote, condividevano con le persone gli spazi della casa. Ma soprattutto c’era la spazzatura. Montagne di spazzatura sulle quali alcune di quelle case erano edificate. Il punto non era documentare tutto questo, mostrare il degrado, la miseria, la disperazione che si respiravano, denunciare quello che la gente non vuol vedere. Il punto, come le fotografie di Letizia Battaglia chiariscono perfettamente, era trovarci la bellezza. Trovare l’umanità in situazioni che di umano avevano davvero ben poco. E celebrarla attraverso la fotografia.
Si sa, Letizia Battaglia usa il grandangolo, è quella la sua cifra estetica. Il 35mm o addirittura il 28 mm. Obiettivi da paesaggio, ampi, che consentono di includere nell’immagine molti elementi, offrendo una visione innaturalmente ampia (il “normale”, quello che riproduce la visione dell’occhio umano è il 50mm, focali inferiori significano angoli di campo più ampi, focali superiori – quelli che una volta si chiamavano teleobiettivi – un maggiore ingrandimento). Il problema è che con quegli obiettivi lì Letizia realizzava dei ritratti. Normalmente un ritrattista lavora con un 55mm, o addirittura con un 85. Vuole che l’obiettivo si avvicini al soggetto per lui, che entri (l’obiettivo) nella sua intimità. Non Letizia. Per lei entrare nella sfera intima del soggetto significava farlo davvero, essere vicino a lui, sentire il suo odore, il suo respiro. Molti anni più tardi dell’esperienza vissuta con lei, ho visto quel film di Luc Besson, Léon.
È la storia di un assassino che prende con sé una bambina a cui hanno ucciso i genitori e finisce per insegnarle come si diventa dei veri professionisti. Vedi – le dice – il fucile è un’arma per principianti. Ti impone di star lontano dal bersaglio. Il professionista vero lavora con il coltello, un’arma che ti obbliga ad avvicinarti e che richiede dunque un perfetto controllo della situazione. Con la fotografia succede qualcosa di simile. È vero che fare ritratti con il 28mm significa comporre in modo particolare l’inquadratura, poter realizzare prospettive interessanti, introdurre distorsioni particolari, ma soprattutto significa avere davvero il controllo sulla situazione. Perché il problema per Letizia Battaglia è stato sempre raccontare storie. Sono quelle che ha sempre cercato in ogni immagine, e il grandangolo le dava la possibilità di raccontarne tante in un solo scatto, ognuno dei quali diventava così un’epica.
L’ultima storia che voglio raccontare riguarda ciò che veniva dopo lo scatto. Già perché a quel tempo le fotografia andavano stampate. Niente digitale, niente istantaneità, niente computer. Al loro posto reagenti, lunghe attese, molteplici passaggi, mani che si bagnano, camere buie e cose del genere. Ma soprattutto l’ingranditore, ovvero quell’apparecchio tramite il quale il negativo veniva proiettato sulla carta fotografica per ottenerne un positivo. Ora, l’ingranditore a ben pensare è un’altra macchina fotografica, solo che funziona al contrario. Per alcuni stampare poteva essere un processo meccanico, da portare avanti secondo l’idea positivista del “miglior risultato possibile”.
Letizia Battaglia lavorava in camera oscura come faceva dietro l’obiettivo. Stampare era fotografare nuovamente, dar vita a un nuovo processo creativo in cui l’immagine prendeva vita. Agire ancora sull’esposizione e interagire con i reagenti di sviluppo significava decidere la nerezza del nero, la bianchezza del bianco, il modo in cui le infinite sfumature di questi due non-colori primari avrebbero dovuto combinarsi insieme. Le forme c’erano tutte ma i colori bisognava inventarli, e il bianco e nero in questo offre possibilità enormi. Insisto: non si trattava di “ritoccare” le immagini come si fa adesso e come, soprattutto, siamo abituati a pensare, ma metterle nella condizione di esprimersi, modulando i chiaroscuri, sottolineando i punti notevoli, mascherando possibili fonti di distrazione (senza mai eliminarle del tutto come si fa oggi con Photoshop). Dando luce al negativo si illuminava di nuovo la scena, e così la verità del reportage si coniugava con la raffinatezza formale dello studio. Ecco, forse è questo che alla fine emerge dall’opera di Letizia Battaglia. L’idea di una fotografia che non ha paura del suo artificio, del soggetto che si mette in posa, che non cerca l’attimo rubato più o meno casualmente ma si dispone affinché l’istante fecondo abbia luogo. Con la consapevolezza che la verità di una immagine, la sua capacità di scuoterci ed emozionarci, non viene dalla presunta innocenza di chi la scatta così come del soggetto ritratto, ma dalla profonda umanità che solo un vero professionista sa esprimere. Lasciare che tutto sia come è per svelare l’evidenza del suo mistero.