Architettura: cosa resta del progetto?
Stiamo vivendo un tempo confuso, segnato da un disorientamento collettivo che chiama paura, aggressività, chiusura verso qualsiasi entità che sia differente e porti complessità.
Il tempo digitale in cui siamo immersi ci porta le emozioni con la forma del sale sulla carne viva, rapide, immediate, lancinanti nel dolore che porta a risposte che non chiedono pensiero sofisticato ma solo azioni semplici e immediate. Ogni messaggio, ogni immagine, quasi tutte le azioni della grande politica sembrano costruite per ridurre la complessità del mondo ai minimi livelli, dimostrando un fastidio evidente per le stratificazioni e le identità anomale che, invece, ci chiedono di avere un pensiero critico personale e attento. Esiste un bianco o un nero, un uno o uno zero, un amico o un nemico, con il capitale o sulle barricate, la crisi ambientale o il liberi tutti per trivellare ovunque, così da fare sembrare lontanissimo un passato, che invece è appena prossimo, in cui le riflessioni su un presente fragile, eterogeneo, sempre più complesso sembravano aprire squarci su strumenti e pensieri diversi e innovativi. Anche le discussioni sulla conclusione di una lunga modernità occidentale, ormai al compimento, aprivano scenari di senso su cosa saremmo stati nei prossimi decenni e su come affrontare questa lunga fase di transizione con strumenti critici e progettuali differenti rispetto a quelli dei secoli di ferro, vetro e cemento.
Invece sembra di essere tornati magicamente a un tempo pre-moderno fatto di chiusure e muri alzati, di finti archi di trionfo e finti palazzi neoclassici con marmi e stucchi dorati che rivestono modernissime strutture di acciaio e cemento armato, di strade e piazze privatizzate in maniera invisibile, di luoghi pensati solamente per ottimizzare il consumo di beni ed esperienze pronte ad essere postate in rete.
Seguendo questa breve premessa verrebbe da domandarsi che cosa c’entra tutto questo con l’architettura e il dibattito sul progetto contemporaneo, ma non dobbiamo dimenticare che ogni spazio che abitiamo e oggetto che utilizziamo è stato commissionato, immaginato, disegnato e prodotto a ricordarci che, come recitò negli anni Settanta l’architetto austriaco Hans Hollein, “tutto è architettura”.
Non esiste artefatto prodotto dall’uomo che non abbia subito una qualsivoglia forma di progettazione e quindi ogni atto progettante porta con sé una responsabilità politica ed etica enorme perché attraversa e condiziona ogni momento della nostra esistenza. Forse è per questa motivazione che guardare al mondo attuale e alla sua profonda metamorfosi ci porta inevitabilmente a interrogarci sul ruolo del progetto e sulla sua necessità.
Bisogna ammettere che l’architettura contemporanea non sta versando in buona salute, forse perché figlia di un tempo disorientato e attraversato da forme di violenza e disparità socio-economica drammatica, risultato della crescita tumultuosa di un iper-capitalismo tecnocratico e monopolista sempre più aggressivo, insofferente a pensieri culturali sottili e complessi e ossessionato da un’idea di presente eterno in cui l’idea di storia e quella di futuro non sono contemplati. L’architettura è sempre il prodotto di chi la paga, la progetta, la costruisce e la abita, ma soprattutto nei primi due elementi, ovvero la committenza e l’architetto, si riscontra una centralità decisiva riguardo al risultato finale. Quindi, se guardiamo ai prodotti dell’architettura più recente ci muoviamo tra il gigantismo di opere pensate per stupire e attirare l’attenzione in un tempo di competizione crescente tra le metropoli globali e una scala molto più contenuta di edifici rigenerati per nuove funzioni pubbliche, piccole-medie abitazioni distribuite in un paesaggio sempre più diffusamente urbanizzato oppure edifici per l’educazione, lo sport e la salute necessari a rispondere a un bisogno diffuso di micro-qualità ambientale.
Dimentichiamoci i dibattiti sul linguaggio e lo stile dominante, perché quello che una volta identificavamo come razionalismo, post-modernismo, minimalismo, decostruttivismo o vernacolare adesso sono impastati in continue varianti e montaggi che hanno generato una marmellata di eclettismo diffuso in cui ogni linguaggio sembra valere l’altro, cambiando a seconda dell’architetto, della scuola di provenienza o del luogo.
Il linguaggio dell’architettura e la permanenza di uno stile erano legati a una specifica cultura visiva e simbolica in un cui una società s’identificava lungo un tempo sufficiente perché si consolidasse ed evolvesse, ma oggi, in un tempo d’esplosione di un individualismo desiderante, moltiplicato per il numero degli abitanti del pianeta, sembra difficile immaginare una forma estetica comune e condivisa in cui rispecchiarsi. Il risultato sono metropoli popolate da architetture solitarie, individuali e incapaci di costruire città, se non come somma d’individualità in competizione tra di loro.
Probabilmente stanno mancando gli strumenti critici e le riflessioni capaci di interrogarci su questa fase informe dell’architettura contemporanea e sul ruolo dei progettisti, ma due pubblicazioni uscite recentemente, Quel che resta dell’architettura. Un progetto storico di Marco Biraghi (Einaudi ed., 2025) e Clandestine parallele. La cultura del progetto a fine Novecento di Cristina Bianchetti (Donzelli ed., 2025) hanno avuto il coraggio di prendersi, da punti di vista diversi e complementari, questa responsabilità e di porci domande e provocazioni di senso necessarie in questa fase storica.
Entrambi gli autori insegnano alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e appartengono a quel ristretto gruppo di studiosi attenti, scrupolosi e culturalmente densi che nulla hanno a che fare con quella fascia di agit-prop da tastiera che rumoreggiano sui social intorno all’architettura e i suoi protagonisti. Entrambi gli autori appoggiano gli scritti e le riflessioni critiche su un percorso di ricerche storico-critiche che guardano soprattutto all’architettura e al progetto nel ‘900, nel caso di Biraghi, e al progetto della città e dell’urbanistica moderna per quanto riguarda Cristina Bianchetti.
Ma quello che rende interessante la compresenza di questi due titoli è che entrambi s’interrogano sulle ragioni profonde della crisi del progetto e della figura dell’architetto, utilizzando la prospettiva storiografica come strumento necessario per leggere la scricchiolante condizione della disciplina del progetto contemporaneo e la sua incapacità di avere un peso politico e simbolico effettivo nel nostro presente.
Avere il coraggio di guardare negli occhi della Medusa è forse l’unico modo che abbiamo di leggere la metamorfosi della cultura del progetto moderno alla fine di una parabola che è durata almeno due secoli e che oggi vive una crisi profonda che va affrontata senza nostalgia e con punti di vista spiazzanti per individuare strade nuove.
Su questo fronte i due volumi prendono direzioni differenti, perché mentre il lavoro di Biraghi prende posizione chiara, direi univoca, sulle parole chiave e le prospettive che la cultura architettonica dovrebbe affermare, la scrittura della Bianchetti ci porta volontariamente all’interno di un labirinto stratificato e problematico di storie italiane, scelte mancate o tradite, progetti che raccontano della continua, fragile, temporaneità dei risultati ottenuti e della necessità di rileggerli, forse per cambiare strada. Entrambi i volumi sono quasi ossessionati dal confronto con le parole e le opere dei due padri-padroni della cultura del progetto italiano contemporaneo come Vittorio Gregotti (Biraghi) e Bernardo Secchi (Bianchetti), uno per l’architettura e l’altro per l’urbanistica, amici e sodali intellettuali sulle pagine di Casabella per due decenni, forse perché il peso dei loro scritti e opere degli ultimi trent’anni ha ancora un’influenza rilevante all’interno dell’accademia italiana o forse per la necessità inconscia di affrontarli definitivamente, per poi abbandonarli.
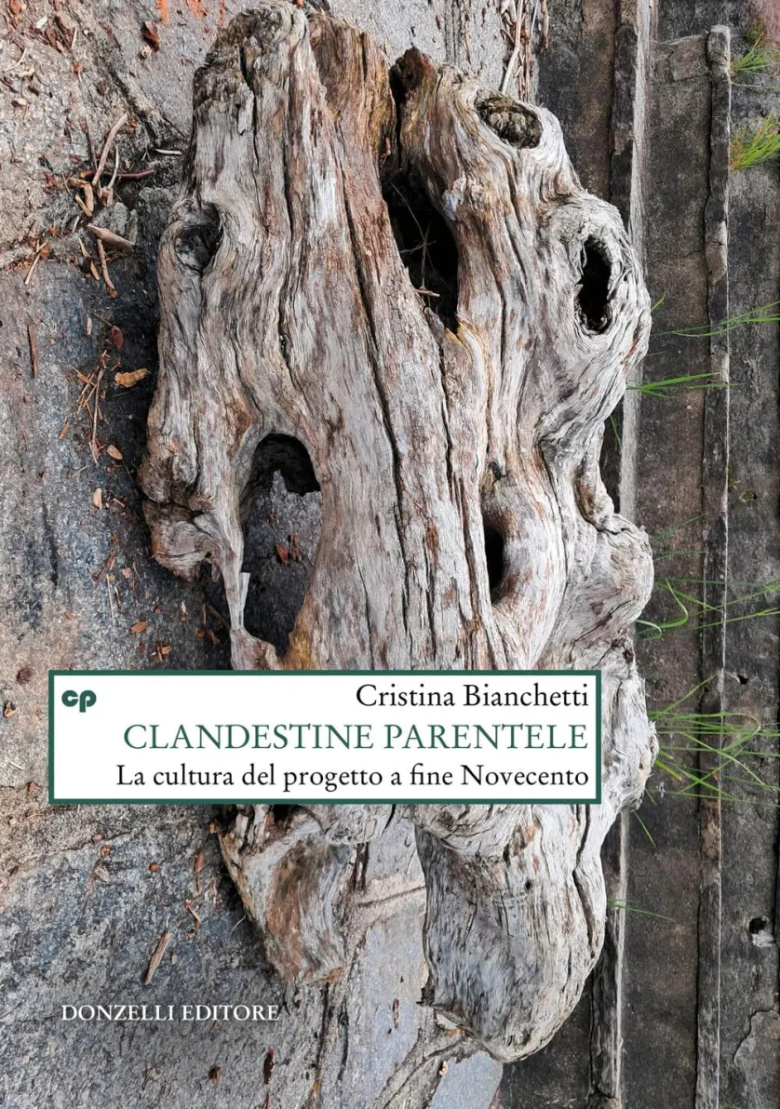
Ma il peso del confronto con le loro parole appare significativo, solo in parte nel volume di Cristina Bianchetti per la sua capacità di aprire scenari paralleli e contrastanti che aiutano la comprensione di un contesto culturale e politico contraddittorio e vitale, mentre nel caso di Marco Biraghi il corpo a corpo con le parole dell’architetto novarese accompagna tutto il volume, a definire un’esclusività intellettuale che appiattisce una disciplina che nella seconda metà del ‘900 italiano ha prodotto opere e pensieri molto più trasversali, vitali e contraddittori tra di loro. Non può bastare la lunga e corposa produzione scritta di Gregotti, che nell’ultimo decennio della propria azione aveva raggiunto livelli quasi forsennati di produzione di volumi, a giustificare l’attenzione minuta e attenta di Biraghi, trasformando questo scritto quasi in un dialogo tra due autori e generazioni differenti.
Il volume Quel che resta dell’architettura, in un tempo in cui viene da interrogarsi su quel che resta del progetto della modernità nel nostro presente, si presenta come una riflessione critica che mette sotto accusa l’incapacità dell’architetto contemporaneo di affermare con forza un progetto politico e culturale su un presente sempre più asservito all’iper-capitalismo e sull’annullamento di ogni forma di pensiero critico e visionario che ne contrasti il dominio pervasivo. È interessante notare come sia Biraghi che la Bianchetti prendano spunto dal libro di Peter Burger sulla Teoria dell’avanguardia, che tanto peso ha avuto nel percorso teorico di Gregotti e del Gruppo 63 a cui apparteneva, per riflettere sulla condizione irrisolta tra il progetto visto come innovazione formale ininterrotta e conflittuale con il reale e una condizione pervasiva di crisi che il progetto non ha avuto la forza di metabolizzare e trasformare in strumento di cambiamento del mondo. Sullo sfondo emerge un'altra parola ingombrante come l’esercizio del pensiero utopico, rimasto sempre su carta o assorbito dai cambiamenti politici, senza che avesse la capacità di traghettarci in un'altra condizione. Sotto questo punto di vista il libro di Biraghi è impietoso perché ci pone di fronte a una condizione diffusa in cui l’architettura ha mancato la sua capacità di esercitare un pensiero critico, resistente e attivo per essersi completamente asservita al mercato e alla sue regole spietate in cui la ristrettezza di tempo e di risorse, la fragilità crescente del soggetto pubblico e un tecnicismo che abbatte ogni differenza, hanno ridotto enormemente la capacità d’azione critica e conflittuale dell’architetto nel presente “rassegnato” a una condizione di sudditanza e passività che sta consumando la forza simbolica della disciplina e la qualità delle opere prodotte.
A questa condizione Biraghi oppone una scelta a dir poco radicale, ovvero la scelta del progettista anche di decidere di “non fare” invece di accettare supinamente le regole del mercato, dimostrando un’autorevolezza forte e una chiara e inflessibile posizione intellettuale che gli permettano di abbattere la propria vanitas, donandosi liberamente al progetto e alla sua missione.
La figura dell’architetto che l’autore milanese preconizza è quasi monacale e sembra non considerare la vasta gamma di complessità che l’attuale condizione del professionismo contemporaneo sta vivendo, mentre i due esempi del progetto per Monte Carasso di Luigi Snozzi o del collettivo Rural Studio negli Stati Uniti prefigurano realtà idealizzate che è impossibile immaginare su scale metropolitane più complesse e dense per problematiche e trasversalità sociale. Biraghi nella parte centrale del libro insiste molto sulla necessità dell’architetto di ricostruire una propria centralità e autorevolezza intellettuale per definire una chiara contrapposizione con il mercato e le sue regole, suggerendo, giustamente, di concentrare le proprie energie progettuali e di sperimentazione su pochi, chiari, elementi che possano diventare temi universali, facilmente riconoscibili da tutti, sorta di nuovi miti contemporanei che il progetto deve evocare e affrontare, offrendo soluzioni ambiziose, prossime a forme di utopie concrete e contemporanee. Per questa ragione l’autore si confronta con la dimensione del mito, oltre a scomodare addirittura un termine scivoloso come la “verità”, per affermare il bisogno dell’architettura di ristabilire radici nuove e forti con il luogo in cui s’insedia, acquisendo così un ruolo sociale e politico riconoscibile in una società sempre più fluida e instabile.
Biraghi insiste sulla necessità di individuare forme resistenti, quasi archetipi assoluti capaci di costruire famiglie di forme e progetti che dal tipo originale possano legarsi al luogo e costruire utili variazioni sul tema, riprendendo il dibattito sul ruolo della tipologia in architettura che ha segnato gli ultimi decenni del secolo passato da Aldo Rossi, passando per Vittorio Gregotti e Carlos Martì Aris. L’architettura si radica quanto più riesce ad attivare relazioni con i luoghi e le geografie che si sono stratificate nel tempo e questo dovrebbe essere il suo fine ultimo diventando elemento resistente, quasi coriaceo, in un mondo che tutto uniforma e semplifica. Gli esempi e le storie portate a buon esempio da Biraghi si situano intorno a una forma di modernismo sofisticato, essenziale in cui la matrice modernista afferma la propria autonomia figurativa e volumetrica come se fossero cristalli resistenti al flusso della Storia. Quello che sorprende è l’assenza di un pensiero sul progetto contemporaneo che non prenda in considerazione la relazione con i corpi dei viventi, la loro dimensione sensoriale e il bisogno di costruire domesticità dove oggi esiste solo una città di edifici solitari. Insieme a questo manca completamente una necessaria riflessione sul fatto che il progetto contemporaneo debba sempre più farsi progetto di paesaggio ridefinendo il proprio statuto di corpo autonomo e artificiale in un ecosistema più complesso e problematico che deve nutrire la forma del progetto offrendo, magari, quella dimensione di utopia sperimentale che sembra sempre più assente. Oltre a questo colpisce che la riflessione critica sul senso del progetto si cristallizzi ancora sulla forma del corpo architettonico non considerando la pervasività delle strategie e pratiche progettuali che ormai attraversano e influenzano parti molto più vaste del nostro vissuto quotidiano. Forse più che di parlare di progetto di resistenza dovremmo affrontare il progetto per l’esistenza di paesaggi di umani e viventi sempre più fragili e legati tra di loro dove il progetto e il progettista devono imparare a ridefinire il proprio ruolo e assoluta necessità liberandosi di quel mito di un’autonomia, formale e intellettuale, che ha solamente chiuso la categoria degli architetti o nella bolla necessaria del professionismo o in quella di un’accademia sempre più avulsa da un mondo che sta mutando rapidamente.
La generosità romantica, moralista e politica dei volumi di Biraghi e Bianchetti è necessaria perché ci impone di riflettere, studiare e cambiare registro per cercare la vita e le risposte necessarie oltre a quello che resta dell’architettura figlia del ‘900 che attende scelte e posizioni sicuramente più radicali e coraggiose.







