Piazzare
“Papà vado a piazzare con i miei amici”. Questa è la frase che da un paio di anni sento dire con regolarità dal figlio adolescente e che mi produce sempre un effetto di curiosità. Non ho idea se questo termine sia squisitamente milanese o nazionale tra le GenZ, ma sicuramente non c’entra nulla con il “piazzare una fregatura”, “spiazzare” un contendente o fare una “piazzata” rumorosa come se fossimo in una scena delle “baruffe chiozzotte” di Goldoni. La piazza, una delle parole più classiche e abituali nel nostro modo di conoscere la città è diventata un’azione, un verbo che mette insieme persone diverse, spostando il senso da una condizione permanente, minerale a una tensione quasi dinamica.
“Piazzare”, ovvero essere piazza, occuparla e trasformarla in un luogo da abitare insieme così come è sempre stato nella storia millenaria delle nostre città, dove la piazza è lo spazio deputato alla vita comune, recinto capace di accogliere corpi e voci diverse, luogo di libertà e d’azione di generazioni differenti. Non sto solo pensando alla piazza principale, quella centrale dei riti ordinari e consacrati in cui una comunità si ritrova, ma soprattutto a quelle centinaia di luoghi più generici, quotidiani, silenziosi che ti accolgono grazie alla loro flessibilità non impositiva, permettendo ad anime e lingue diverse di sentirsi accolte. La piazza da sempre è il luogo costruito e pensato per accogliere la vita pubblica. Recinto definito architettonicamente e nel suo perimetro fisico che ha determinato la possibilità di non essere individui soli, ma corpo comunitario necessario in cui le parole, idee, pensieri e sensi potessero trovarsi, scambiarsi, anche scontrarsi per dare un senso profondo all’essere cittadini di uno stesso contesto di appartenenza. Senza piazze non avremmo città e, quindi, comunità e, quindi, cittadini. La piazza ha vissuto una progressiva metamorfosi di senso simbolico e materiale perché non è, solamente, lo spazio definito nei suoi caratteri architettonici, ma può essere una strada, uno slargo, un cortile o anche un luogo libero, informe, eletto da una specifica comunità in un tempo definito come luogo in cui stare insieme. Improvvisamente quel luogo che apparentemente non ha forma fisica e sociale, diventa una vera piazza temporanea perché un gruppo d’individui, insieme, l’ha eletta come luogo necessario per esprimersi. Il tempo della piazza è cambiato così come l’idea stessa di questo luogo così necessario alle nostre vite sociali e pubbliche. Non esiste movimento, cambiamento, rivoluzione e scontro nella storia dell’umanità che non abbia avuto le sue strade e piazze capaci di essere occupate e usate per esprimere in ogni modo possibile il cambiamento in atto. Anche negli ultimi decenni in cui si celebrava mestamente la morte delle strade come luogo sociale l’esplosione globale di Occupy Wall Street e delle diverse Primavere Arabe, passando per le ritualità generazionali dei Friday for Future ha dimostrato che le piazze sono ancora centrali e necessarie all’espressione della vita comunitaria, delle sue inquietudini, rabbie irrisolte e volontà di essere ascoltati. Ogni volta la piazza era il cuore e quello che è progressivamente mutato è stato il modo di utlizzarle, perché da spazio dinamico delle manifestazioni “tradizionali” si è passati all’occupazione fisica dei luoghi. Occupy portò centinaia di tende nelle piazze trasformando dei luoghi attraversati rapidamente in veri e propri insediamenti nomadi in cui la vita si fermava, producendo contenuti, momenti di scambio e confronto, abitando attivamente uno spazio che sembrava depotenziato nel suo valore simbolico. Quando la rotonda stradale di Taharir Square al Cairo diventò il cuore della primavera egiziana dimostrò che anche uno slargo stradale poteva diventare capitale temporanea del cambiamento richiesto da una nuova generazione. La piazza davanti al Politecnico di Milano che si riempie di tende per protestare contro la mancanza di alloggi civili e a basso reddito per gli studenti trasforma quel luogo in una comunità vasta che si moltiplica in altre piazze italiane. Quando Greta Thunberg si sedette a terra ogni venerdì mattina sul fianco di una strada pubblica trasformò quei centimetri quadri in una piazza dove il suo corpo resistente, ostinato e consapevole poteva incontrare altre vite, storie e desideri producendo una forma di urbanità che si è riverberata su scala globale. Quei pochi metri quadri diventarono un luogo universale perché attraversati da un’azione capace di produrre un’eco che ha risuonato nelle nostre coscienze e ha illuminato un’inquietudine che albergava nei nostri animi.
Ogni luogo prende corpo e senso simbolico quando l’azione si carica di contenuto, portandoci ad abitare quello spazio con una visione progettuale sul futuro che rende quel recinto minerale un corpo vivo, necessario, vibrante per le energie che ha saputo accogliere.
Forse è per tutte queste ragioni che la parola “piazzare” mi ha così colpito, perché muoveva il senso che indica uno spazio apparentemente fisso all’idea che ognuno dei ragazzi e ragazze che utilizzano quel verbo diventino esse stessi piazza, forma e corpo attivo della città che abitano e che, magari, vorrebbero cambiare.
La cosa interessante è che la maggior parte di queste azioni consacra piazze minori, quasi informi, raramente le maggiori e più strutturate, forse perché meno impositive nei rituali e nella forma degli spazi che definiscono il recinto del luogo eletto. Negli anni Novanta e anche prima si eleggeva un muretto dove stare e ritrovarsi, mentre adesso si dice “piazzare”, che è un’azione che elegge un luogo più ampio, che si ferma e abita quel recinto con tempi e modi sempre più nomadici con una sorta di azione statica che ci spiega, ancora, che le parole sono organismi vivi con una dinamica culturale e sociale instabile, legata alle generazioni che se ne appropriano per stabilire un fenomeno specifico. Eppure questa azione elementare e urbana sta producendo reazioni preoccupate soprattutto da chi ci governa e Milano, vero laboratorio di un Paese che sta mutando pelle, ci offre qualche elemento di riflessione politica e progettuale.
Basta navigare in rete per trovare tracce di un conflitto generazionale su cui vale la pena riflettere.
Una serata come tante altre. Un sabato sera in una piazza della media periferia residenziale milanese dove s’incrociano vite diverse. C’è chi porta il cane fuori, chi cerca parcheggio, chi cammina per andare a un appuntamento, poi c’è un gruppo numeroso di ragazzi e ragazze di un liceo cittadino che sono lì a piazzare tranquillamente. Nelle vicinanze una signora viene purtroppo scippata della borsa e chiama la polizia per sporgere denuncia. Arrivano prontamente due volanti che registrano il fatto per poi guardare verso il gruppo dei ragazzi e dirigersi verso di loro senza che ci sia correlazione tra un fatto e l’altro. Alla richiesta dei poliziotti su cosa facessero in piazza è seguita la naturale risposta che il ritrovo era informale e tra amici per stare insieme. Stavano “piazzando”, appunto. La reazione a questa normale spiegazione è stata quella di considerare quel gruppo un assembramento pubblico non autorizzato eccessivo, ormai normato nei numeri dal nuovo Decreto Sicurezza, con la conseguenza che un centinaio di ragazzi e ragazze sono stati identificati singolarmente. Siamo così abituati a un numero crescente di forze dell’ordine in ogni piazza, stazione, spazio pubblico, treni da trovare quasi normale che ti vengano chiesti i documenti e che i tuoi dati siano immagazzinati nell’archivio del Ministero degli Interni con una frequenza sempre più intensa. Ci dovremmo sentire rassicurati, ma la linea di confine tra sicurezza e controllo è sempre più sottile e si riversa soprattutto sulle generazioni più giovani.
Milano è la città in cui ogni strada, piazza e marciapiede è in affitto e viene sempre più occupata da recinti, bersò, pergole che riducono la sezione percorribile delle vie e delle piazze. L’effetto temporaneo che permetteva dopo la pandemia di usare le strade come luogo in cui stare insieme a distanza di sicurezza e all’aria aperta è diventato ormai stabile ed è sicuramente fonte di reddito significativa per l’amministrazione pubblica.
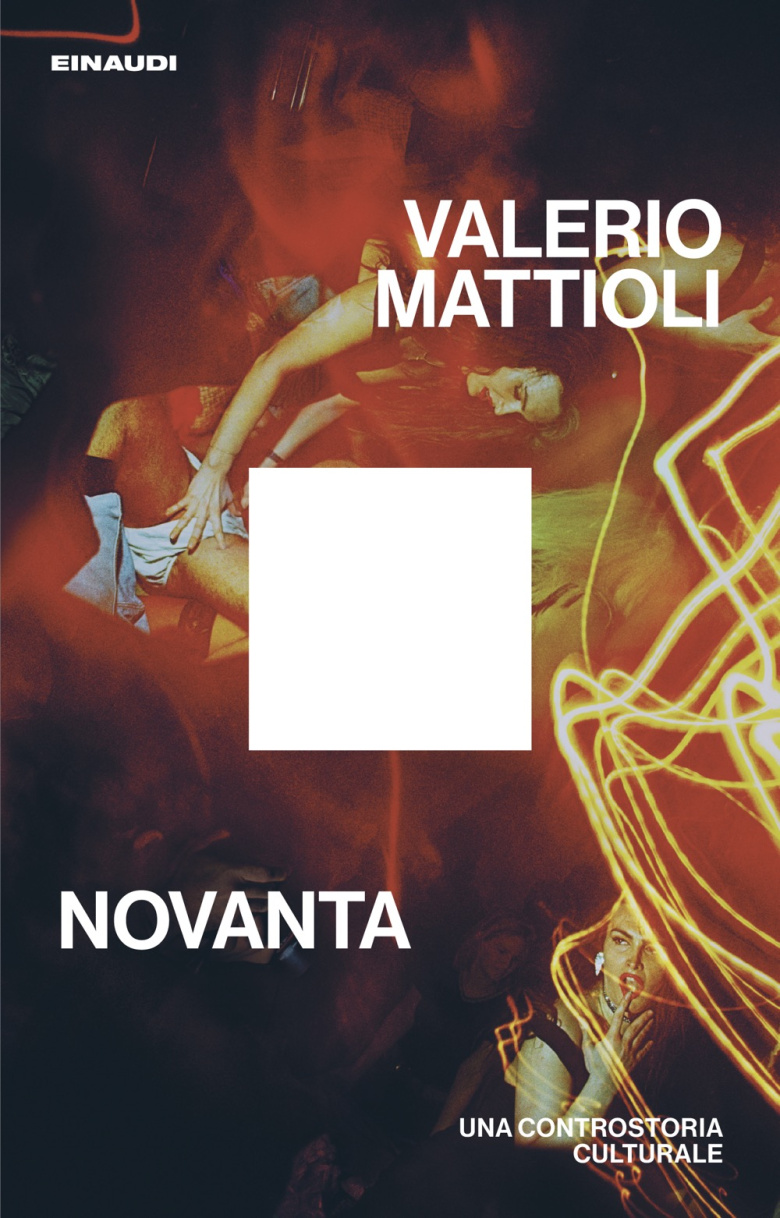
Ogni luogo delle nostre città è in affitto o in vendita temporanea e la linea di confine tra spazio pubblico (ovvero di tutti i cittadini), spazio pubblico in gestione privata e spazio privatizzato è sempre più pericolosamente ambigua e porta l’esclusione delle fasce più fragili e deboli economicamente.
Una città in cui tutto è in affitto ed è performante e che, contemporaneamente, non ha la forza politica di proteggere e tutelare i suoi centri sociali non può essere definita propriamente città.
Una città in cui la pratica degli affitti brevi, degli Rb&b, dei costi non calmierati porta alla progressiva espulsione dei ceti medio-bassi e degli studenti meno abbienti verso altre città più attente e accoglienti non è più città perché smette di avere cittadini che la abitano, che votano e che partecipano alla sua vita quotidiana.
Una città che si vanta di aumentare il numero di studenti fuori sede, possibilmente stranieri, dei manager a reddito alto, dei turisti, piuttosto che aiutare i suoi abitanti tradizionali e stanziali a vivere civilmente la propria città, non è più una città.
Una città che guarda alle piazze solo come spazi di auto-celebrazione (rigidamente sponsorizzata) e che insieme le demonizza perché popolate dalle manifestazioni non autorizzate, dai “maranza” di periferia, da “quelli dei centri sociali” e da comunità sempre più fluide, senza interrogarsi sulla rabbia e le inquietudini che li accompagnano, non può definirsi città.
Ma torniamo al verbo “piazzare” e a Milano, dove non solo è stato chiuso il Leoncavallo, con un effetto simbolico molto chiaro dal punto di vista politico e la preoccupante ammissione dell’amministrazione locale di non essere stata avvisata dal Ministero degli Interni, ma dove ogni centro sociale è messo sotto scacco, monitorato dalle forze dell’ordine come un centro pericoloso per la nostra vita pubblica, additato dalla politica più aggressiva e reazionaria come somma di tutti i mali per la quieta vita della maggioranza silenziosa. Quei centri sociali, che recentemente Valerio Mattioli nel suo libro Novanta. Una controstoria culturale (Einaudi, 2025) ha indicato come il reale polmone e cuore di libertà e produzione intellettuale, musicale, politica e artistica di Milano, oggi sono sempre più considerati come inutili riserve indiane di vetero marxisti e anarchici, quando una nuova generazione di ragazze e ragazzi vorrebbe ripensarli perché diventino dei veri, generosi, laboratori di libertà e scambio che mancano sempre di più in una città mercificata, inaridita e nel punto basso di una curva politica che chiede un radicale ripensamento.
La città contemporanea ci sta insegnando che la separazione tra spazio pubblico e quello privato è sempre più labile e in mutazione e questo elemento dovrebbe fare riflettere le nuove amministrazioni non come tema economico ma come soggetto di progettualità sociale.
Ogni piazza può diventare un centro sociale temporaneo e ogni centro sociale è una piazza aperta alle diverse realtà sociali che abitano il territorio, ed è dimostrato dal fatto che molte di queste nuove realtà politiche cerchino una relazione di scambio, confronto e cura con tutte quelle comunità fragili e diverse che popolano il territorio attiguo diventando dei veri spazi pubblici di solidarietà e conforto reciproco. Queste riflessioni dovrebbero suggerire alla politica vera d’interrogare quello che sta avvenendo per ripensare la politica degli spazi pubblici per le future comunità.
Riflettere su “piazzare” vuole dire guardare finalmente a chi usa questa parola.
La generazione dei nostri adolescenti è quella che ha fatto la pandemia e le scuole medie chiusa in casa, è quella che non dà alcun senso alla parola “futuro” perché non lo riconosce come valore, è quella che vede un mondo prodotto di disparità sociali ed economiche sempre più estreme e ingiuste, è quella che ha vissuto il crack economico, la pandemia, il senso di una irreversibile crisi ambientale e due conflitti devastanti che ancora appaiono irrisolti, oltre che di una scena politica globale in cui l’idea di forza, autorità e aggressività tardo capitalista è portata a un livello inimmaginabile sino a pochi anni fa.
Una città che stringe le strade privatizzandole per ogni ristorante pronto a pagare l’affitto, che trasforma le piazze storiche in perimetri esclusivi per chi consuma, che monetizza ogni spazio potenzialmente sfruttabile, che non alimenta una forma di sostentamento alla costruzione di nuovi centri sociali, che identifica i suoi giovani che stazionano “pericolosamente” in uno spazio pubblico che orizzonte può dare a una generazione di futuri cittadini?
In un momento in cui la politica nazionale di questo governo demonizza ogni forma di critica e di alternativa attraverso leggi e decreti che trasformano silenziosamente le nostre città in arcipelaghi di zone rosse, aree militarizzate, considerando ogni possibilità di azioni antagoniste passibili di azioni penali, quali spazi di progettualità o di azioni alternative sono possibili?
In questo specifico contesto politico le amministrazioni locali hanno un ruolo politico decisivo per bilanciare la deriva autoritaria centrale sul controllo degli spazi pubblici mentre la cultura del progetto dovrebbe offrire strumenti e visioni utili per supportare un cambiamento necessario alternativo. Non si tratta solo di pensare al make-up coloristico delle nostre piazze o di mettere qualche tavolo da ping pong, ma di pensare radicalmente il sistema degli spazi per le comunità e le loro possibilità di un accesso economico specifico e facilitato che consenta a nuove azioni culturali e politiche di crescere e diventare le piazze e i centri sociali di una generazione di cittadini e cittadine che non va fatta scappare, ma che vuole abitare la città. Milano tra meno di due anni andrà a votare e credo che questo tema, insieme all’emergenza abitativa, dovrebbe essere uno dei cardini di un vero programma che sia insieme politico, culturale, sociale ed economico. Si tratta di tornare ai fondamentali simbolici per una città che attualmente vive uno strano oblio compiaciuto e stanco, ma che ha sempre dimostrato di avere gli anticorpi e le energie per ripensarsi.
“Piazzando” in posti spesso dimenticati e fetenti le nostre ragazze e ragazzi dimostrano la necessità di resistere e sopravvivere in una città che sembra non volerli, ma anche una forma vitale di attenzione e colonizzazione dello spazio pubblico che reagisce a chi ci vorrebbe tutti in casa felici, consumatori e senzienti. Solo in questo modo potremo coltivare la cura dei luoghi che abitiamo e il loro futuro per le prossime generazioni, in attesa che emerga una nuova parola progettante che ci spiazzi.







