Berta Isla e non solo / Intervista a Javier Marías
Nonostante Javier Marías costruisca trame elaborate e persino avvincenti, il suo non è un mondo di fatti bensì di congetture, di tormentate interpretazioni, di ipotesi controfattuali. Quel che accade occupa uno spazio variabile a seconda dei romanzi, ma quanto sarebbe potuto accadere impegna più scrittura, più dedizione dell’autore, e alla fin fine è ciò che rende pregevolmente inconfondibile il suo avanzare verso un climax che non costituisce, patentemente, lo scopo cui tendono i suoi libri. Nell’ultimo, intitolato a una dei due protagonisti, Berta Isla (traduzione di Maria Nicola, Einaudi) le svolte dell’intreccio hanno un ruolo fondamentale; ma, ancora una volta, è ciò che non appare, quel che la superficie dei fatti non evidenzia, a imporsi in primo piano. Già l’incipit del romanzo, che torna con quasi identiche parole nel capitolo conclusivo, dice qualcosa dell’incertezza che colonizza la mente della protagonista: “Per molto tempo non avrebbe saputo dire se suo marito era suo marito… A volte pensava di sì, altre volte di no, e a volte decideva di non pensare e di continuare a vivere la sua vita con quell’uomo che assomigliava a lui…” Non che l’identità del protagonista maschile, Tomás Nevinson, sia in discussione; insondabile è piuttosto la sua aderenza a quel che mostra di sé, a ciò che lascia apparire dall’indistinzione del proprio orizzonte di vita, dove i tempi della sua assenza priva di notizie prevalgono via via su quelli in cui riappare, visibilmente straniato e distante, ma amaramente consegnato al suo segreto: qualcosa che ha scelto nella convinzione che non gli fosse dato scegliere.
Tomás Nevinson è un brillante studente di Oxford, perfettamente in possesso dell’inglese del padre e dello spagnolo della madre, dotato nell’apprendimento delle altre lingue come in ogni virtù mimetica, quando Wheeler, il suo professore di cui si conosce il passato di spia, tenta di convincerlo a arruolarsi nei servizi segreti MI6. Al momento non gli riesce, ma il ragazzo non sembra essere l’arbitro del proprio destino: una doppia manovra centrata su qualcosa di mai avvenuto lo incastrerà per la vita. Il mediatore è un personaggio cinicamente affascinante, l’agente segreto Bertram Tupra, già noto ai lettori di Marías, che lo aveva introdotto nella trama di Il tuo volto domani. Intanto Berta – che ha sposato Tomás al tempo stesso con convinzione e ineluttabilità – passa il tempo a aspettarlo nella casa di Madrid, che condividono per pochi periodi l’anno. E mentre lo aspetta, non sa cosa pensare delle sue lunghe assenze, né perché appaia così inquieto quando finalmente ritorna, a scadenze sempre meno ravvicinate. Non a caso il romanzo è intitolato a lei: sua è la sola voce che parla in prima persona, suoi i passaggi mentali più significativi, ma anche le parentesi di azione cariche di suspence, mentre gli anni passano – dal 1969 e il 1995 – e l’unica certezza è l’ineluttabilità dell’attesa.
In questo romanzo chi agisce, ovvero Tomás Nevinson, lo fa perlopiù nell’ombra, e ciò di cui si rende responsabile, nel bene e nel male, non lo verremo mai a sapere. L’azione di Berta, invece, consiste perlopiù in una lunga attesa, che si sforza di non riempire di congetture, e tuttavia la costringe a lottare con l’ansia. Per questo ha affidato la trama del romanzo a un narratore extradiegetico, estraneo ai fatti, e ha fatto parlare in prima persona solo Berta?
Dal 1986, quando ho pubblicato L'uomo sentimentale, tutti i miei romanzi erano scritti in prima persona, e anche i miei racconti, con una sola eccezione, tanto che non sapevo se sarei stato capace di "tornare" alla terza. Ma, non appena ho cominciato a scrivere in prima persona, come d'abitudine, mi sono reso conto che sarebbe stato impossibile scaricare su Berta la responsabilità di una lunga narrazione: avrebbe dovuto fare troppe congetture e supposizioni, dopo tanti anni trascorsi lontano dal marito Tomás. Ho deciso, perciò, di usare la terza persona per raccontare "qualcosa" della vita di Tomás Nevinson, perlomeno il modo in cui si è ritrovato dentro i fatti che lo hanno coinvolto. Ovviamente, non volevo nemmeno dire troppo, ci sono già abbastanza romanzi di avventure e "peripezie", non volevo aggiungerne un altro. Per questo ho optato per un'alternanza del punto di vista, a seconda di quello che mi conveniva nei diversi passaggi. Da molto tempo sono convinto che, in un mondo frammentato come quello in cui viviamo e dove non è possibile essere certi neppure delle nostre azioni, affidare un romanzo a un narratore onnisciente risulti più inverosimile. Ma mi sono anche reso conto che la terza persona offre alcuni vantaggi: la possibilità di essere più arbitrari e il non dover giustificare sempre come si è venuti a sapere quel che si sa.
Fino a un certo punto della sua esperienza di narratore, lei ha detto di trovare troppo straniante affidare l’io del romanzo a un personaggio di sesso diverso dal suo; ma già già negli Innamoramenti era la voce di Maria a raccontare. Qui l’immedesimazione nella psiche femminile è ancora più compiuta: quando e come ha risolto, da un punto di vista narrativo, questa distanza?
Beh, immagino che il precedente di Gli innamoramenti mi abbia “allenato" un po', è ovvio. Oggi non provo più quella insicurezza iniziale sperimentata allora. Del resto, sono sufficienti l'osservazione e l'immaginazione. Ho osservato molte donne intelligenti che ho avuto accanto; poi interviene l'immaginazione. Come dissi già quando pubblicai Gli innamoramenti, nel 2001, uomini e donne non sono così diversi, per quanto riguarda il compito di farne il narratore o la narratrice di un romanzo: devono comunque raccontare, osservare, riflettere, descrivere.
Quando lei introduce Berta al lettore la descrive come una ragazza sicura di sé, destinata a un ruolo protagonista, capace “di far credere a tutti che la cosa peggiore che potesse capitare loro era di perderla…”. Ma alla fine del romanzo, nel ricapitolare la sua esistenza, Berta si rende conto che non è il vuoto lasciato da Tomás a averla fatta soffrire di più, bensì la propria irrilevanza nella vita di lui: “Quanto poco ho contato per te – dice – Che ruolo insignificante ho avuto”. È stata la prima volta, forse, che ha affrontato in modo così centrale questo problema, vero?
A dirla tutta non lo so. Ora che me lo fa notare, penso che María Dolz, la protagonista e narratrice di Gli innamoramenti, provi qualcosa di simile nei confronti dell'uomo che ama, Díaz-Varela. E in un certo senso Eduardo Muriel, uno dei personaggi principali di Così ha inizio il male, scopre quanto poco importino le sue decisioni alla moglie, Beatriz Noguera, che l'ha ingannato per trattenerlo accanto a sé. L'irrilevanza nella vita dell'altro si manifesta in molti modi: anche nel fatto che qualcuno non tenga conto dei nostri desideri e sentimenti pur di raggiungere il proprio obiettivo, sebbene l'obiettivo si limiti all’averci accanto, com'è il caso di Beatríz e Muriel. Almeno in parte, tutto ciò riguarda la scoperta di un rapporto utilitaristico da parte dell'altro.
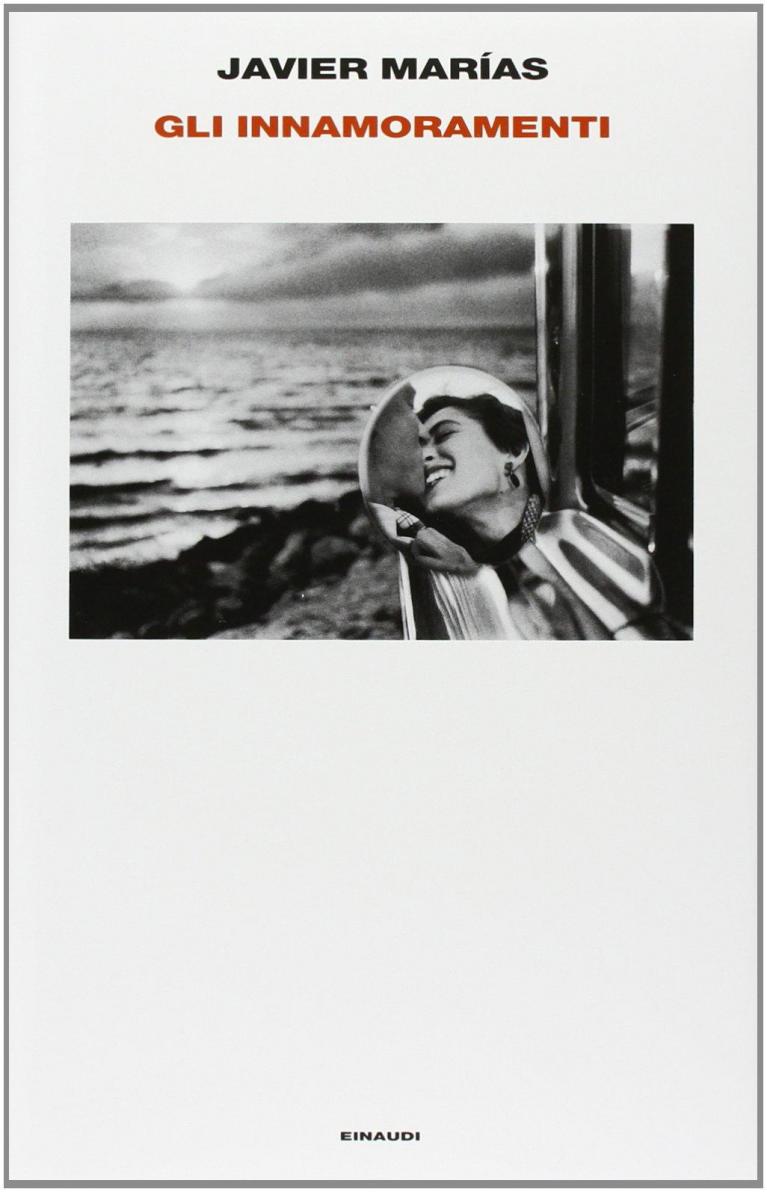
Wheeler, il professore che sarà il responsabile più o meno diretto dell’arruolamento di Tomás nei servizi segreti, ha una concezione hobbesiana della vita: “Ci sono sempre vaste porzioni dell’umanità che cercano di danneggiarne altre, o di strappare loro qualcosa, regnano sempre il rancore e la discordia, e quando non regnano si preparano e stanno in agguato. Quando non c’è la guerra c’è la sua minaccia…” E la sua sfiducia nelle risorse della legge è radicale: “Chiunque può finire un carcere per un capriccio”. Queste convinzioni sono anche le sue?
Immagino di condividerle in parte. Guardi, non scriverei quel che dice Wheeler nei miei articoli, perché anche se spesso non sembra, in quella sede mi sento obbligato a essere più ottimista che nei romanzi. Non si può rovinare la colazione ai lettori ogni domenica. Si crede o si finge di credere, sia pure fino a un certo punto, che le cose possano migliorare, almeno nel concreto, a breve termine. Altrimenti, perché prendersi la briga di esprimere opinioni ogni settimana? Si segnala quello che ci sembra stupido, sbagliato, ingiusto, pericoloso, con il proposito di influire un poco sull'immediato presente. Nei romanzi invece non è Javier Marías a parlare, ma i personaggi (compresi il narratore o la narratrice), e in questo territorio fittizio si può essere più pessimisti e più brutali, sapendo che il lettore saprà di trovarsi in una finzione. Nei romanzi si è più sinceri: compete al lettore pensare: "Questo è vero, ma non lo è, perché siamo in un romanzo e parlano persone che non esistono né sono esistite". D’altra parte è anche vero che uno come Wheeler, membro dei Servizi Segreti durante la guerra, non può pensarla diversamente.
Lei ha trasferito in questo libro personaggi che già comparivano nella trilogia titolata Il tuo volto domani. Lì Jaime Deza veniva sfruttato da un misterioso centro di spionaggio inglese grazie alla capacità di indovinare dalla faccia di una persona il suo comportamento futuro; qui, invece, Tomás viene arruolato grazie alla sua straordinaria conoscenza delle lingue e alle sue virtù mimetiche. In entrambi i libri torna il loro “capo”, Bertram Tupra, uno spregiudicato agente dei servizi. Qual è lo spirito con cui è andato a ripescare queste sue “creature”, e cosa cerca, principalmente, di ottenere nella costruzione dei suoi personaggi?
Alcuni personaggi indugiano nell'immaginazione dell'autore, che vede in loro più possibilità e sul cui passato o futuro si interroga ancora. E ci sono autori che creano un territorio dove tornano più volte (da Yoknapatawpha di Faulkner a Región di Benet, o a Macondo di García Márquez). I miei confini geografici non sono immaginari, sono soprattutto Madrid, Oxford, Londra. Ma ho un "territorio" di temi e di personaggi che passano da un romanzo all'altro. E anche di immagini e frasi che ricompaiono. Non ci sono misteri.
Lei mette certamente molta cura nel progettare la trama di ogni suo romanzo, ma alla fin fine questa non è che l’ossatura, lo scheletro. La carne è fatta di lunghe digressioni, delle congetture alle quali i personaggi sono costretti, oppure – come in Domani nella battaglia pensa a me – di quel che sarebbe potuto accadere più che di quel che effettivamente accade. E quindi è come se ci fosse un prevalere delle interpretazioni sui fatti, è d’accordo?
Non spetta a me dire cosa prevale. È vero che non curo troppo le trame, perché queste si aprono il passo da sole, in modo improvvisato o quasi istintivo. Del resto, se conoscessi tutto quanto accadrà nel libro fin dall’inizio non lo scriverei più.
Spesso nei suoi libri lei ha dato molta importanza, e quindi ha investito molta scrittura, in ciò che non si è verificato, nelle opportunità scartate, nelle scelte mancate. Qui, in Berta Isla, la situazione si capovolge, ma la filosofia sembra essere la stessa: “Anche quello che esiste, non esiste”, dice Tomás a Berta, tentando di spiegarle la situazione nella quale si trova. L’inafferrabilità delle situazioni sembra essere per lei un grande motore romanzesco, è così?
Sì, credo che quanto esiste, al tempo stesso non esista, o almeno che arriverà un momento in cui sarà sarà indifferente che sia esistito. Non voglio entrare nella questione contemporanea delle fake news e di tutto il resto che è collegato a questi problemi, ma penso che viviamo in un'epoca in cui a molta gente importa sempre meno se le cose, o i fatti, esistano o no. È come se il futuro avesse già invaso il presente.
Quando Tupra cerca di spiegare a Tomás l’essenza della loro segretezza – “Siamo qualcuno e non siamo nessuno. Ci siamo ma non esistiamo, o esistiamo però non ci siamo…” – conclude così: “Noi siamo come il narratore in terza persona di un romanzo… Non ha nome e non è un personaggio…” Qui Tupra pretende di annullare ogni principio di responsabilità, infatti più tardi dice: noi siamo qualcosa “di analogo a una convenzione”. Cosa intende esattamente?
Tupra dice quelle frasi in questo senso: apriamo un romanzo, qualcuno comincia a raccontare (se è in terza persona), lo accettiamo come una convenzione, senza chiederci quasi mai chi sia e perché sappia quello che sa e affermi quello che afferma, con quale missione o con quale scopo. Il nome dell'autore è sulla copertina, di solito c'è anche una nota biografica, una foto, spesso una dedica. Fin qui nulla di ingannevole: quell'autore ha scritto il libro. Ma, a partire da un dato momento, accettiamo la convenzione secondo la quale è qualcun altro a essere responsabile di quanto viene detto. È come quando, un tempo, a teatro si alzava il sipario: ci dimenticavamo (più o meno) di sedere in poltrona, di essere arrivati da casa, del taxi che ci aveva portato fino all'ingresso. "Adesso è un'altra cosa", ci dicevamo. A questo, più o meno, si riferisce Tupra quando descrive il proprio compito.
Nessuno, in questo romanzo, sceglie davvero la propria vita. Non solo Tomás si precipita verso il suo destino senza nemmeno riflettere, come non avesse scelta, quando invece una scelta l’aveva; ma anche il suo matrimonio con Berta sembra iscritto in una necessità ineluttabile. Entrambi si amano, ma come se non potessero farne a meno. Questo fatto di ritrovarsi a essere poco artefici della propria vita coincide con la sua visione dei nostri destini?
Nella mia visione del mondo e in quella di quasi chiunque abbia un minimo di intelligenza. Crediamo di agire secondo la nostra volontà, almeno nelle società occidentali, ma dalla nascita siamo prigionieri di mille condizionamenti e limitazioni. Ne parlavo molto chiaramente negli Innamoramenti. Non sappiamo mai, per esempio, se chi ci ha sposato lo abbia fatto perché eravamo liberi, o disposti a farlo, o perché eravamo il sostituto di qualcuno che in precedenza aveva rifiutato colei, o colui, che ha finito per diventare nostra moglie o nostro marito. E non si tratta solo di questo: verso la fine, Tupra ne parla con Tomás Nevinson e gli dice che l'idea di poter "scegliere" è recentissima, che la maggior parte dell'umanità non lo ha mai fatto, e che in gran parte del mondo le cose stanno ancora così. Scegliere è un miraggio delle società ricche e viziate. La forza di volontà conta, naturalmente, e con essa si ottiene molto, ma a dire il vero questa forza è qualcosa di molto debole e relativo.
Molti dei suoi motivi principali ricorrono in vari suoi libri. Per esempio, nell’epilogo di Tutte le anime lei scrive: “Crediamo di poter raccontare le nostre vite in maniera più o meno ragionata e precisa, e quando cominciamo ci rendiamo conto che sono affollate di zone d’ombra, di episodi non spiegati e forse inesplicabili, di scelte non compiute, di opportunità mancate, di elementi che ignoriamo perché riguardano gli altri, di cui è ancora più arduo sapere tutto o sapere qualcosa.” Da un punto di vista narrativo, come sintetizzerebbe le opportunità che le derivano dal coltivare le zone d’ombra?
Sono più interessanti, no? E sono quelle che hanno più spazio, che lo crediamo o meno. Le zone d'ombra, e il mistero del tempo, sono i temi principali di qualunque romanzo degno di questo nome, almeno per me. Sono il territorio dell’ambiguità, dell'indecisione, del dilemma, ed è questo, in larga misura, che dà forma alla vita, almeno a quella che interessa me. Una vita piena di certezze, soddisfatta, che non si fa mai domande e crede di aver tutto chiaro, è, di solito, una vita dogmatica, priva del minimo interesse. Per questo sono detestabili i romanzi "a tesi", quelli che racchiudono un "messaggio", quelli educativi, quelli di "denuncia sociale", quelli che mettono la letteratura al servizio di altre cause. L'oggetto della letteratura è quanto c’è di più indecifrabile, è il mondo della contraddizione e del paradosso, del volere e non volere, del sapere e non sapere. Tutti i grandi autori, da Shakespeare a Conrad a Proust, hanno indagato questo mondo.
Sia i suoi titoli, sia i suoi romanzi hanno spesso al loro interno citazioni letterarie. La ricorrenza è tale da configurarsi come una sua necessità. Di solito, il riferimento è Shakespeare, qui quello più presente è Eliot. Sembra che lei provi un piacere speciale nel riprendere passaggi classici che le sono cari, quasi un piacere da contatto, la voluttà di fare tornare a nuova vita un testo della tradizione: un gesto di gratitudine più che un omaggio. Le è mai capitato di costruire un romanzo a partire da una citazione?
Non sono arrivato fino a questo punto, anche se una volta un critico ha detto che alcune citazioni di classici sembravano esistere solo perché io le scoprissi, le sottolineassi, dessi loro nuova vita e nuova profondità nei miei romanzi. Indubbiamente esagerava, ma, se è accaduto me ne rallegro molto. Quelle citazioni non sono un ornamento, fanno parte della trama, si mescolano alle mie parole e ai personaggi, finiscono per diventare parte del romanzo tanto quanto ciò che ho inventato. E poi sì, il mio è ovviamente anche un gesto di gratitudine, proprio perché spesso la letteratura illumina un poco le immense zone d'ombra che attraversiamo. Soffermarsi sulle questioni poste dalla scena di Enrico V di cui parlano Berta e Tomás è un modo per metterla in risalto e, al tempo stesso, mostrare la mia gratitudine a Shakespeare.
Quando Tom ricompare, oltre vent’anni dopo, e va da Southworth, il suo ex tutor di Oxford per raccontargli quanto della sua vita gli è indispensabile a sapere quel che vuole sapere, il romanzo torna a essere affidato a un narratore in terza persona. Ma man mano che ci si avvicina all’evento cruciale, quello che rivelerà la trappola in cui Tom cadde a suo tempo, è come se il punto di vista si elevasse a dominare il panorama di quanto sta accadendo. È una scena molto efficace, che comunica una grande tensione. Le è costata diverse stesure?
Non scrivo mai più redazioni, ne scrivo, invece molte di ciascuna pagina, e non passo a quella seguente finché non ho dato per buona la precedente. Ciò che resta nella prima versione del romanzo è per sempre. Nei miei romanzi compaiono a volte personaggi la cui morte è stata decisa subito prima di raccontarla, per esempio. E no, non mi è costato particolarmente scrivere quella scena. È vero, però, che poco prima di arrivarci mi sono concesso tre giorni di sosta per decidere che cosa sarebbe accaduto. C'erano altre possibilità.
Una versione più breve di questa intervista è uscita su "il manifesto"







