Gladwell: misteri del cambiamento sociale
Nella bandella del libro Tipping point. La vendetta del punto critico (UTET), l’autore Malcolm Gladwell è stato indicato come «giornalista e sociologo». Giornalista lo è certamente, dato che ha collaborato con autorevoli testate statunitensi, ma è discutibile che possa essere considerato un sociologo. Per essere tale, dovrebbe conoscere la sua disciplina, come d’altronde dovrebbe conoscerla un qualsiasi professionista: un architetto che ha il compito di progettare delle case che stiano in piedi o un idraulico al quale viene chiesto di aggiustare un impianto idraulico malfunzionante. Gladwell sembra invece voler volutamente ignorare il grande volume di conoscenze che la sociologia ha messo a punto in circa due secoli di storia.
I temi di cui Gladwell si occupa certamente sono “sociologici”, perché ruotano attorno alla classica questione della comprensione dei meccanismi di cambiamento della società. Già infatti i fondatori della sociologia si erano posti nell’Ottocento lo scopo d’individuare le principali leggi di funzionamento della società. Comte, Spencer, Durkheim, Simmel e Tarde, cioè, cercavano innanzitutto di comprendere come operi la società. Questa, peraltro, si presentava all’epoca attraverso un modello stabilizzato da tempo come quello moderno, caratterizzato da intensi processi d’industrializzazione e urbanizzazione. Nel Novecento, invece, si è visto che questo tipo di modello non era stabile, ma soggetto a fenomeni di cambiamento. Che cioè fosse necessario focalizzare l’attenzione, più che sul concetto di funzionamento della società, su quello di cambiamento sociale. Ciò è apparso soprattutto evidente a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, quando le principali società capitalistiche hanno mostrato la comparsa di radicali dinamiche di trasformazione. Dinamiche che hanno portato a quello che il tedesco Niklas Luhmann ha indicato come il passaggio dei sistemi sociali maggiormente avanzati da una struttura stratificata a una struttura differenziata basata sulla frammentazione in molteplici subculture. Ed è su questa nuova realtà sociale che si sono concentrati negli ultimi decenni gli sforzi di comprensione di sociologi come Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck o Richard Sennett.
Tutti autori che vengono sostanzialmente ignorati da Gladwell, il cui problema invece è aggiornare, possibilmente ottenendo lo stesso livello di successo mondiale, il suo libro più importante: Il punto critico. Con questo lavoro infatti, che è stato il primo che ha pubblicato, si proponeva nel 2000 di spiegare i fenomeni di cambiamento della società attraverso una semplice metafora: quella della diffusione dei virus nel corpo umano. I fenomeni sociali, cioè, si svilupperebbero a suo avviso come i virus, che si moltiplicano efficacemente riproducendosi senza sosta e generando in tal modo delle epidemie spesso incontrollabili. Analogamente, il «punto critico», per Gladwell, è un livello che, una volta raggiunto, genera un processo di cambiamento sociale inarrestabile. Si ha, cioè, un effetto “a valanga” che è in grado di modificare in brevissimo tempo i comportamenti e le abitudini di vita di molte persone.
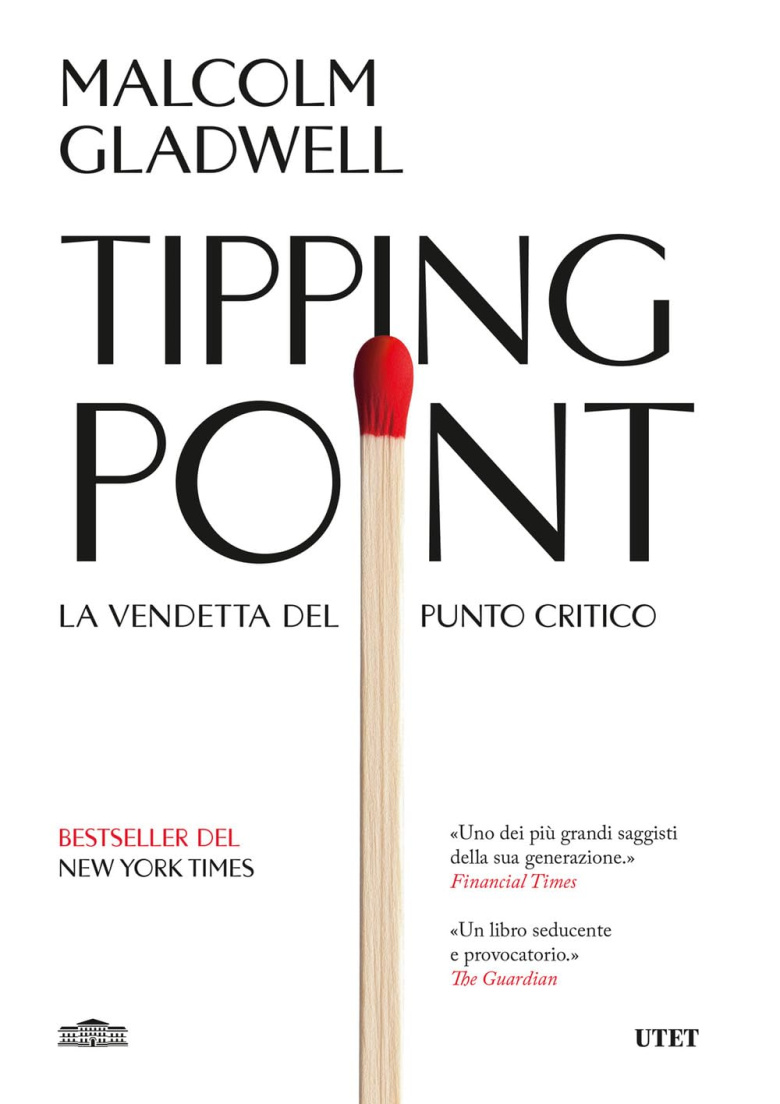
Gladwell ha parlato nel suo primo libro Il punto critico dell’esistenza di vere e proprie “leggi” che a suo avviso regolerebbero il funzionamento dei fenomeni di contagio sociale. Le ha riprese nel nuovo libro e la prima di esse è quella che ha definito «legge dei pochi». I “pochi” sono delle persone che, pur essendo in numero limitato, possiedono delle particolari qualità che le rendono molto potenti sul piano sociale e pertanto in grado d’influenzare gli altri e fare partire delle epidemie sociali. Tali persone appartengono a tre categorie sociali: gli «esperti di mercato» (o «mavens»), che hanno la capacità di raccogliere delle informazioni su un determinato argomento e condividerle con gli altri, i «connettori» (o «connectors»), che hanno la funzione di stabilire relazioni tra ambiti sociali diversi e pertanto favorire la diffusione delle informazioni, e i «venditori» (o «persuaders»), che hanno invece delle doti di convinzione, cioè un particolare carisma che gli consente di persuadere il prossimo.
Gladwell, parlando di questi particolari tipi di individui, non fa altro che ripetere dei risultati di ricerca che sono largamente condivisi da parecchio tempo. Infatti, il sociologo statunitense di origini austriache Paul Lazarsfeld ha dimostrato già a partire dagli anni Quaranta del Novecento il ruolo centrale che viene svolto nella diffusione sociale delle opinioni e dei beni di consumo dagli opinion leader, i quali sono degli individui non dotati di particolari qualità e in possesso della stessa condizione socioeconomica degli altri membri del gruppo che influenzano. Possono però svolgere una funzione di leader in virtù del possesso di una maggiore competenza, derivante da un’elevata specializzazione, da una posizione sociale strategica (perché al centro di un’intensa attività relazionale e con un’elevata esposizione ai mezzi di comunicazione) e dalla capacità di rappresentare dei valori largamente condivisi nella collettività d’appartenenza. Gli opinion leader, pertanto, operano rendendo più autorevoli con il proprio avallo i messaggi provenienti dai media, diffondendo le comunicazioni venute dall’esterno cui difficilmente i membri del gruppo potrebbero avere accesso e filtrando contemporaneamente tali comunicazioni per eliminare quelle non conformi agli interessi, ai valori e alle norme dominanti nel gruppo.
Da ciò è derivata una teoria assai nota nell’ambito degli studi sugli effetti sociali prodotti dai media: quella di Lazarsfeld, Berelson e Gaudet nota come «two-step flow of communication» («flusso di comunicazione a due livelli»). Secondo tale teoria, tra i messaggi emessi dai media e la comunicazione interpersonale non esiste antagonismo, né indipendenza, ma un rapporto di pacifica collaborazione. Il messaggio proveniente dai media (primo livello del flusso di comunicazione) viene “filtrato” dai rapporti che si instaurano tra le persone (e tra esse e i leaders) e poi trasposto a un secondo livello. Lazarsfeld ha successivamente sostenuto che il processo di diffusione delle comunicazioni non opera su due soli livelli, ma attivando un più articolato sistema di comunicazione a più stadi, nel quale i messaggi vengono dunque “filtrati” da diversi soggetti.
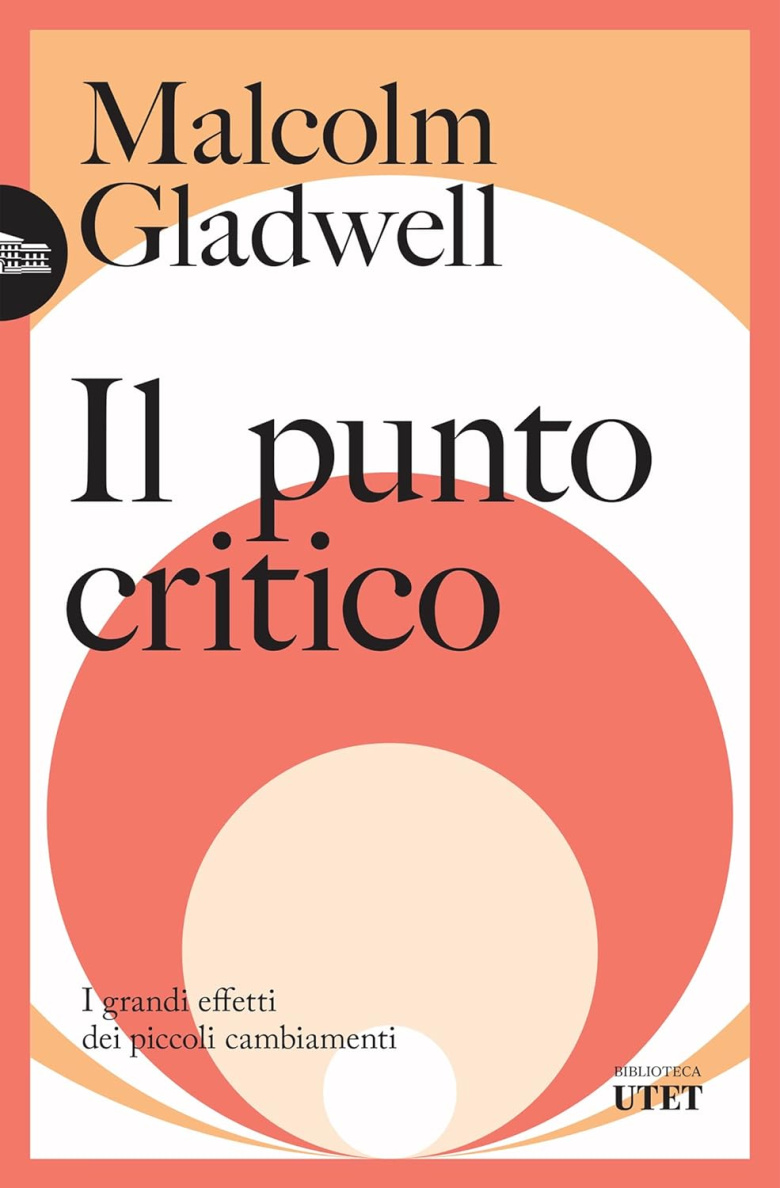
Oltre a queste ricerche sugli effetti esercitati dai media, nei decenni precedenti l’uscita nel 2000 del libro di Gladwell Il punto critico, erano da tempo stati condotti anche molti studi di marketing relativi al ruolo che alcune particolari persone esercitano nell’influenzare le scelte d’acquisto di altri individui. In questo ambito era già nota, ad esempio, la figura del «market maven», ovvero un «esperto di mercato», un leader “trasversale” che per la sua particolare personalità interessata a tutti gli aspetti che riguardano il mondo dei consumi è portato a raccogliere continuamente informazioni su qualsiasi tipo di prodotto, prezzo o negozio. Viene considerato pertanto dagli altri individui una preziosa fonte di orientamento per i prodotti a basso prezzo, rispetto ai quali è solitamente l’unico leader a essere consultato. Per i prodotti più costosi e complessi, invece, può cercare d’indirizzare i consumatori verso opinion leader che, in virtù della loro specializzazione, possiedono delle informazioni maggiormente accurate.
Prima del 2000, però, è stato individuato negli studi di marketing anche un altro specifico tipo di opinion leader: il cosiddetto «consumatore innovativo», cioè un individuo propenso ad acquistare nuove marche e prodotti appena compaiono sul mercato e comunque il più possibile prima degli altri. Si tratta di un soggetto spinto generalmente a specializzarsi su prodotti di un particolare settore merceologico, verso il quale manifesta un elevato coinvolgimento. In ciò è simile agli opinion leader in generale, i quali però si occupano di solito di prodotti che non sono più nuovi. Il consumatore innovativo contribuisce inoltre a rendere il nuovo prodotto più conosciuto e a legittimarne l’uso presso i non-consumatori.
Gladwell ha proposto nel suo primo libro, e ripreso nel nuovo, altre due “leggi” a suo avviso in grado di descrivere efficacemente il funzionamento dei fenomeni di contagio sociale: «il potere del contesto», che sottolinea la fondamentale importanza rivestita dall’ambiente sociale nell’influenzare i comportamenti delle persone, e «il fattore presa», che invece evidenzia come la capacità d’influenzare i comportamenti dipenda dalle modalità con le quali si comunica, che dovrebbero essere il più possibile orientate a favorire il recepimento del messaggio.

Il primo libro di Gladwell ha ottenuto un notevole successo sul piano delle vendite, ma è stato oggetto anche di numerose critiche. In particolare, è stato contestato per essersi principalmente basato sui risultati di un celebre esperimento di psicologia sociale effettuato nel 1969 negli Stati Uniti da Jeffrey Travers e Stanley Milgram. Tale esperimento aveva dimostrato che mediamente per mettere in connessione due persone sconosciute sono necessari al massimo sei passaggi, dunque «sei gradi di separazione». In seguito, però, tale esperimento è stato ripetuto e si è evidenziato che quelli che Gladwell ha chiamato i «connettori» svolgevano in realtà un ruolo decisamente marginale sul piano sociale. Insomma, le ricerche sperimentali hanno messo in discussione le idee di Gladwell, il quale comunque venticinque anni dopo ha ripresentato esattamente uguale la sua tesi in Tipping point. La vendetta del punto critico. E l’ha fatto non cercando di argomentare le sue opinioni allo scopo di contrapporle alle critiche ricevute, ma adottando il suo abituale e brillante stile di comunicazione, basato sulla presentazione di una grande quantità di casi tratti dalla vita quotidiana delle persone. Uno stile dunque di tipo narrativo, che probabilmente rappresenta anche la principale ragione del grande successo mondiale ottenuto da questo autore. Il quale, nel libro più recente, racconta con dovizia di particolari, casi come l’epidemia di rapine in banca sviluppatasi a Los Angeles durante gli anni Novanta, l’effetto depressivo esercitato sulle vaccinazioni infantili dalle scuole che adottano il modello pedagogico steineriano, la natura di quella che viene considerata la più gigantesca truffa americana nell’ambito dell’assistenza sanitaria e l’epidemia di oppioidi, che ha causato negli ultimi anni negli Stati Uniti il decesso di parecchie migliaia di persone.
Gladwell scrive con uno stile piacevole a leggersi, ma molto lontano da quello di tipo scientifico. E la scienza, come abbiamo detto, ci dimostra che gli «esperti di mercato», i «connettori» e i «venditori» di Gladwell sono efficaci nell’influenzare i comportamenti delle persone, ma non così decisivi come tale autore sostiene. Analogamente a come non sono molto efficaci nemmeno quelli che nell’ultimo libro egli chiama «superdiffusori» e che sono molto simili ai precedenti. Tutti, in realtà, fanno parte di quell’insieme di persone che oggi di solito vengono denominate influencer. Cioè quei personaggi su cui le aziende investono molto, anche seguendo le indicazioni di Gladwell, allo scopo di cercare d’influenzare le scelte effettuate dagli altri consumatori. Sarebbe meglio però che, anziché dare retta a Gladwell, i manager aziendali riducessero gli investimenti finalizzati a “influenzare” gli influencer e dedicassero una maggior quantità di risorse e attenzioni per cercare di elevare il livello qualitativo dei messaggi che indirizzano verso i consumatori. Così facendo, potrebbero raggiungere dei risultati economici più soddisfacenti. Gladwell, certamente, potrebbe continuare a scrivere i suoi libri contenenti molti casi interessanti. E ci sarebbero probabilmente anche molti lettori interessati a quello che scriverebbe. La scienza, però, è un’altra cosa.







