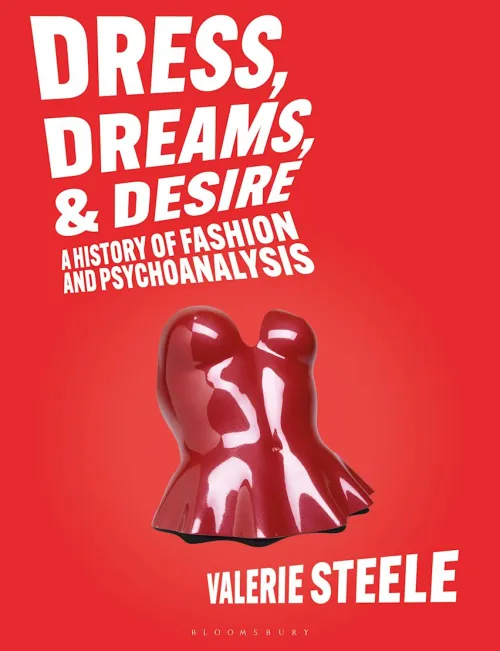La moda sul lettino
La moda è uno dei dispositivi principali attraverso cui costruiamo e rendiamo leggibile la nostra identità. Nonostante la persistenza di giudizi che la relegano a fenomeno superficiale, si offre sempre più chiaramente come una “superficie profonda”: una soglia in cui il visibile si intreccia con ciò che resta a volte opaco anche a noi stessi. Ogni gesto del vestire — anche il più automatico — si carica di significati che non controlliamo del tutto. È forse in questa eccedenza che moda e psicoanalisi si incontrano, nel tentativo di dare forma a desideri, inquietudini, fantasie che attraversano il corpo.
Dress, Dreams, and Desire: Fashion and Psychoanalysis è la prima mostra a ripercorrere in modo sistematico la storia dei rapporti tra moda e psicoanalisi, seguendo alcune costellazioni concettuali ricorrenti: corpo, sessualità, inconscio. Quasi cento capi — da Alaïa a Kawakubo, da Versace a McQueen — diventano tracce materiali attraverso cui osservare come le teorie psicoanalitiche abbiano influenzato il modo di immaginare il corpo nel Novecento e oltre. Curata da Valerie Steele, direttrice del Museum at FIT, la mostra si inserisce nel suo percorso intellettuale di lunga durata dedicato a decifrare la moda come fatto culturale complesso. Anni fa, la critica di moda Suzy Menkes aveva definito Valerie Steele come la “Sigmund Freud della moda”. Un’affermazione giornalistica, che tuttavia coglieva nel segno: Valerie Steele, storica affermata, è stata la prima a portare la moda fuori dalla “gabbia del frivolo”, indicandone il valore sociale e le connessioni culturali, in particolare con la fondazione nel 1997 della prima, e ancora oggi più autorevole, rivista scientifica sulla moda: Fashion Theory. Già autrice e curatrice di libri e mostre sul tema dell’erotismo e del feticismo, in questa mostra dedicata interamente alla psicoanalisi, Steele inquadra abiti e accessori nella cornice delle interpretazioni principali della disciplina psicoanalitica sulla sessualità e sull’inconscio.
Il percorso espositivo si apre con Sigmund Freud, non tanto per ribadire interpretazioni note, quanto per soffermarsi sul suo specifico modo di vestire e di comporre il suo guardaroba. Nella Vienna gerarchica e antisemita di fine Ottocento, Freud conosceva perfettamente il peso simbolico degli abiti; la sua attenzione quasi ossessiva rifletteva un desiderio di assimilazione che la storia avrebbe presto smentito. Per lui sessualità e inconscio erano centrali e, se la società non fosse stata maschilista e misogina, la moda si sarebbe probabilmente adagiata sul suo lettino, come accade in Fashion Neurosis, il podcast di Bella Freud, bisnipote di Freud e stilista, presente sia al symposium, in dialogo con Valerie Steele, sia in mostra con un completo azzurro “gender neutral”.
Il lascito di Freud apre alle successive interpretazioni del ruolo dell’abito nella costruzione e difesa dell’immagine di sé. Le sezioni dedicate agli anni Venti e Trenta mostrano come la psicoanalisi sia stata associata alla libertà personale di donne e di minoranze sessuali. Parallelamente, gli artisti surrealisti trovavano nelle teorie freudiane un repertorio iconografico inesauribile, come nelle cravatte dipinte di Salvador Dalí presenti in mostra. Le interpretazioni di Joan Riviere sulla femminilità come masquerade anticipano molte riflessioni successive sull'identità di genere.

Negli anni Cinquanta si assiste a un brusco cambio di tono: la disciplina psicoanalitica, soprattutto negli Stati Uniti, si irrigidisce con posizioni apertamente misogine e omofobe. Edmund Bergler, psicoanalista tristemente noto per la sua teoria di conversione dell’omosessualità, definì gli stilisti gay “i nemici più acerrimi delle donne”. È il momento di massima distanza tra maschile e femminile, come mostrano i completi maschili giacca-cravatta-pantaloni e gli abiti femminili con vita stretta e ampia gonna sotto il ginocchio. Abiti che oggi appaiono come dispositivi di controllo del corpo e della rappresentazione, rivelando quanto la moda partecipi alla costruzione delle norme di genere e quanto tali norme siano state interiorizzate, contestate e trasformate nel corso del secolo.
Che il genere sia prima di tutto una performance emerge con chiarezza nell’abito sirena di Thierry Mugler del 1989, in poliestere e lurex. Mugler utilizzò spesso modelle transgender e la sua visione iper-femminile risultò controversa. Judith Butler, com’è noto, interpreta la femminilità come mascheramento, e Mugler incarna questa idea in modo particolarmente eloquente.
Il cuore della mostra è lo spazio immersivo della sala espositiva principale, non organizzato cronologicamente, ma per temi, che esplora concetti quali lo stadio dello specchio, il corpo frammentato, il desiderio, il feticismo e la differenza sessuale. Accanto a Freud e Lacan, la mostra convoca Jung e Anzieu, le cui teorie permettono di leggere gli abiti come dispositivi psichici: sogno, desiderio, estensione del sé. L’abito diventa architettura del corpo, armatura, seconda pelle. Il celebre Safety pin Dress di Versace, indossato da Elizabeth Hurley nel 1994 accanto a Hugh Grant in smoking, mette in scena l’ambivalenza tra mostrare e nascondere. Un erotismo fondato sull’intermittenza dello sguardo: lo dimostra il clamore suscitato dal Green Plunge Dress di Versace, anche noto come Jungle Dress indossato da Jennifer Lopez nel 2000 che sembra sul punto di aprirsi per rivelare la nudità del corpo. Benché la nudità sia prevalente nell’abito femminile, ci sono segnali di cambiamento, come l’abito rosso di Haider indossato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia da Timothée Chalamet nel 2022. A sua volta, come si vede in mostra, l’abito è citazione di un completo maschile rosa del 1998, ad opera di Jean Paul Gaultier.
Sono poi molti gli ensemble che alludono al feticismo, come l’abito rosso fuoco della collezione Haute Couture (2000) di John Galliano per Dior, denominata appunto Freud or Fetish. La psicoanalisi classica tendeva a considerare il feticismo come tipicamente maschile, ma alcuni teorici contemporanei, come Elizabeth Grosz, suggeriscono che sia la struttura stessa del desiderio a essere di per sé feticista. Come ricorda anche la psicoanalista Susie Orbach, la sessualità umana è sempre costruita e mai semplicemente “naturale”.
L’esposizione prosegue con altre declinazioni: lo specchio e lo sguardo, l’oggetto del desiderio, la “donna fallica” esemplificata dal celebre reggiseno conico di Madonna firmato Jean Paul Gaultier nei primi anni Novanta. La moda come seconda pelle viene esplorata attraverso il concetto dell’Io-pelle di Didier Anzieu, ripreso nel symposium dall’intervento di Christine Anzieu Premmereur e ampiamente trattato nel libro: ciò che indossiamo può proteggere come un’armatura o esporre il corpo erotizzandolo. Un bustier di pelle rosso (1983) di Issey Miyake o un abito di Rei Kawakubo funzionano come architetture corporee. Come anche la psicoanalista Pascale Navarri ha osservato: “Ciò che l’apparenza della moda espone è, allo stesso tempo, la nostra vulnerabilità nell’essere visti e nel non essere visti.”
Le teorie del sogno di Freud e Jung fanno emergere significati inconsci di diversi stili. L’abito-cioccolato di Jeremy Scott per Moschino evoca il desiderio appagato nella logica freudiana, mentre Rick Owens, nella collezione Priestesses of Longing, richiama archetipi femminili di natura esoterica. La giacca a specchi di Schiaparelli, Hall of Mirrors (1938/1939) è accostata allo stadio dello specchio lacaniano; Steele suggerisce che Elsa Schiaparelli abbia utilizzato la moda per tentare di riparare un’immagine di sé segnata da un giudizio materno negativo; Eros e Thanatos, concetti chiave nell’analisi freudiana, emergono potentemente, per esempio, nell’abito Roses and Razors (2020) di Jun Takahashi per il marchio giapponese Undercover che combina rose e rasoi.
Le sezioni dedicate al desiderio e alla differenza sessuale interrogano anche la tradizione psicoanalitica che ha definito il corpo come “roccia di base”. Nonostante alcuni analisti ritengano che le persone transgender debbano “accettare la realtà”, Steele ricorda che né il corpo né il sé sono entità fisse. La moda amplia le forme di espressione dell’identità in modo affine alla concezione psicoanalitica del sé in trasformazione. Il cambiamento individuale si manifesta attraverso l’abbigliamento: per molti giovani contemporanei ciò comporta scelte stilistiche fluide o non binarie, segnando un vero cambiamento di paradigma negli atteggiamenti verso sessualità e genere. Il self-fashioning diventa così processo costitutivo dell’identità. Patricia Gherovici, psicoanalista lacaniana intervenuta al symposium con la relazione “Wrestling With Fashion: Arts of Wearing a Body”, ha affrontato questi temi da una prospettiva clinica e teorica.
Il volume Dress, Dreams & Desire. A History of Fashion and Psychoanalysis, a firma Valerie Steele, pubblicato da Bloomsbury, amplia e approfondisce i temi presenti in mostra, partendo da Freud e passando dal feticismo per arrivare alle questioni contemporanee sull’identità di genere. Non è il catalogo della mostra, ma un saggio teorico che si affianca ad essa, accostando Schiaparelli, McQueen,Versace e molti altri ai concetti psicoanalitici che illuminano le loro opere. Steele riprende le prime teorie psicologiche del vestire, come quelle di J.C. Flügel sulle zone erogene mutevoli, mettendone in luce limiti e pregi, come quello di aver relativizzato il concetto di modestia e dialoga con Lacan – che vestiva come un dandy eccentrico, diversamente da Freud – sulla ferita della soggettività scissa, mostrando continuità e scarti nelle interpretazioni del corpo vestito. L’autrice e curatrice sostiene che la diffusione della cultura psicoanalitica abbia influenzato non solo la cultura in generale, ma che abbia avuto anche un impatto sulle tendenze della moda, sui cambiamenti degli stili e sul modo in cui noi interpretiamo la moda.

Come storica, Steele si era già ispirata al libro di Peter Gay, Freud for Historians (1985), per capire come i concetti della psicoanalisi potessero aiutarla a interpretare la storia della moda femminile del diciannovesimo secolo. Infatti, ciò che era stato pubblicato fino a quel momento non era, a suo avviso, soddisfacente – come viene argomentato nell’Introduzione al volume, accennando ai più noti testi, quali The Language of Clothes di Alison Lurie (1981), a suo giudizio riduzionista, o al libro di James Laver, Costume and Fashion (1969), in cui le differenze tra uomini e donne in merito all’abito, erano basate su preconcetti più che su una ricerca originale.
Nel 2015 dopo una sua partecipazione a un convegno a Londra su psicoanalisi e moda organizzato dal Freud Museum insieme al London College of Fashion, Valerie Steele ha avuto modo di conoscere più da vicino il lavoro sulla costruzione del genere attraverso gli abiti da parte di psicoanalisti appartenenti alle nuove generazioni, più interessate alla moda, anche personalmente, e meno condizionate dai bias del passato. Da lì è partito il progetto di dedicare un’intera ricerca al rapporto tra moda e psicoanalisi che è diventato poi una mostra, un symposium (14 novembre 2025) – cui hanno partecipato tra gli altri, alcune dei terapeuti presenti a Londra, come è il caso di Anouchka Grose – e, appunto, un libro.
La caratteristica principale dei fashion studies, branca che si è affermata nel mondo anglosassone e poi anche in Italia, soltanto da pochi decenni, è l’interdisciplinarietà: sociologia, storia, storia dell’arte, antropologia, psicologia sono alla base di diverse analisi sulla moda. Principalmente, tuttavia, sono stati gli strumenti socioculturali a dominare il campo. Ora un altro fondamentale strumento, la psicoanalisi, si è aggiunto allo studio e alle ricerche intorno alle evidenti espressioni del genere umano, quali moda e modi di organizzare e trattare il corpo.
Il libro di Valerie Steele, al momento disponibile soltanto in lingua inglese, è composto di otto capitoli, oltre all’Introduzione: La moda come superficie profonda; 1: Freud e la moda; 2: Il sognatore nudo; 3: La mascherata; 4: Lo specchio e il corpo frammentato; 5: Nemici giurati; 6: Desiderio e differenza sessuale; 7: Toccare lo sguardo; 8: Corpi da indossare (mia trad.).
In particolare, nel sesto capitolo, Desire and Sexual Difference, alla luce di teorie lacaniane, vengono analizzate sia alcune specifiche collezioni e alcuni stilisti, sia opere di artiste come Vanessa Beecroft e Sylvie Fleury, accomunati dal tema del desiderio e della mercificazione del corpo femminile: per le donne, l’esperienza della moda, scrive Steele può richiamare il feticismo e il narcisismo intesi come autostima e piacere nell’atto della vestizione.
Un’interessante analisi dei miti cari alla psicoanalisi, quali Narciso e Medusa sono l’oggetto del capitolo To Touch the Gaze, in cui viene trattato un tema forse un po’ sottovalutato dagli studiosi di moda e cioè l’aspetto protettivo dell’abito. Riferendosi alle teorie di Didier Anzieu, secondo il quale se l’Io-pelle di un individuo non è abbastanza forte o flessibile, risulta evidente come la più lieve ferita narcisistica possa provocare un danno grave: in questo senso gli abiti armatura di Yohji Yamamoto, a dire dello stesso designer, come anche quelli di Comme des Garçons rispondono al desiderio, se non alla necessità, di proteggere chi li indossa da sguardi sgraditi, fino all’impressionante, enorme abito a punte acuminate, esposto in mostra, di Viktor & Rolf per la collezione Haute Couture dell’autunno-inverno 2020.
In definitiva, il libro e la mostra rivelano come l’abito non sia mai un semplice oggetto, bensì un dispositivo di soggettivazione attraverso cui ciascuno di noi narra, reinventa e negozia la propria identità. Le testimonianze e le teorie presentate, fino alle interpretazioni deleuziane del corpo che “si accoppia” con i vestiti, mostrano che la moda agisce come una forma di artificio capace di dare corpo ai nostri desideri e alle nostre mancanze. Se la psicoanalisi ci ha insegnato che non siamo mai identità compiute, ma processi in divenire, la moda rende visibile e vivibile questo divenire, trasformando il corpo in una costruzione sempre aperta. La loro intersezione, conclude Steele, ci fa comprendere che la nostra relazione con l’abito è, come la vita psichica, un esercizio continuo di trasformazione: una pratica estetica ed etica che illumina l’arte, fragile e potente, di diventare sé stessi.
Nel complesso, il progetto testimonia la capacità del Museum at FIT e di Valerie Steele di proporre nuove chiavi interpretative per comprendere la moda come pratica culturale fondamentale della modernità e della contemporaneità. Non offre risposte definitive, ma invita a riconoscere nel vestire una forma di interrogazione continua: un dialogo ininterrotto tra ciò che sappiamo di noi e ciò che ancora ci sfugge.
The Museum at FIT, New York “Dress, Dreams & Desire. A History of Fashion and Psychoanalysis”, dal 10 settembre 2025 al 4 gennaio 2026, a cura di Valerie Steele.
Valerie Steele (2025), Dress, Dreams & Desire. A History of Fashion and Psychoanalysis, Bloomsbury Visual Arts, London, New York, Oxford, Delhi, Sidney.