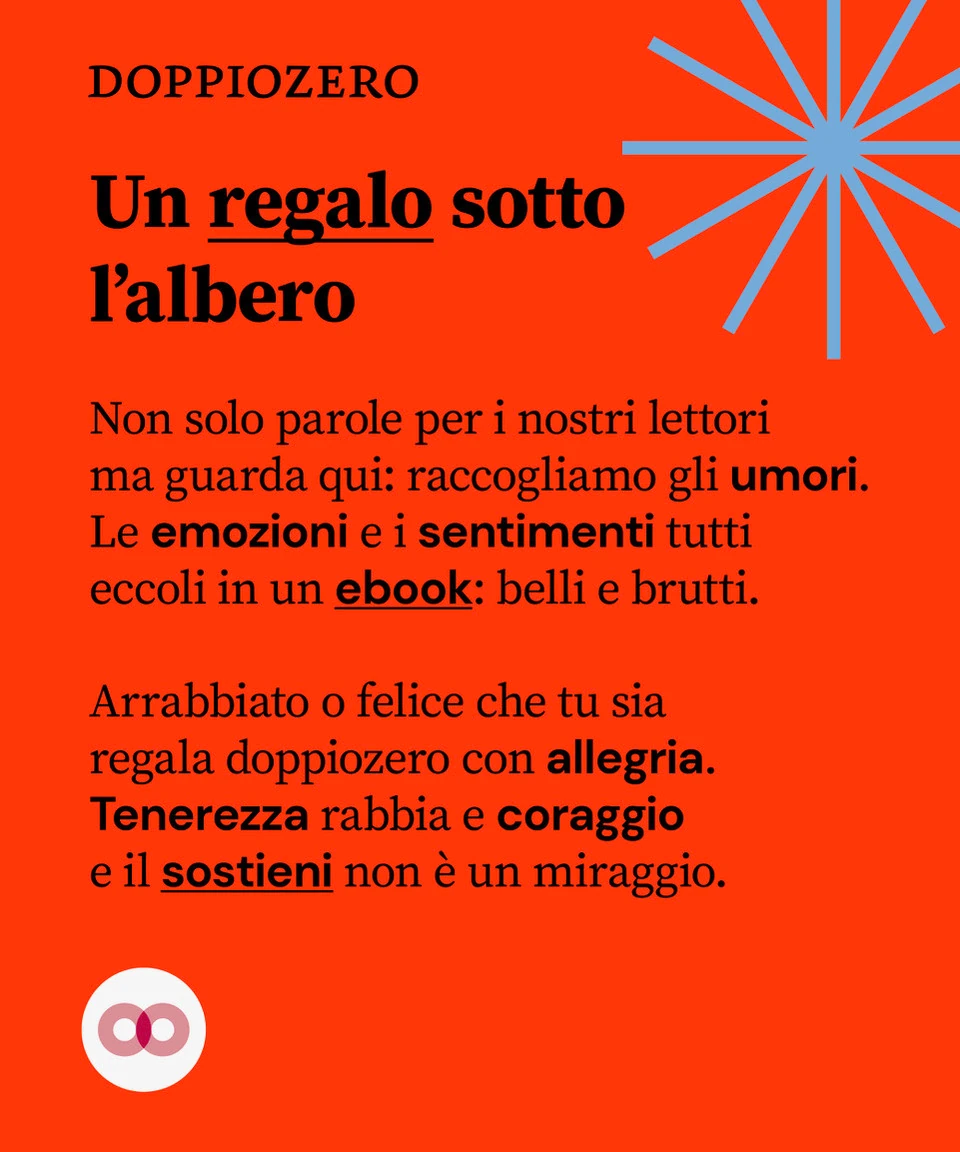Il fanciullino si è fermato a Piramide
Biblioteca comunale, quartiere Testaccio, viscere di Roma. Il richiamo dello stomaco è un’ottima occasione per una pausa. Mentre salgo i gradini che conducono a un piccolo spiazzo con la vista della Piramide in lontananza assisto a una scena curiosa. Una signora anziana in lontananza, rincorsa da voci di ragazzini che urlano: “Aho, è venuto bene er colore?”, in riferimento all’eccentrica chioma sfavillante della suddetta. Le voci provengono dal secondo piano della biblioteca, in cui ha sede una scuola elementare. Seguono delle avances pepate a delle ragazze che si recano in biblioteca e che, ad occhio, devono avere una ventina d’anni più dei bambini. Ragazzate penso, mentre comincio a gustare la merendina. Trovandomi nella zona rossa appena valicata dalla signora e dalle ragazze, divento facile bersaglio dei bambini che cacciano un urlo e si nascondono dietro la serranda. Passano pochi secondi e parte il primo “occhialuto!” che, come i successivi, entra ed esce dalle mie orecchie. “Occhialuto!”, “A’ occhialuto”, “ma che te magni, ‘na merendina?”. Siamo su un piano fenomenologico, quello di un essere umano dotato di occhiali impegnato a nutrirsi.
Tuttavia la mia totale, disarmante disattenzione (non mi sforzo neppure di alzare lo sguardo affinché possano giocare a tirar dentro la testa) viene presa dai bambini per una sfida bella e buona. Di tutto punto alzano il tiro: “st***zo!”, “a’ st***zo!” e persino un più minaccioso “che c***o fai, mo’ scenno e t’ammazzo de botte”. Le altre varianti intonano gli stessi accordi, eccetto una, la più curiosa, in cui il vocativo dell’apostrofe si trasforma in una concisa domanda: “St***zo?”. Non mi era mai stata posta una domanda in questi termini. Se l’esclamazione è facile da ignorare, ora mi sento interpellato, indotto a rispondere, ad alzare la testa, a negare, a mettere in mezzo le loro sorelle. Non reagire equivale a un dimesso “sì, lo sono”. Ma insomma che fai, ti metti a discutere con dei bambini di otto anni? Sarebbe ridicolo. E poi questo è il periodo meraviglioso in cui si scoprono le parolacce, e si declamano dalle finestre come poesie d’amore dedicate ai passanti. Dovrei sentirmi onorato di cotanta premura.
Prevale così il Wu wei, il Non-agire: ecco qui, penso, una buona occasione per mettere in pratica gli insegnamenti del Tao Te Ching. “A’ st***zo” – Wu wei – “A’ cojone” – Wu wei – “Mo t’ammazzo” – Wu wei – “Mo’ scenno e t’ammazzo de’ botte” – Wu wei. Una pausa inusuale, non c’è che dire, sospesa tra un richiamo pseudo-gandhiano alla pace universale e una minaccia di morte per imprecisate ragioni (ridurmi in fin di vita per un paio di occhiali mi sembra pretestuoso).
Continuano a piovere parolacce con una scalata vertiginosa, mentre la mia indifferenza taoista indispone ancor più i bambini, ora inferociti come non mai. Con questo ci vogliono le maniere forti. Non voglio virgolettare le loro espressioni ma il concetto è, in sostanza, che un paio di questi bambini di anni 8 (otto) si mettono in testa di fare sesso con mia mamma, non senza l’accortezza di coprirle il volto con una busta di plastica. Dubito fortemente che i miei giovani amici facciano riferimento al celebre quadro di Magritte conservato al MoMA in cui due amanti si scambiano un freddo bacio avvolti in un velo che sembra di pietra.

***! – Wu wei – ***! – Wu wei – ***! Wu wei?! No, aspetta un attimo, ma quale Wu wei, questi hanno passato il segno, altro che “piano fenomenologico”.
Mi precipito all’ingresso della scuola per denunciare il turpiloquio subito. La porta è chiusa a chiave come la gabbia di uno zoo. In tutta tranquillità arriva una signora che casca dalle nuvole, non ha sentito un’acca nonostante urlino a squarciagola. Ad ogni modo mi è andata bene, la volta scorsa hanno lanciato dalla finestra libri e matite. Insomma ho rischiato la lapidazione per un paio di occhiali. A volte viene voglia di prenderli a calci negli stinchi, si lascia scappare la signora cercando la mia approvazione. Ma la violenza non attirava solo altra violenza? Ecco che mi invita a salire con lei nella scellerata classe. Io resisto, non voglio processare nessuno né discutere con quattro Franti sfigati invitandoli a vergognarsi. La mia voleva essere solo una segnalazione. “Non si preoccupi, venga con me, parlo io, su”, incalza la signora tenendomi stretto per il braccio come se fosse colpa mia. Saliamo.
C’è una sola porta aperta: dentro regna un silenzio assoluto, la classe pende dalle parole del maestro. Davanti a me solo bambine, bellissime, ben vestite, pettinate; mentre la signora riferisce l’accaduto mi fissano con i loro occhioni incuriositi. Erano delle voci maschili o femminili?, domanda la più vispa, perché in questa classe, precisa, ci sono solo tre bambini, e me li indica con la matita temperata. Seguono tre primi piani di facce docili e assopite, come lo sono quelle di chi vive nei matriarcati. È ovvio che abbiamo sbagliato classe, così ovvio che l’unica a non accorgersene è la signora, che continua imperterrita a riportare la mia storia disgraziata tra l’incredulità generale.
Lascio la scuola esitante. Provo con la lettura sociale: il disagio di questi bambini disadattati, la situazione familiare disastrata per esprimersi così rozzamente. Provo con il relativismo: un atto di goliardia, il grido inarticolato e liberatorio, un carnevale della parola, una messinscena dell’Es. Provo con la sociologia spiccia: la televisione ha colonizzato l’inconscio ed espropriato l’immaginazione di tutti, soprattutto delle fasce più esposte come i bambini e gli anziani. Provo con la politica: lo Zeitgeist di una Roma governata da un ex fascista o di un’Italia in cui i parlamentari alzano il dito medio per rispondere a una domanda come in un concerto metal. Provo con la compassione verso l’insegnante che si sveglia ogni mattina con il peso sullo stomaco all’idea di dover gestire un classe del genere.
Finché mi aggrappo a una lettura marxista: i bambini di Testaccio non fanno altro che articolare il “hé, vous, là-bas!” (“Ehi! Lei, laggiù!”) di Althusser, ovvero l’interpellation, l’essere apostrofati, l’ingiunzione propria dell’ideologia. Se l’ideologia è quella macchina implacabile e pervasiva che trasforma l’individuo concreto in soggetto, che lo convoca e lo costituisce socialmente in quanto tale, l’interpellation ne è lo strumento più efficace. La polizia apostrofa un passante rivolto di spalle, anonimo e senza volto con un “hé, vous, là-bas!”. Questi si rigira, convinto che quella che suona già come un’intimazione sia indirizzata a lui (“dice proprio a me”). Rigirandosi di 180 gradi, l’individuo nasce in quanto soggetto. Prima di questa rotazione fisica c’è solo un essere al di fuori d’ogni sistema di regole ma anche senza storia, eccentrico persino a se stesso. Solo l’appello gli dona esistenza, solo con la sua risposta quasi irriflessa – “Ma chi, io?” – quell’io nasce a se stesso.
Girarsi a un appello verbale o a un colpo di fischietto, alla voce pubblica, a una sirena, a uno “stronzo?!” nella fattispecie, vuol dire essere assoggettati. Soggetti a prima che soggetti di. “Ehi! Lei, laggiù!” – o le varianti impudiche dei fanciullini di Testaccio, dall’occhialuto in giù – sono dei richiami individuali che, puntando contro l’indice, ritagliano il singolo dal contesto urbano anonimo e gli assegnano un ruolo nella sfera sociale. Che questo richiamo dell’ideologia passi oggi attraverso chi, come i bambini, a questa macchina ideologica dovrebbe essere ancora immune, ecco un salto che Althusser non aveva contemplato scrivendo nel suo appartamento all’Ecole Normale.
Che queste riflessioni siano sensate o meno, poco importa: il problema, tutto mio, resta in piedi, perché non mi era mai capitato di essere ricoperto di così tante parolacce. E in casi come questi il Taoismo o Althusser valgono quanto gli ombrelli a dieci euro all’uscita della metro.