Speciale
Szymborska. Lo chiamiamo granello di sabbia
È il primo verso di una poesia di Wislawa Szymborska. Il verso che segue completa la rappresentazione in modo inatteso: “Ma lui non chiama sé stesso né granello né sabbia”. Il titolo della poesia è Vista con granello di sabbia, e appartiene alla raccolta Gente sul ponte, del 1986: la sola raccolta che era stata pubblicata in Italia, da Scheiwiller, nel 1991, nella traduzione di Pietro Marchesani, prima che la poetessa polacca ricevesse il Nobel, il che accadde nell’anno 1996. Marchesani avrebbe poi tradotto, con grande cura ed eleganza, e interpretato in più occasioni, tutte le stazioni del cammino poetico della Szymborska. Ecco, dunque, le prime strofe della poesia (cito i versi nella traduzione italiana):
Lo chiamiamo granello di sabbia.
Ma lui non chiama sé stesso né granello né sabbia.
Fa a meno di un nome
generale, individuale,
permanente, temporaneo,
scorretto o corretto.
Del nostro sguardo e tocco non gli importa.
Non si sente guardato e toccato.
E che sia caduto sul davanzale
è solo un’avventura nostra, non sua.
Per lui è come cadere su una cosa qualunque,
senza la certezza di essere già caduto
o di cadere ancora.
L’avventura del granello di sabbia appartiene a noi, perché siamo noi a dare un nome al granello: osservarlo, o toccarlo, seguirne il movimento, vederlo posare è un accadimento che è solo nel cerchio del nostro vedere, e giunge alla nostra lingua perché siamo noi ad avere una lingua. Il lettore dinanzi a questi versi sente che le immagini si mostrano da subito come avvolte da un loro alone riflessivo, da una domanda. Ed è poi questo un nucleo evidente della poetica della Szymborska: mostrare, insieme con l’immagine, il cerchio di pensiero con il quale il poeta accompagna quella stessa immagine. E quel pensiero che germina dall’immagine è a sua volta detto con l’ironia di chi non vuol dare al pensiero l’esclusiva nell’atto del conoscere. Qui, da subito, l’apparire dell’oggetto, figura per eccellenza del minuscolo, dell’appena percepibile, dell’insignificante, è puro nome, nome dato dagli uomini, dalla lingua degli uomini. La biblica nominazione creaturale (Genesi, 2, 20-21) non è evocata direttamente, ma fa da sfondo a questa separazione dell’oggetto dal suo nome: il granello, il suo apparire alla vista, il suo movimento, la sua collocazione nell’ordine del visibile, è momento della nostra conoscenza, ma non si inscrive nel sapere del granello, il quale è privo di ogni possibilità di sapere, è granello solo perché noi lo diciamo granello. E tuttavia nel momento in cui il dire della poesia separa il granello di sabbia dal nome, finisce con il partecipare egualmente, sebbene in negativo, alla vita del granello: “per lui è come cadere…”, dice il poeta, attribuendogli un’azione, o la somiglianza con un’azione. Perché altro dominio non ha la poesia se non il nome, e con il nome l’immaginare la vita di ogni cosa. E comunque l’esperienza della separazione tra il nome e la cosa, tra il nostro vedere e la vita della cosa, non è confinabile al granello, riguarda tutto quello che appare ai nostri occhi:
Dalla finestra c’è una bella vista sul lago,
ma quella vista, lei, non si vede.
Senza colore e senza forma,
senza voce, senza odore e senza dolore
è il suo stare in questo mondo.
I versi accentuano, via via, questo puro esser cosa della cosa, e la sua separazione dai sensi dell’uomo, dalla vita dei sensi. I versi si succedono allargando la descrizione: il fondo del lago non ha un fondo, le sponde non sanno di essere sponde, l’acqua non conosce il bagnato e neppure l’asciutto, le onde non sanno del loro mormorio, e neppure di essere le onde al plurale o l’onda al singolare. Via via si dilata la scena dell’apparire, quasi convocando tutti gli elementi di una creazione che l’uomo ha consegnato alla sua propria lingua, o in essa imprigionato. Il cielo, il sole, il vento, la nuvola sono anch’essi nel nome, non sanno della loro condizione, né della loro essenza. La descrizione giunge, infine, a nominare il tempo, che è anch’esso, nella sua scansione, tutto nostro. Ma c’è un’ultima parola che, dopo l’ironia, porta lo sguardo, e il pensiero, al di fuori della separazione tra il nome e la cosa:
Il tempo passò come un messo con una notizia urgente.
Ma è soltanto un paragone nostro.
Inventato il personaggio, fittizia la fretta,
e la notizia inumana.
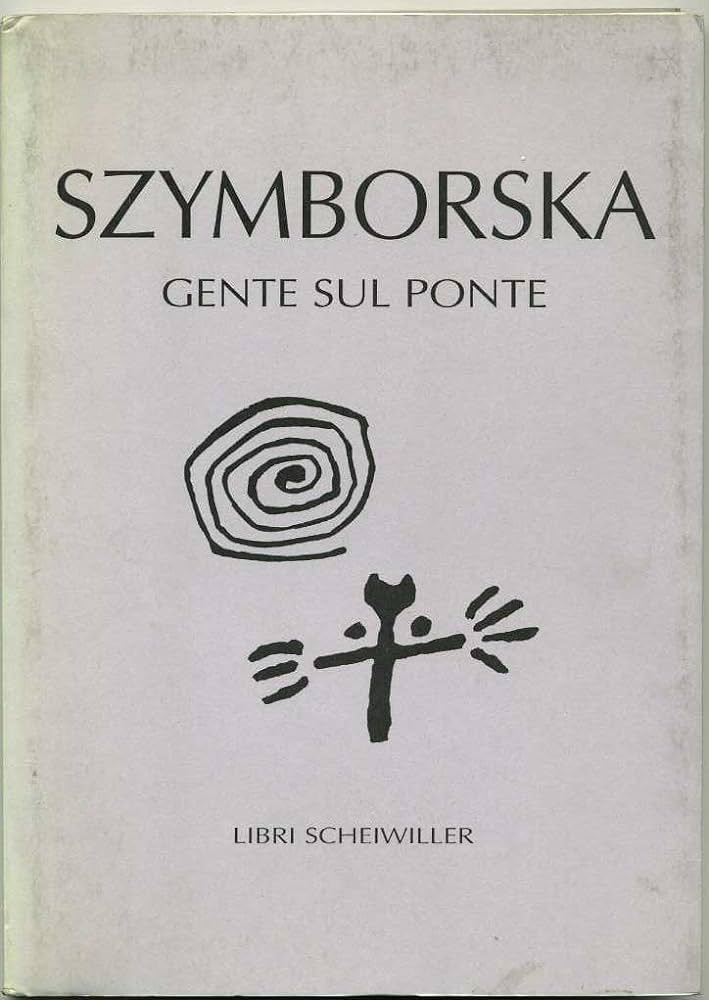
La notizia che il tempo porta è “inumana” (nieludzka). Dal tempo giunge qualcosa che sconvolge e fa deflagrare la quiete della distinzione tra il nome e la cosa: è il tragico della notizia che il passaggio del tempo, in quanto tale, porta con sé. La distinzione tra il nome e la cosa è rinviata nella regione dell’artificio.
Questa della chiusa che è in scarto con l’intero testo e in qualche modo lo illumina dalla fine, è frequente nella poesia della Szymborska. Un solo esempio. Nella poesia Il cielo (della raccolta La fine e l’inizio, 1993) si dice della artificiosità della distinzione tra la terra e il cielo, perché dappertutto è cielo; quella distinzione, dice la voce dell’io messo in scena, serve solo per “sopravvivere /a un indirizzo più esatto, / più facile da trovare, / se dovessero cercarmi”. Ed ecco gli ultimi due versi che nominano i segni utili in quella ricerca: “Miei segni particolari: / incanto e disperazione”.
Dalla raccolta Per questo viviamo del 1952 al volume Qui, del 2009, la poesia della Szymborska ha declinato, con forme insieme ironiche e pensose, leggere e interrogative, discrete e teatrali,
una fenomenologia del quotidiano, dinanzi al cui mostrarsi la poesia si sporge con una sua particolare curiosità e compassione. Perché è la singolarità, la prossimità al suo respiro, che la poesia cerca di accogliere nella lingua. Consapevole della inanità e fuggevolezza del nome. Consapevole, anche, del vuoto di ogni invocazione. Ecco alcuni versi della poesia Il silenzio delle piante (Attimo, 2002):
Cespugli, boschetti, prati e giuncheti –
Tutto ciò che vi dico è un monologo
E non siete voi che lo ascoltate.
Muovendo da due grandi esperienze poetiche di lingua polacca, diverse tra di loro, quelle di Milosz e di Herbert, la poesia della Szymborska accoglie via via in un dire piano, colloquiale, ma anche ragionativo e ironico, gesti, voci e figure che appartengono all’esistenza “comune”: un apparire del visibile deprivato di ogni traccia di sublime. E tuttavia il lettore avverte che dietro il calembour o l’umorismo o il paradosso, prende forma una sorta di metafisica del minimo, e una commozione dinanzi all’irripetibile singolarità di tutto ciò che sta tra di noi, con noi. Se tracce di stupore resistono, esse hanno come fonte il “miracolo alla buona” del vivere quotidiano.







