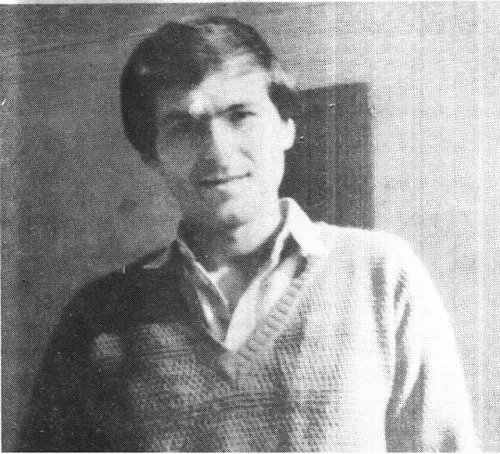Gli esordi ritrovati di Milo De Angelis
Con la pubblicazione di Poesie dell’inizio 1967-1973 (Lo Specchio, Mondadori 2025), Milo De Angelis compie un atto di svelamento della primissima fase della sua vita poetica, consegnandoci oggi la sua voce di poeta adolescente. Una voce in formazione, ma già riconoscibile per chi ha in mente i versi di Somiglianze, il fondamentale libro di esordio del 1976, di cui queste poesie sono un incubatore in anni cruciali: «fu allora che iniziai a scrivere seriamente in versi, e ad avvertire la pretesa (pretesa di completezza, appunto, e dunque appaiata a un turbamento) di far sì che il lettore non sentisse gratuita una successione. Era difficile e necessario…» (M. De Angelis, Colloqui sulla poesia, Book Time, 2013, p.28).
Versi che l’autore credeva perduti e che, grazie al ritrovamento da parte dell’amico e maestro Angelo Lumelli, ha scelto tra i numerosi fogli ricomparsi e poi raccolto nelle 51 poesie che compongono il libro. «Ho rispettato per filo e per segno il testo originale senza cambiare una virgola – in certi casi con qualche sforzo…» dichiarava l’autore nella raccolta di Tutte le poesie (Mondadori, 2017) in cui era già contenuta una parte di questi testi giovanili, come a volerne sottolineare il carattere di apprendistato ma anche la volontà di un’aperta condivisione.
Leggere oggi le Poesie dell’inizio significa disporsi a osservare il mondo e, insieme a quel giovane, tentare di decodificarlo, di imparare. Poesie dell’apprendimento, si potrebbe dire interpretando il titolo di un testo che compare in due versioni, tanto ha richiesto quello scritto nella ricerca della sua direzione più precisa: L’apprendimento del dolore sembra essere il filo che conduce il discorso del poeta in divenire. Scrive Luigi Tassoni, nell’introduzione, di come De Angelis gli abbia confidato che proprio questo «sarebbe stato il titolo perfetto per il libro, se Gadda prima di lui non ne avesse reso già magistrale la connotazione». Dolore che per il giovane poeta sorgeva dal contrasto frontale tra l’attesa di futuro e lo spalancarsi della realtà della morte, tra l’aspettativa di vita e il riconoscimento agghiacciato del nulla. «Un maestro che chiami: uscire con lui / dal recinto aperto, vivere sempre. / Non c’è. / (…) / “alcuni, da grandi, / sapranno che c’è il nulla / e piangeranno”. / … l’evento insuperabile / che devasta già ora, se / veramente / il non ancora che ci spaventa / è dentro la vita, anticipato / con paura, sta entrando, ecco, è presente / non voglio…».
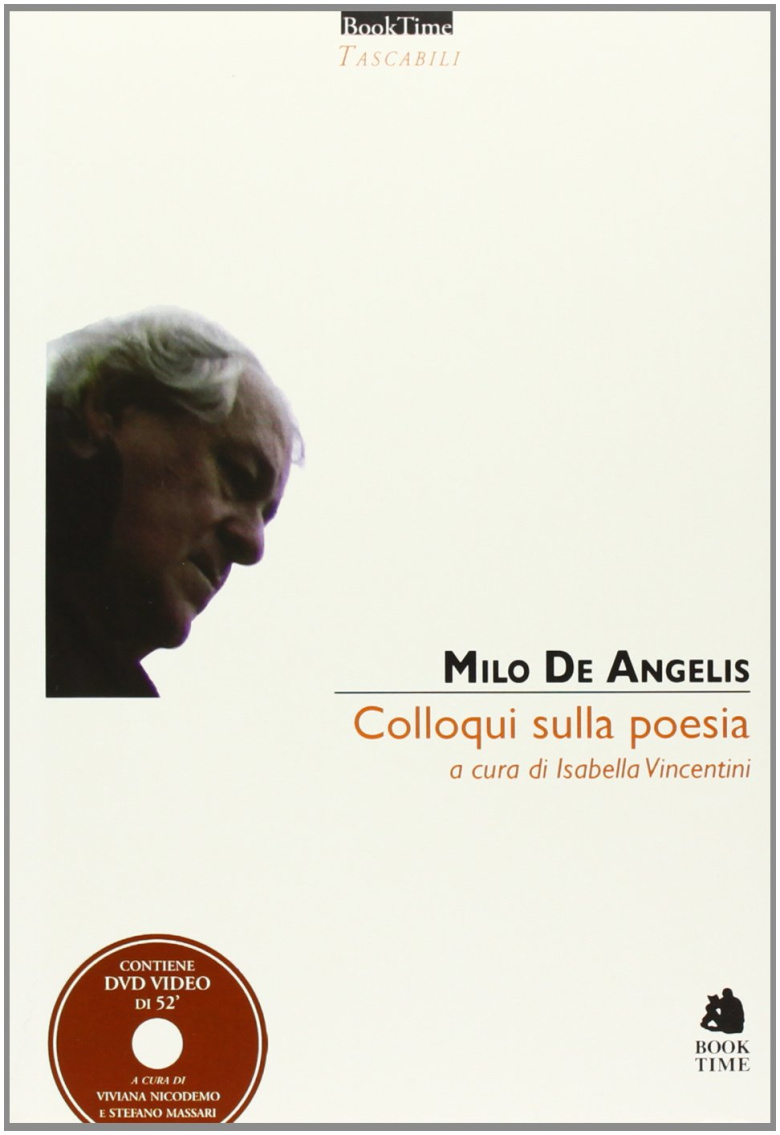
Il carattere tragico della poesia di De Angelis scaturisce sin dalle origini da contrasti ineludibili e qui già riconoscibili. Nello sguardo stupefatto e ingenuo che permea queste pagine si scorge, allo stesso tempo, anche la capacità sottile di decifrare il lato in ombra delle cose: sarà proprio la gioia a svelare che la vita non è gioia, è il «sapersi progetto interminabile» ciò che apre la contesa con «l’idea della fine», è qui che si inizia a riconoscere che «questa assoluta / importanza della vita / fa che niente sia essenziale» (Intervallo e fine).
Allora, come oggi, scriverne era il varco necessario oltre il quale l’affaccio nella vita che dovrà farsi adulta trova la sua catarsi: il foglio bianco – lì davanti – è una via d’uscita e allo stesso tempo l’ingresso in un perimetro nel quale dare forma, ordine, contenimento alla battaglia che si agita dentro un adolescente. Quello che tra i banchi era l’appuntamento atteso con il tema, nell’adolescenza si traduce nella trepidazione per l’incontro destinale con la scrittura che si fa tutt’uno con la vita, è il percorso obbligato, l’unico in grado di opporre «un trasalimento di rime contro il nulla» come verrà scritto qualche decennio più tardi in Linea intera, linea spezzata. «Quel foglio (…) era davvero una porta. Bisognava varcarla per entrare nella vita autentica» (id. Tutte le poesie 1969-2015, Mondadori, 2017, p.411).
Qui si segna «l’inizio», bisognava «in-ire», entrare dentro la vita, come significativamente il titolo del libro indica, restituendo tutta la sua carica di tensione e movimento. Ed entrare nella vita è entrare compiutamente nella parola perché si faccia sempre più esatta, è «un cammino iniziatico, una sorgente da cui si diramano i ruscelli delle singole parole» spiega l’autore in una bella recente intervista a Fahrenheit. Inizio, inoltre, come fuoriuscita dal silenzio che caratterizzava il Milo dell’infanzia ma che è anche l’altro volto della poesia, il suo complemento essenziale.
Una tensione e un movimento che spingevano il giovane poeta a cercare i suoi simili, le somiglianze appunto, per costruire il proprio orizzonte di riferimento distinto dalla via dello sperimentalismo e dello storicismo a cui Milo reagiva con la ricerca di una terza via, in un percorso autonomo e condiviso. Iniziano infatti in quegli anni le letture collettive del proprio lavoro, lo stesso Lumelli lo ricorda nella postfazione, gli incontri fondanti con maestri d’eccezione come Bigongiari, Luzi, Fortini. L’indimenticabile Pavese. La scoperta di poeti allora poco diffusi come Cvetaeva, Benn, Leśmian, Celan. La sintonia con Lucrezio, nata sui banchi di scuola e culminata nella magistrale traduzione del De Rerum Natura nel 2022, autore amato «per la capacità di addentrarsi nei chiaroscuri dell’anima, di esplorare le zone più buie, inospitali, disabitate, vertiginose dell’esperienza umana» (Id. De Rerum Natura di Lucrezio, Mondadori, 2022, p. XI), scrive Milo mentre sembra che parli di sé stesso. È questo il terreno in cui si addentra il giovane De Angelis e da cui sgorgano questi suoi primi testi.
Se proviamo a comprendere in un unico sguardo l’opera dell’autore, si osserva che la scelta di comporre oggi, a ritroso, la raccolta Poesie dell’inizio ribadisce la volontà, la necessità e anche la scelta di metodo di tenere viva e trasparente la comunicazione con i lettori, la stessa tensione che – nonostante l’oscurità di alcune opere meno recenti – tutti i libri di Milo hanno indicato. Quel «voglio solo parlarvi» esplicitato pochi anni dopo in Poesia e destino (1982) corre nelle opere seguenti fino a Linea intera, linea spezzata (2021,) in cui il verso lungo, prosastico, esposto manifesta la ricerca di una lingua in grado di tenere vivo oggi il colloquio tra chi scrive e chi legge. In questo senso anche le recenti traduzioni di Lucrezio e di I fiori del male di Baudelaire concorrono ad alimentare questo flusso di comunicazione poetica.
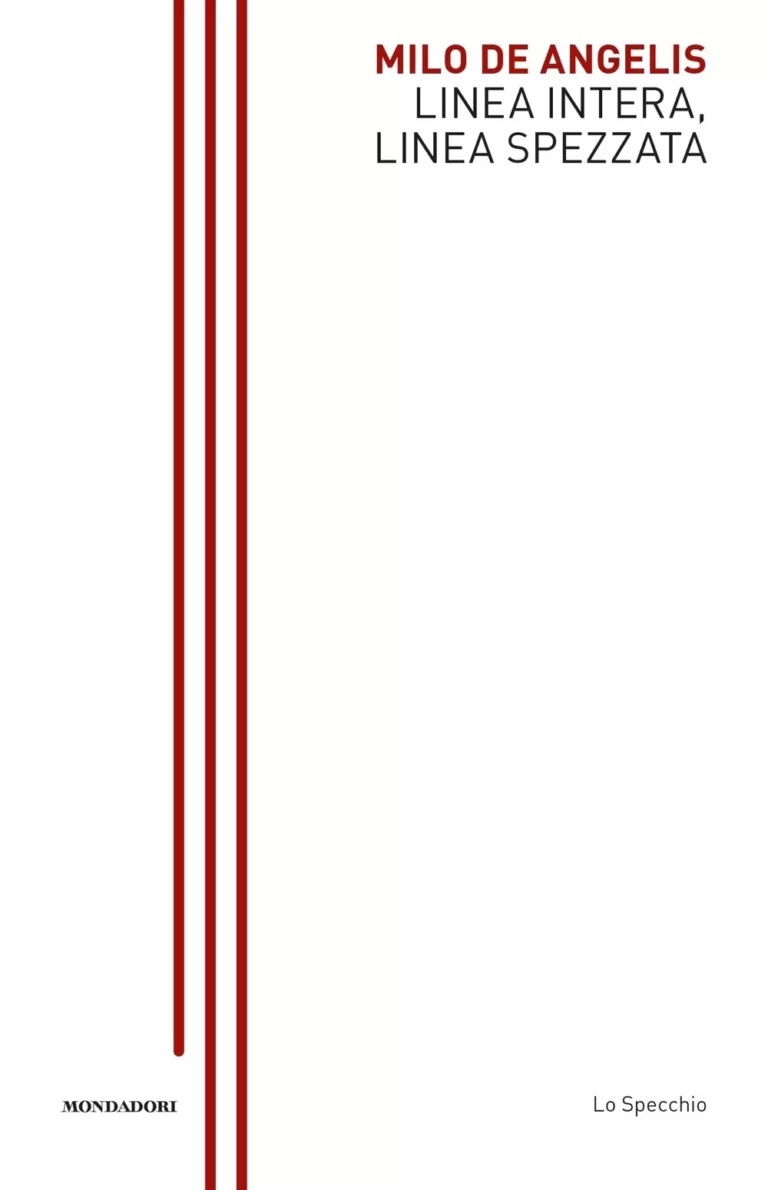
Ecco allora che qui, dall’origine, vengono scelte per i lettori proprio le parole più urgenti e già gravide del futuro percorso, come embrioni in formazione, prima della nascita di Somiglianze, prima dell’affermazione del proprio nome che – con la forza assertiva di un battesimo – troverà la sua piena espressione in Millimetri, qualche anno più tardi: morte, nulla, paura, ritorno, corpo, grido, amore. Le prime indimenticabili figure femminili, i campi sportivi, i pioppeti. La vena riconoscibile nel futuro dell’opera.
Con Poesie dell’inizio si ritorna dunque a scuola, ma si comprende subito che questa sconfina oltre le sue mura e i palpiti della Canzoncina per una bella ala sinistra. L’impatto con «quelle vorticose onde del sangue» che «una bella, una vera ragazza nella squadra avversaria» suscita nell’Istituto Gonzaga, travalica l’incontro con il femminile e le sue promesse. Era l’attesa e la paura, «era le minacce dell’ignoto, era il vuoto che irrompeva nel cortile gesuita, era la vita!».
Era la vita nel momento in cui si spalanca nelle sue possibilità e allo stesso tempo nella contraddizione: l’adolescenza, con la sua sete e il suo acume, intuisce che la vita, tra il richiamo dei corpi e la perdita dell’infanzia, la coscienza della morte e la possibilità di sceglierla, è imprendibile.
È così per Alain, il protagonista di Fuoco fatuo, magnifico film di Malle tratto dal romanzo di Drieu La Rochelle, che parla in Il gesto più esatto e che compare qui per la prima volta nell’immaginario poetico di Milo De Angelis, una figura che sotto altri volti continuerà a essere presente nell’intera opera. L’interesse per il cinema, che origina proprio nell’adolescenza, avrà un’influenza profonda nella formazione dell’autore, con le proiezioni mattutine seguite saltando la scuola – «via Torino, cinema Centrale: questa settimana / è la terza mattina» –, la frequentazione di tutte le sale milanesi dell’epoca di cui ancora oggi Milo ricorda i nomi in ordine alfabetico. L’attenzione all’immagine nella sua diacronicità così come nell’istante incandescente del singolo fotogramma, costituirà dunque un substrato fondante della vocazione visionaria del poeta.
Nella figura di Alain si incarnano la possibilità di incontro e, al contempo, di siderale distanza dalle cose «in un territorio / dopo le parole ma prima dell’azione», tra dolore ammutolito e la scelta del «igesto più esatto»: «ascolta Solange, tu capisci tu sei vita; ascolta, vita, / non si può toccarti / e tenterò con la fine: si lascerà fare».

La morte come atto definitivo e volontario, animato paradossalmente da una determinazione vitale e assoluta, sciolta dal suo legame con le cose, sarà un tema ricorrente in De Angelis, a cui egli oppone fin da questi primi versi la forza uguale e contraria della vertigine della vita, della paura di scomparire, del desiderio d’amore. Il rischio da accettare è netto: «in questo odore d’erba / non c’è che restare» (Gli accampamenti vicino al treno).
Restare, con la consapevolezza che l’uscita dall’infanzia è segnata dalla perdita, dal momento nel quale «hai capito che la tua vita è inutile» (Dipendevi da quello a cui non servi): dissolto l’appiglio della religione, appresa la coscienza del limite, del finito, della povertà dell’umano costretto nella sua «agonia razionale», il giovane poeta si impegna a limare la propria sintassi come il necessario approdo verso un punto fermo: «cercherò frasi che ti salvano / dirò che ti amo» (Starò con te). Al di là della perdita, c’è dunque una conquista possibile: tra il dolore e la gioia sfuggente dei corpi, esiste la parola, un luogo terrestre e sublime che può risanare, come verrà compiutamente detto molti anni dopo. L’opera di Milo De Angelis ha espresso questo, ora lo sappiamo, dalle origini a oggi, attraversando anche i libri più impervi, perché anch’essi sono stati scritti, la parola anche lì ha valicato ogni sbarramento, ha affrontato «la paura, dovunque» (È anche tra le cabine vecchie) nominandola.
In questo ventaglio di temi e intuizioni, Poesie dell’inizio si offre dunque ai lettori come un viatico necessario per meglio addentrarsi nell’opera di un autore che in tutti questi anni ha coltivato e difeso con determinata coerenza quel nucleo originario, quella visione poetica che ancora oggi ci parla.
Leggi anche:
Corrado Benigni | Milo De Angelis: il nuovo De Rerum Natura
Gianni Montieri | Milo De Angelis: Linea intera, linea spezzata
Corrado Benigni | Il silenzio. Intervista con Milo De Angelis
Umberto Fiori | Milo De Angelis. Qualcosa di urgente