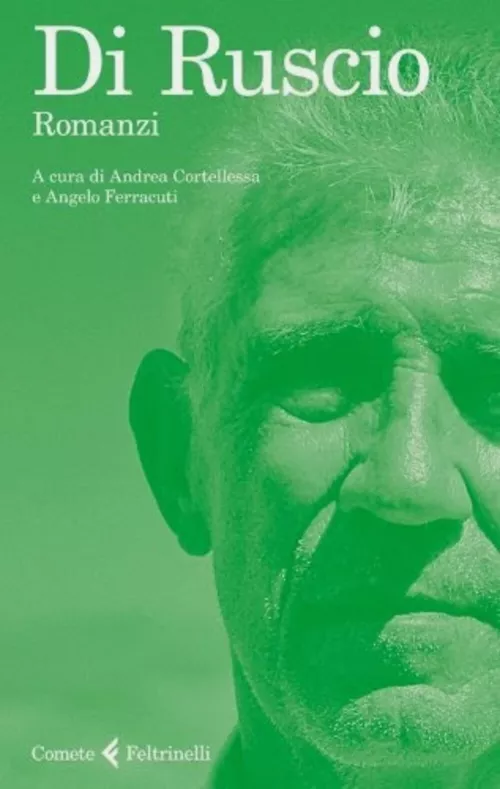Luigi Di Ruscio. Romanzi
La mattina del primo aprile 1969, Italo Calvino era negli uffici Einaudi. Nei giorni precedenti aveva letto un romanzo inedito, intitolato Il verbalizzatore. L'autore trentanovenne aveva alle spalle alcune pubblicazioni di poesia; la prima in particolare, risalente al 1953, intitolata Non possiamo abituarci a morire, era stata ben accolta da Fortini. Il romanzo inedito era la storia del verbale di una riunione, redatto da un verbalizzatore così ossessivo da far entrare all'interno del testo qualsiasi cosa, "dando fondo se non all'universo", aveva scritto Calvino, "a una visione del mondo". Calvino aveva apprezzato il libro e tuttavia ne era rimasto quasi spaventato dalla "cupa aggressività" che gli ricordava Céline. E così, pur ammirando l'opera, aveva rifiutato di pubblicarla, motivando la sua scelta in modo coerente non solo con la propria idea di letteratura, ma anche con se stesso e le proprie fissazioni personali. "La verità è che io sono un maniaco dell'ordine e della geometria, e nel Suo eroico disordine mi raccapezzo poco".

Il giudizio finale ancora oggi suscita una doppia reazione, equamente divisa tra delusione e tenerezza verso Calvino, che aveva svelato una parte di se stesso all'autore. 2150 chilometri a nord di Torino, l'autore del romanzo inedito finiva il turno alla fabbrica di chiodi Christiania Spigerverk, ubicata nella periferia di Oslo. Si chiamava Luigi Di Ruscio, era nato a Fermo nel 1930, e come alcuni italiani – inconciliati con la nazione ancora fascista del Dopoguerra – aveva deciso di lasciare l'Italia nel 1957, ufficialmente per cercare lavoro e fuggire dalla fame. Ma oltre alla questione economica, Di Ruscio aveva vissuto l'impossibilità di adattamento al mondo democristiano e a quello del Pci. "Se i democristiani mi avessero dato anche un posto da scopino sarei rimasto in Italia", ha detto una volta. Aggiungendo però, poco dopo: "Senza la settimana corta, senza la paga oraria che mi fa comperare libri, non avrei potuto scrivere (...) Se fossi rimasto in Italia avrei potuto scrivere solo in galera (...) La settimana lavorativa era troppo lunga e spossante, ritornavo a casa solo per dormire". Luigi Di Ruscio, nel suo esilio scandinavo – perché di questo si è trattato – si è sposato con una norvegese, ha fatto quattro figli e lavorato nella stessa fabbrica di chiodi fino alla pensione, prima di morire a 81 anni, nel 2011. Ma soprattutto in questi decenni ha continuato a scrivere romanzi e poesie, e nonostante il disinteresse dei grandi editori si è creato una comunità di affezionati lettori. Le sue ultime opere sono state pubblicate negli anni scorsi da Ediesse e Le Lettere.
Ora, a tre anni dalla morte, Feltrinelli ha deciso di raccogliere alcuni suoi romanzi in un unico volume: Palmiro, Cristi polverizzati, Neve nera, Apprendistato (prefazione di Angelo Ferracuti, postfazione di Andrea Cortellessa). I romanzi di Luigi Di Ruscio si possono leggere come un'unica opera, e ci parlano sempre dell'Italia, la nazione perduta fisicamente ma riconquistata attraverso la lingua. Sono i romanzi dei manovali, dei contadini, dei giocatori di carte, dei barbieri politicizzati, del sogno impossibile di una rivoluzione vagheggiata nella luce accecante della piazza di un paese marchigiano, i suoi immediati dintorni di cui, grazie alla scrittura, riusciamo a percepirne gli odori. I romanzi sono la storia dell'infanzia, di chi ha visto il primo semaforo a ventidue anni e di chi ha tenuta accesa la fiammella della sua vita d'artista durante le ore in fabbrica. Di Ruscio tornava a casa in bicicletta e si rinchiudeva nella stanza per scrivere della luce italiana, dei personaggi epici e picareschi ritratti attorno alla sezione del partito, con uno stile scoppiettante e percussivo, furente e comico, mentre moglie e figli parlavano nel resto della casa in norvegese. La lingua è stata una forma di conoscenza e resistenza, anche in quei lapsus che sono diventati negli anni la peculiarità della prosa di Di Ruscio, forme alienate di un processo sorgivo. "Iscrivere", come sottolinea Cortellessa, è "un insistere", ma è anche un'iscrizione, "iscrivere" è la promessa di ogni inizio. Così come "profondando" è andare in profondità senza sprofondare: profondare è salvarsi con l'insistenza dell'iscrivere.
E tuttavia questa ricerca di salvezza non è mai individuale, altrimenti Di Ruscio avrebbe avuto un altro tipo di vita, adattata ai compromessi. I propri accadimenti personali sono sempre agganciati all'esistenza del noi, tanto da sentire un debito lontano, ringraziando le lotte operaie norvegesi degli anni '30, che avevano migliorato le condizioni di lavoro a Oslo, dandogli così la possibilità di scrivere nei decenni seguenti. Eppure non c'è mai una nostalgia edulcorata dell'Italia che fu, anzi, la prosa di Di Ruscio "è il presente del momento stesso in cui si racconta", aveva sottolineato Antonio Porta. Certo, spiace che questa importante antologia di Feltrinelli non sia arrivata con lo scrittore in vita. Ricordo quindi con affetto la sua felicità nell'apprendere che Cristi polverizzati era stato recensito in queste pagine, quattro anni fa: il tragitto in bicicletta alla ricerca di Repubblica, nell'edicola della stazione di Oslo. Ferracuti sottolinea che Di Ruscio, quando ha preparato la valigia per andare in ospedale, conscio della morte vicina e di quanto aveva fatto in vita, ha scritto: "Ritorno tranquillamente nel niente da dove sono venuto. Nei miei versi è la mia resurrezione".
Pubblicato precedentemente il 31 marzo 2014, su La Repubblica