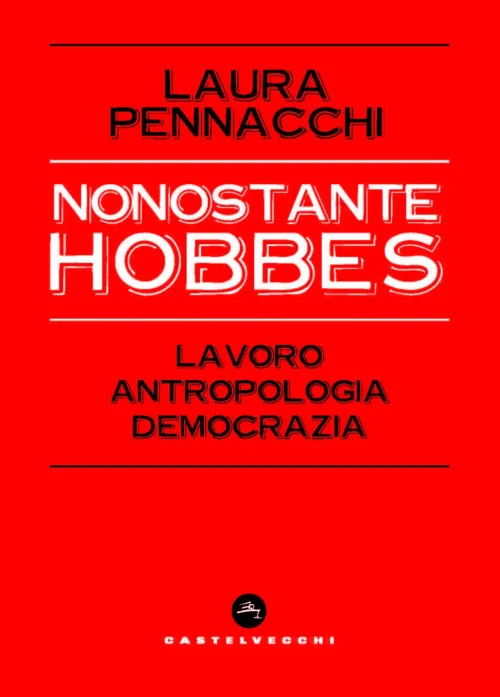Machiavelli e Hobbes neoliberisti
Machiavelli e Hobbes, essendo all’origine dell’antropologia negativa, dell’homo homini lupus, avrebbero aperto la strada al neoliberismo attuale, che nega il valore del lavoro umano. Tesi forte, estrema, dell’economista e filosofa Laura Pennacchi nel suo importante libro Nonostante Hobbes. Lavoro antropologia democrazia (Castelvecchi 2025). Tesi, quella di Laura Pennacchi, suffragata da una ricca analisi del neoliberismo e del populismo, ma che ha dedicato una poco approfondita critica ai due grandi autori classici. Pennacchi ammette che il loro pensiero è multiforme, estremamente complesso, mai riducibile ai loro interpreti. Eppure, li tratta in poche pagine (pp.83-89), il resto viene dedicato alle interpretazioni, eredità e sviluppi del loro pensiero.
Si è posta davvero con le pagine del Principe di Machiavelli e del Leviatano di Hobbes la base antropologica su cui il neoliberismo, secoli dopo, ha poi costruito? Il Principe muove sì da una visione dell’uomo negativa: l’uomo triste che obbedisce al potere perché ne ha timore, non perché lo ama. Qui ci sta fino a un certo punto il leader populista di oggi (che però vuole anche essere amato dalla folla). Ma la natura umana, scrive Machiavelli, è anche di obbligarsi per i benefici che si fanno e per quelli che si ricevono. E in questa reciprocità sta invece una visione antropologica moderna di contratto sociale. Doppiezza di Machiavelli? O ambiguità della natura umana?
Forse i due autori, Machiavelli e Hobbes, meritavano di più. In ogni caso alcuni anelli di congiunzione andrebbero approfonditi: anziché rovesciare, si potrebbero unire i grandi autori messi al vaglio della critica di Laura Pennacchi e i nuovi valori da lei enunciati. Tra questi possibili anelli di congiunzione vi è l’onore, la fama che muovono l'azione. Tema di Machiavelli e di Hobbes certo, ma onore (kleos) è anche quello che spinge Antigone a dar sepoltura al fratello. Quello che muove il lavoratore giapponese nella fedeltà verso l’azienda (il libro di P. d’Iribarne, La logique de l’honneur, è del 1989) mettendo in rilievo una diversa antropologia del lavoro così vicina a quella di Laura Pennacchi. Quello, infine, che appartiene a forme di ‘grandezza’, di ‘renom' (L. Boltanski e L. Thevenot, De la justification. Les economies de la grandeur, 2022) che si situano in una particolare cité, diversa dalla cité industriale o da quella del mercato, perché si fonda su valori in nome dei quali avviene l’accordo tra le diverse parti del corpo sociale.
E poi. Siamo sicuri che il neoliberismo costruisca il suo edificio sugli individui ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno descritti da Machiavelli nel famosissimo cap. XVII del Principe? L’ economia neoliberista si basa su un’immagine di homo oeconomicus, di liberi attori che compiono ‘scelte razionali’ entro mercati quanto più possibile de-regolati, mossi dallo scopo di massimizzare/ottimizzare i profitti. Non rispondono a nessun poter superiore, tantomeno allo Stato. Agiscono senza freni, spiega Pennacchi, in un quadro di ‘denormativizzazione’ (tutto è deciso dal contratto privato, non dalla Legge), mercificazione (tutto diviene merce compreso il lavoro, la terra, il capitale che sono invece merci molto particolari, spiegava Karl Polanyi), finanziarizzazione (tutto diventa rendita finanziaria e lotteria di borsa, all’opposto di quanto voleva John Maynard Keynes). Ma allora lo strale che Pennacchi rivolge a Machiavelli e Hobbes è forse mal indirizzato: dovrebbe essere rivolto a Milton Friedman (appena citato a p. 18-9) che teorizza lo ‘Stato minimo’ perché il capitalismo è ciò che l’uomo fa appena è lasciato solo. E a Friedrich von Hayek (citato a p.159), che in nome del cosiddetto ’ordine spontaneo’ della società vede nello Stato sociale interventista e welfarista la ‘strada verso la servitù’. La loro antropologia è diversa da quella di Machiavelli, autore che è ignoto a entrambi, e di Hobbes, che è da Hayek criticato in quanto rappresentante del razionalismo costruttivista incarnato dal moderno Stato (questo ‘uomo artificiale’, una costruzione artificiale degli uomini, di cui Hobbes è l’indiscusso teorico). Questi due classici, fondatori della Repubblica e dello Stato, non hanno insomma direttamente a che fare con il neoliberismo.
Invece, indirettamente sì. Attraverso la mediazione di Carl Schmitt, Leo Strauss, René Girard.
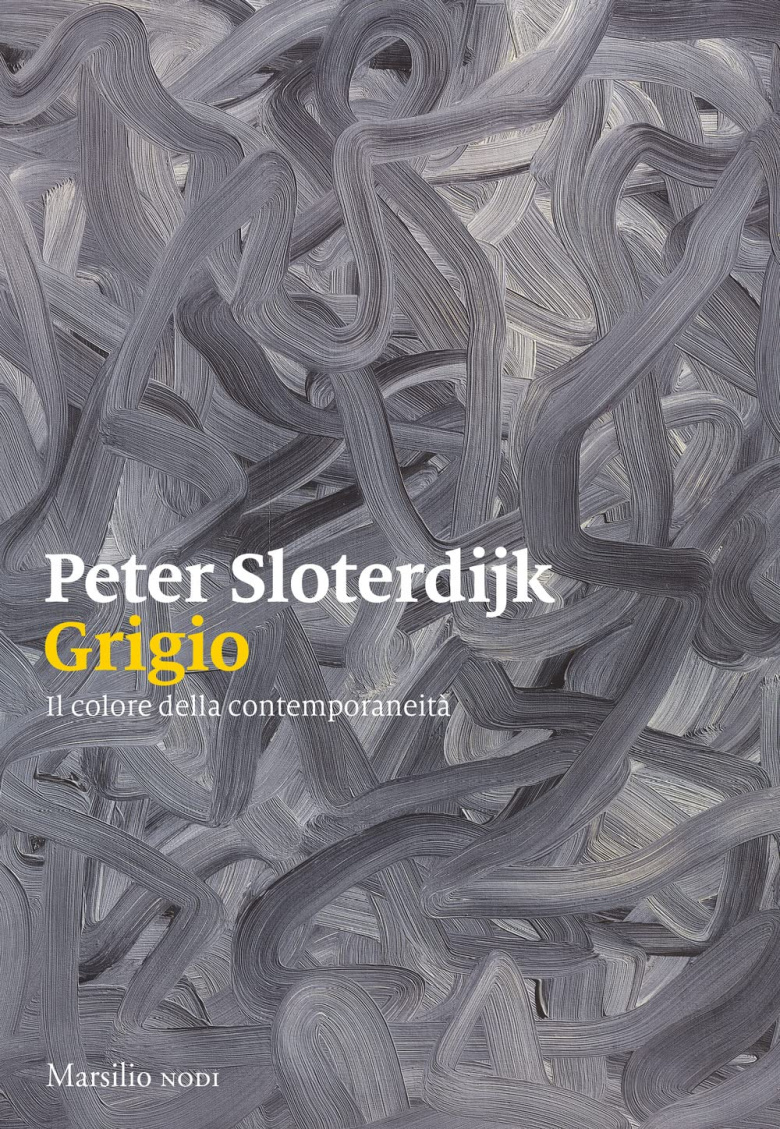
Resta aperta allora la questione: quale è l’antropologia filosofica del neoliberismo? su quale tipo umano esso ha costruito la sua fortuna che dura da 40 anni? Il libro di Pennacchi è bellissimo nel presentare la ricerca di valori, filosofici estetici etici, del pensiero Novecentesco, da Max Weber a Jürgen Habermas alla ‘seconda’ scuola di Francoforte: autori che vanno ad affermare i valori nell’epoca del negativo. L’antropologia che esalta la creatività (qui proposta nell’intero cap. 3 che conclude il libro) è notevole, e si può riassumere nella frase di Hans Joas, il sociologo esperto di teologia: il vero motore della dinamica dell’agire umano è la creatività, non la razionalità. Non altrettanto ricca è l’analisi critica di Pennacchi dei fondamenti antropologici del neoliberismo. Se non sono quelli di Machiavelli e di Hobbes, come qui ho cercato di sostenere, quali altri sono? Indagando un autore come Peter Thiel, investitore di Silicon Valley (alleato di Elon Musk e finanziatore di Trump e di Vance), scopriremmo che il suo liberismo (I am a libertarian) si nutre di Leo Strauss, Carl Schmitt, Renè Girard, del quale ultimo fu studente di filosofia a Stanford. Il percorso è più complicato: i classici del pensiero politico europeo ‘conservatore’ sono usati per smantellare la democrazia liberale, considerata da Thiel un ossimoro. E puntare a un ‘mondo Internet’ e oltre, finalmente liberato dal controllo dello Stato (ma senza dimenticare che l’Intelligenza Artificiale è una tecnologia militare per il controllo dell’avversario). Schmitt in dialogo con Strauss: questo è il fondamento di Thiel. L’Anticristo è quello che seduce gli uomini prospettando un mondo unificato in pace e sicurezza. Per reagire, occorre superare la paralisi del politico, uscire dal sistema di checks and balances della democrazia rappresentativa (P. Thiel, The Straussian Moment, 2007).
In altri termini, la pars construens del libro di Pennacchi è molto bella, la pars destruens invece difetta. Sì, è giusto criticare il neoliberismo. La domanda da proporci però è: perché questa ‘parte’, il neoliberismo, ha vinto e tuttora vince, nel mondo contemporaneo fino ad essere all’origine dell’attuale disordine mondiale?
Una risposta ‘filosofica’ viene dall’ultimo Peter Sloterdjik (Grigio, Il colore della contemporaneità, Marsilio 2023). Se (con il ‘Dio è morto’ di Nietzsche) dio non poteva più essere il ‘compensatore ultimo’ del male, ci si doveva rivolgere a chi provocava il male tra le file dell’umanità. La ‘classe’ è stata nel Novecento questa soluzione al problema del colpevole e delle vittime. Ma oggi assistiamo a una transizione dal ‘rosso’ al ‘grigio’ nel campo politico del Novecento: è il crepuscolo dei colpevoli che si stende su tutta la modernità, in cui è sempre più difficile distinguere i buoni che agiscono dai cattivi che reagiscono.
Uno storico del pensiero neoliberista, Quinn Slododian (autore di Globalists e di Hayek’s Bastards) sostiene una tesi diversa da quella di Laura Pennacchi. Egli dice: negli anni 1960-1970 il neoliberismo mette a fuoco la differenza umana, l’idea che gli esseri umani non siano interscambiabili e tutti uguali, ma che diverse popolazioni umane abbiamo diverse capacità e dotazioni da portare nel mercato. Questo ha condotto i neoliberisti a riscoprire categorie come cultura, razza, e civilizzazione. Di qui Hayek sosterrà negli anni 1980 che il mondo Occidentale ha qualità differenti dal resto del mondo, ed esso solo può produrre un certo tipo di attore economico ottimale. Quindi il capitale umano, che è sradicato (e ci viene in mente la Simone Weil del 1943, L’enracinement), che è de-territorializzato e universale, viene dai neoliberisti fatto “riatterrare” in particolari gruppi culturali e genetici, perfino qualcosa che si potrebbe definire “Volk capital”, capitale popolare. Siamo così al populismo.