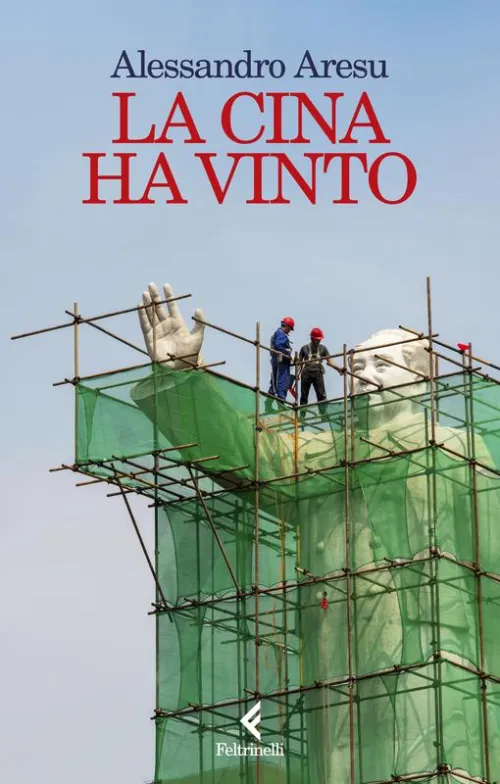La Cina ha vinto?
Alessandro Aresu scrive La Cina ha vinto (Feltrinelli 2025), mettendosi nei panni di Wang Huning, il settantenne professore di scienze politiche e suggeritore degli ultimi tre presidenti cinesi, una specie di Kissinger cinese membro del Politburo. Wang nel 1988, giovane professore cinese, visita per sei mesi gli Stati Uniti, decine di città e di università, vede le imprese e i poveri senzatetto, studia i consumi e le contraddizioni del paese. Curioso e attento, annota ogni cosa e al suo ritorno in Cina scrive America contro America, uscito nel 1991. Da allora è questo il libro che i dirigenti cinesi leggono per capire l’avversario americano, o meglio il competitor. Anche Aresu legge il libro di Wang Huning e gli dedica il suo libro, anzi letteralmente ce lo racconta, in un formato da romanzo più che da saggio. Già studioso di Max Weber, di Carl Schmitt, di Étienne Balazs, Aresu guarda adesso al mondo attraverso le caricature degli uomini potenti, americani e cinesi, le loro idiosincrasie e le loro menti calcolanti. I capi di Huawei e di Alibaba e i capi del Partito, i loro figli e le loro figlie, in Cina. I capi di X e di Palantir, e i nuovi padroni della Casa Bianca, in America. Lo stile è un po' Dynasty. Una sfilata di potenti: potrebbe essere un capitolo di un libro sulle nuove élites.
Certo la geopolitica studia il potere delle nazioni, quindi soprattutto chi comanda. Eppure, ogni misura del ‘potere’ dovrebbe includere la ‘massa’, il binomio cui Elias Canetti ha dedicato il suo grande libro, Massa e potere.
Ma non c’è qui la società reale, quella americana divisa e rotta, quella cinese prona alla burocrazia celeste. La dedica iniziale del libro ai ricercatori e agli operai cinesi “che hanno reso possibile la nostra vita digitale”, suona alquanto forzata. Qui degli operai di Shenzhen che assemblano i nostri smartphone, nei loro dormitori-lager, dei lavoratori 9-9-6 (lavorano dodici ore al giorno per sei giorni) delle fabbriche cinesi non c’è traccia. C’è sì l’ossessione cinese della produzione dell’industria (capitolo 3): ma è riferita alla cultura dell’industria pesante di Xi Jinping, che privilegia la fabbrica su ogni altro settore, “gli smartphone sono fatti dai cinesi e dai coreani e da nessun altro”. E neppure vi è traccia qui degli operai americani dell’Ohio, che si autodistruggono nella perdita di un dignitoso lavoro, mentre anche in Silicon Valley dilaga il lavoro 9-9-6. Ci sono solo Musk e Zuckerberg alla cerimonia di inaugurazione di Trump, Xi Jinping e i suoi nelle adunate del Partito. I personaggi principali, Aresu li elenca alla fine del libro (p. 113): il protagonista Wang Huning, il Partito (Xi Jinping, Jiang Zemin, il Ministero della Sicurezza), il mondo cinese che guarda al mondo (sette tra scienziati e capitalisti rossi), Deng Xiaoping e Annabel Yao figlia del fondatore di Huawei, Charlie Munger l’americano che scommise su BYD l’auto elettrica cinese, Joseph Needam grande studioso della Cina, Donald Trump il presidente-immobiliarista, infine la nonnina della frutta di Taiwan visitata da Jensen Huang fondatore di NVIDIA, la fabbrica americana dei chips.

Eppure, una più critica analisi del modello cinese e del ‘tipo cinese’ (Nietzsche lo chiamava così) è possibile e necessaria, è urgente: proprio grazie ai classici Weber (che vide il capitalismo politico), Schmitt (che teorizzò i grandi spazi), Balazs (che studiò la millenaria burocrazia celeste cinese), Kojève (che previde in largo anticipo come sarebbe avvenuta la diffusione universale del capitalismo ad Oriente, l’arricchitevi! poi proclamato da Deng Xiaoping che ha cambiato per sempre la Cina). O meglio, a partire dalle loro teorie per interpretare meglio la realtà in corso d’opera.
La geopolitica, guidata da una esclusiva visione della potenza, indica degli spazi di influenza cercati dagli Stati con la forza. Essa ha fatto un uso spregiudicato della teoria schmittiana dei “grandi spazi”: Stati-continente che si fronteggiano, in forma imperiale. “Il riconoscimento di una grande potenza da parte di un’altra grande potenza rappresenta la forma più alta del riconoscimento giuridico-internazionale” scriveva Schmitt nel 1950. Il superamento degli Stati-nazione era stato previsto già da Schmitt, Kojève, Jünger dopo la Seconda Guerra Mondiale: essi pensavano portasse verso lo Stato mondiale, e invece ha condotto prima alla logica dei blocchi, USA-URSS, poi alla contrapposizione Nord-Sud. Agli Imperi. Oggi, Americano e Cinese. Sarebbe stato utile inserire nel libro come la Cina è stata riconosciuta grande potenza (momento chiave gli anni ’70, quando Nixon va da Mao).
Il libro di Aresu ci racconta (cap. 3) i campioni dell’Intelligenza Artificiale, mezzo cinesi mezzo americani, che creano nuove imprese in pochissimo tempo, accelerazione è la parola chiave. Così i cinesi da oggetti, sudditi diventano “soggetti del nostro mondo”. Ma ‘soggetti’ come? e chi? i pochi privilegiati, i molti ricercatori di Intelligenza Artificiale, i lavoratori delle fabbriche, l’intera popolazione? Il problema della cittadinanza e dei diritti nella modernizzazione cinese mi sembra assente dal libro. Servirebbe un’analisi della società cinese, dal di dentro. L’uscita dalla povertà in pochi decenni. La corsa all’arricchimento personale. Il neijuan che significa la competizione in tutti i campi: educativa, lavorativa (il 9-9-6), tra imprese (con offerte al ribasso). La pressione scolastica sugli studenti e sui genitori, una “corsa del topo” autolesionista e inutile per le famiglie medie, mentre le famiglie molto abbienti fanno in modo che i figli abbiano un passaporto straniero e li mandano alle scuole internazionali. Gli operai-contadini che restano senza cittadinanza urbana (hukou) ai margini delle smisurate megalopoli. I costi sociali e ambientali incalcolabili della modernizzazione cinese. In cui la dittatura è presente in ogni segmento della società.
Il libro tratta invece della ‘guerra per i talenti’ (cap. 2) che la Cina scatena nei confronti dell’America, documentata da fitte pagine di nomi di studenti o studiosi cinesi che operano nella ricerca negli Stati Uniti. Il commento lo fa Wang Huning, le classi in cui il computer ha diviso il mondo sono due: gli asiatici, soprattutto cinesi, e gli asiatico-americani, soprattutto cinesi. Se ne conclude che l’America ha i giorni contati se non continuerà ad alimentarsi di menti cinesi, forse nel frattempo potrà contare su quelle indiane. Gli ingegneri di Bangalore sono già da anni una risorsa-chiave per l’industria tech americana.

Il libro accumula evidenze a sostegno della tesi: la Cina ha vinto. È lo slogan prestato da un ex-rappresentante commerciale degli Stati Uniti in Cina, Michael Froman, un avvocato che ha lavorato per la Mastercard. Questa profezia geocommerciale, su cui molti sono oggi pronti a scommettere, sembra prendere il posto della profezia geopolitica, di Weber e Schmitt, che un secolo fa hanno mostrato dove stava andando il capitalismo: a occupare tutto il mondo. Questa unificazione del mercato mondiale sta però avvenendo in modo per nulla pacifico, bensì irto di conflitti. Nessun nomos della terra la governa. Aresu ne vede il lato cinese: crescita in pochi anni di imprese come BYD a Shenzhen, un milione di addetti nell’auto elettrica, pronta a superare la Tesla di Elon Musk. O come Xiaomi, l’azienda che fa un’auto in 76 secondi e uno smartphone in 60 secondi. Ma in questa crescita esiste davvero uno ‘spirito del socialismo’? Non basta per illustrarla lo ‘spirito del capitalismo’ di Max Weber, debitamente aggiornato?
La propaganda cinese insiste sulle magnifiche sorti e progressive del socialismo, con milioni e milioni di giovani cinesi che vogliono emulare ed eguagliare i ricchi capitalisti rossi. Si capisce: è il ruolo del Partito-Stato, questo. A noi serve piuttosto una capacità critica. Ad esempio, immettendo nella narrazione non solo le storie di successo ma anche le storie di fallimento e di anomia che pure traspaiono nella letteratura e nel cinema cinesi, e nei resoconti non ufficiali. Ma anche molto si capisce da semplici visite alla Cina reale: gli operai edili che vivono in baracche costruendo i nuovi grattacieli, gli homeless che dormono sotto i ponti, Hong Kong che ha visto distrutta la propria peculiare identità storica in nome della cinesizzazione, e Taiwan in attesa del peggio (Aresu dedica sei pagine del cap. 4 a Taiwan ma parla d’altro, racconta la guerra “di parole” tra le università cinesi e taiwanesi in passate competizioni, ma qui si prepara la guerra “vera”). Anche la Cina crea enormi diseguaglianze e grandi gruppi di emarginati, forse perfino maggiori di quelle delle società occidentali. Soprattutto i lavoratori migranti senza hokou, 300 milioni secondo le stime (la statistica cinese è inattendibile). I bambini lasciati nel villaggio di origine. La disoccupazione giovanile stimata al 20%. I gruppi di perseguitati come i creativi cinesi di tutte le arti (dalla Cina non verrà la creatività). Non significhi, questo, adottare lo stereotipo della Cina che copia tutto dall’Occidente, giustamente criticato da Aresu, perché una cultura cinese ovviamente esiste nella sua piena autonomia. Ma certo serve a mettere a fuoco un fatto: dopo la grande stagione narrata dallo storico Joseph Needham, e molte volte citata in questo libro, della supremazia cinese fino al suo declino e alla chiusura (secoli XV-XIX), la riapertura cinese al mondo capitalistico sta avvenendo a costi enormi e accelerati per il paese e per il pianeta.
Insomma, davvero la Cina ha vinto? O l’Occidente ha perso, come argomenta Emmanuel Todd nella sua Sconfitta dell’Occidente (2024)? In quel libro Todd sostiene che quando un Paese raggiunge il 20-25% di istruzione superiore di una generazione, la sua popolazione si sente immediatamente superiore, e al sogno dell’uguaglianza subentra la legittimazione della diseguaglianza. È accaduto all’America dopo il 1965. Succederà alla Cina dopo il 2025?