Hervé Bazin: la madre cattiva
Una madre deve essere «sufficientemente buona», lo affermava Donald Winnicott, lo psicoanalista britannico che nel 1964 fu tra i principali esponenti della teoria dell’attaccamento. Di madri non buone, o meglio di madri cattive, sono popolate le pagine delle grandi opere letterarie: da Medea a Madame Bovary, sino ai giorni nostri con le narrazioni vincenti di famiglie disfunzionali che ottengono il plauso della critica. Del resto, parafrasando Tolstoj, le famiglie felici non fanno letteratura; ciò che chiediamo ai libri è di analizzare l’ambiguità, la zona d’ombra, la frustrazione, tutto il gigantesco sommerso del quotidiano, dunque anche il lato “meno materno” della maternità.
Un romanzo in particolare, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1948, presentava una figura di madre decisamente inquietante: Pauline Pluvignec, detta Folcoche, emblema dell’antagonista per eccellenza. Un personaggio memorabile, la più cattiva delle madri cattive, capace di imprimersi a fuoco nella mente del lettore lasciando un ricordo traumatico e persistente. Il romanzo in questione era Vipera in pugno (Vipère au poing) di Hervé Bazin, fu presentato alla sua pubblicazione come autobiografico e sollevò un vespaio di polemiche, poiché per la prima volta veniva decostruito apertamente il mito dell’amore materno. A dispetto dello scandalo suscitato – o forse proprio a causa dello scandalo – il libro vendette milioni di copie, fu tradotto in tutto il mondo e venne adattato per il cinema nella pellicola omonima di Philippe de Broca.
La storia narrata da Bazin – che in seguito sarebbe diventato presidente dell’Accademia Goncourt – era un racconto viscerale di amore e odio, la ribellione di un figlio all’autorità inclemente della propria madre. Oggi Vipera in pugno torna nelle librerie italiane dopo numerosi anni di assenza – l’ultima edizione risale al 1974 per Garzanti. Lo riporta in auge Feltrinelli Gramma, nella nuova traduzione di Riccardo Fedriga, con un’intensa copertina viola in cui campeggia il volto contrito di un bambino in bianco e nero. È un libro che, a oltre settant’anni dalla prima edizione, non ha perso un briciolo della propria forza sovversiva e inchioda il lettore sin dalla prima pagina.
Il romanzo si apre infatti con l’uccisione di una vipera per mano del piccolo Jean Rezeau: «Afferrai la vipera per il collo, esattamente sopra la testa, e strinsi, niente di più». Il bambino uccide per diletto, per gioco, e viene subito punito dalla famiglia in una scena che ben presto assume dei tratti tragicomici e grotteschi. Sin dall’incipit Bazin trasforma la vipera in un animale simbolico: il sacrificio della vipera scatena il dramma, che l’autore riesce abilmente a trasfigurare in una parodia della società borghese ormai in declino. La vipera, già morta, sarà finita a colpi di tacco dallo zio di Jean, un insigne protonotario apostolico, che per l’occasione viene paragonato a San Michele: «il serpente, che cadde, inerte, sul gradino e che mio zio, oramai rassicurato, con fare militaresco finì a colpi di tacco come san Michele, suo patrono».
Il paragone è volutamente irriverente, dal momento che l’arcangelo san Michele, invece, si trovò a fronteggiare un vero e proprio drago. L’intero libro di Hervé Bazin è intessuto di riferimenti biblici e mitici che rimandano alla simbologia del serpente. Sin dal principio la vipera diventa una metafora della terribile madre e fornisce, indirettamente, un’anticipazione della sua malvagità – che il lettore ancora non conosce.
La scena inusuale di un atto efferato, di un assassinio, che certo non ci aspetteremmo compiuto dalle mani innocenti di un bambino, contiene una potente carica simbolica. Il serpente da predatore diventa preda, stretto tra le dita bambine che lo strangolano, in un ribaltamento di ruoli singolare. La morte della vipera, posta all’inizio del libro, può essere letta come un sacrificio. Secondo René Girard un rituale sacrificale permette alla comunità di difendersi dalla propria violenza, deviandola verso una vittima sacrificabile. In quest’ottica, secondo Girard, la vittima del sacrificio diventa una divinità protettrice, impedendo così di sprigionare la vera violenza e, di conseguenza, ai membri della comunità di uccidersi a vicenda. Dunque il sacrificatore – in questo caso il bambino – pensa a colui che vuole uccidere – la madre – uccidendo colui che sacrifica – la vipera.
L’apertura del romanzo di Hervé Bazin, letta in chiave simbolica, appare come un capolavoro di retorica: la vipera, che dà il titolo all’opera, è la «vittima sostitutiva» intesa da Girard e tornerà, non a caso, nel finale in un significato trasfigurato e metaforico tra le mani di Jean ragazzo, «vipera in pugno» come emblema della rivolta compiuta.
Oltre all’indiscusso valore letterario, ciò che colpisce del romanzo di Hervé Bazin è il tono. È il tono che avvince il lettore dall’inizio alla fine dell’opera, trascinandolo a perdifiato con un linguaggio furioso, amorale, nella ribellione del protagonista Jean Rezeau, soprannominato a proposito “Teppa”. La voce di Hervé-Jean si ribella progressivamente a ogni forma di autorità, da quella materna a quella religiosa, sino a decostruire l’intero costrutto sociale mostrando lo stile di vita ipocrita e sopra le righe di una borghesia ormai decaduta. Persino la religione, nel libro di Bazin, viene considerata una pratica di asservimento: la confessione viene presentata come strumento utilizzato per «mettere a nudo le coscienze», la messa domenicale viene seguita in modo ossequioso dagli oltre «trecento braccianti» della magione secondo un consolidato rituale di sottomissione, inoltre la madre traccia il segno della croce sulla fronte dei figli con le unghie imprimendo così lo stigma indelebile della propria autorità.
Dopo l’efferata uccisione dell’animale posta in apertura, il dramma vero e proprio si compie quando entra in scena la vera antagonista della storia: «La nonna morì, la mamma arrivò». La madre Paule, scopriamo presto, ha molto in comune con la vipera, si presenta ai figli battezzandoli a suon di schiaffi, provocando in loro un immediato rifiuto: «Le pupille aguzze della donna che non volevamo già più chiamare mamma». I figli, a loro volta, ribattezzeranno quella madre crudele con il nomignolo di «Folcoche» – in francese traducibile come scrofa, l’animale che mangia la propria prole – ma reso nella traduzione italiana di Fedriga come «Bastarda» o nell’ancor più dispregiativo «Bastarda pazza».
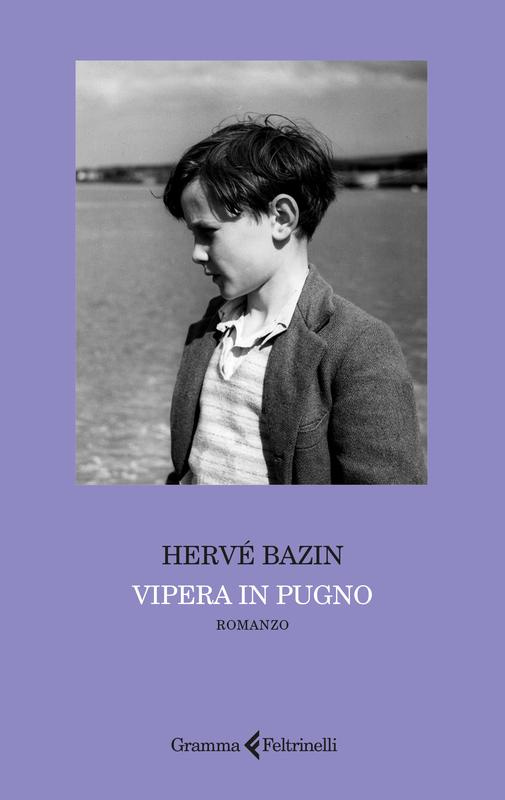
Emerge, pagina dopo pagina, il singolare ritratto di una donna che «oltre ai figli aveva due soli nemici: le tarme e gli spinaci» e impone nella dimora della Belle Angerie un’educazione autoritaria, per non dire spartana, un autentico regime dittatoriale del terrore in ossequio a norme stringenti di economia domestica. Le azioni compiute dalla madre replicano, curiosamente, il sistema di attacco e difesa del serpente: a tavola sevizia le mani dei bambini con delle forchettate, conficcando i rebbi nella carne come denti, e fa inghiottire ai pargoli delle porzioni esorbitanti di olio di ricino, come se iniettasse in loro il suo veleno.
I figli, vittime designate, sono tre: Ferdinand soprannominato “Il Moscio”, Jean o “Teppa” e Michel detto “Scricciolo”. L’unico in grado di opporsi fermamente alle angherie materne sarà il protagonista e narratore, Jean, perché, come vedremo, è colui che più assomiglia alla madre e dunque il solo capace di tenerle veramente testa. A fare da contraltare è un padre, Jacques, vile e sottomesso che sembra avere più a cuore la propria collezione di insetti che il benessere della prole. «Avevamo freddo, avevamo fame. Guardavamo con bramosia le ante socchiuse degli armadi da cui nostra madre attingeva, con parsimonia, cibo e vestiti» racconta l’avvilito Jean al principio della storia, mentre nel suo cuore sta maturando il rancore che lo condurrà a compiere atti sconsiderati, come due tentativi di matricidio.
Secondo Donald Winnicott una “madre buona” è colei che si adatta ai bisogni del proprio bambino e ne favorisce l’indipendenza, permettendo così lo sviluppo del suo «sé autentico». In caso contrario, dunque di madre «non sufficientemente buona», Winnicott sosteneva che a essere tradita è «l’onnipotenza soggettiva del bambino» e la conseguenza è la creazione di un «falso sé», ovvero di una personalità non sviluppata, con una tendenza difensiva, anaffettiva. La teoria di Winnicott ci consente una chiave di lettura psicologica di Vipera in pugno, che si rivela necessaria dal momento che, forse, l’elemento psicologico è ciò di cui il romanzo è privo.
Nel finale il figlio impenitente diventa lo specchio della madre, in una dicotomia speculare al detto «tale madre, tale figlio». È come se Jean avesse assimilato l’autorità materna alla stregua di un’infezione velenosa, divenendo vipera lui stesso. Ed è qui che il libro di Bazin ci pone la domanda capitale: qual è l’esito di un’educazione autoritaria sui figli? Nell’apprendistato all’odio compiuto dal suo protagonista vediamo gli effetti, nefasti, di uno stile educativo rigido e inflessibile. L’adolescente Jean diventa un ragazzo ribelle, incapace d’amare e resistente nei confronti di ogni forma di autorità, il suo unico istinto dominante è la fuga. Il paradosso è che, nell’impeto della propria feroce rivolta, si rende conto di aver interiorizzato le regole materne, quando afferma: «La personalità che ho issato sull’albero maestro come una bandiera nera è stata confezionata da te in ogni piega, che hai tinto e ritinto con il miglior nero di seppia». La morale finale professata da Jean è feroce, un trionfo dell’odio, perché da una madre cattiva non si può che apprendere la sfiducia nei confronti del prossimo e la conseguente impossibilità di amare.
Ciò che manca, in Vipera in pugno, è la voce della madre. Paule Pulvignec, detta Folcoche, ci viene restituita con i tratti caricaturali e malefici che la rendono l’antagonista perfetta – ma non ci viene raccontato il suo punto di vista. Sulla base psicologica della teoria dell’attaccamento potremmo dedurre che anche lei sia stata vittima di uno stile educativo punitivo e autoritario, che avrebbe poi replicato a propria volta, infliggendolo ai figli.
Sulla vera storia di Paule Pluvignec Rezeau ha fatto luce di recente, con un libro-inchiesta pubblicato dall’editore francese Grasset, la giornalista Émilie Lanez. In Folcoche: Le secret de “Vipère au poing”. Enquête sur un meurtre littéraire, Lanez muove la potente accusa che il romanzo di Bazin non sia in realtà autobiografico, ma una sorta di vendetta costruita ad arte contro la propria famiglia. La giornalista prende le difese di Paule, liberandola dal «mostro di carta» in cui il figlio scrittore l’avrebbe imprigionata compiendo un «matricidio letterario». Tra le pagine di Folcoche (Grasset, 2025) scopriamo che anche Paule ebbe un’infanzia infelice, fu rinchiusa per oltre dieci anni in collegio e, in seguito, data in sposa contro la sua volontà a un perfetto sconosciuto. Émilie Lanez nella conclusione della sua inchiesta sostiene che non è stata una madre amorevole, ma autoritaria, in ogni caso «non una torturatrice».
Dunque, Vipera in pugno sarebbe una falsa autobiografia? Un romanzo di vendetta? Io credo che non ci sia un'unica verità, proprio come non c’è un’unica storia. La forza del romanzo d’esordio di Bazin – che tra l’altro apriva una trilogia dai titoli simbolicamente animaleschi – era data dalla voce furiosa e ribelle del suo protagonista: è la storia di Jean Rezeau o di Jean-Hervé Bazin, poco importa. Nella letteratura non cerchiamo la verità pura e oggettiva, ma la verità individuale, che è poi quella che nella vita rimane sempre inabissata, sommersa, taciuta. Vipera in pugno racconta una rivolta adolescenziale e ha il tono assoluto dell’adolescenza e delle sue teorie incontrovertibili, estreme, radicali: non c’è spazio per il pentimento, per il rimorso, in quel libro – e non deve esserci, perché altrimenti verrebbe meno il tono irriverente che lo ha reso un capolavoro. Il narratore di Vipera in pugno è bambino, poi ragazzo, non è ancora adulto; ed è solo da adulti che si impara davvero a perdonare le colpe dei padri, o delle madri.
In copertina, opera di Larry Madrigal.







