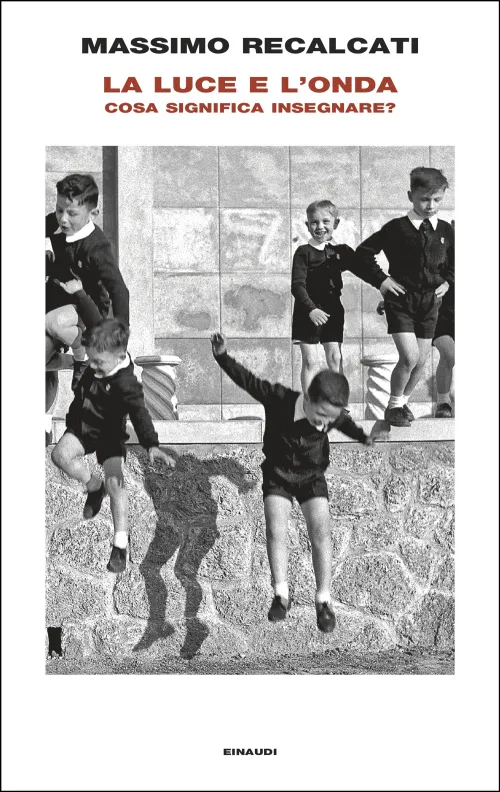Recalcati: a scuola di creatività
Potremmo considerare La luce e l’onda. Cosa significa insegnare? (Einaudi, 2025), il nuovo libro di Massimo Recalcati dedicato alla scuola, un testo sulla creatività che attraversa la vita della scuola. Al centro della riflessione è l’idea che l’insegnamento e l’apprendimento non consistano soltanto nella trasmissione e nell’acquisizione di conoscenze e competenze: la posta in gioco è molto più alta, la scuola è il luogo relazionale dove avviene una trasformazione soggettiva che tocca tanto i maestri quanto gli allievi. In questa prospettiva la scuola si configura come una comunità con caratteristiche uniche e peculiari che la contraddistinguono da tante istituzioni indispensabili alla vita sociale. Il punto di vista di Recalcati rimane focalizzato – come era già avvenuto in L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento (Einaudi, 2014) – sull’intreccio tra vita e sapere che, grazie alla testimonianza dell’insegnante, diventa il fulcro di ogni processo di apprendimento. A questo nucleo concettuale si aggiungono tante altre diramazioni che riprendono temi che Recalcati ha sviluppato negli ultimi dieci anni nei saggi dedicati alla psicoanalisi di Jacques Lacan; ai sintomi contemporanei e in special modo alle forme di ritiro sociale caratterizzati da un’inedita affermazione della pulsione securitaria; all’arte contemporanea dando testimonianza della tensione perpetua tra forza e forma; fino alle più recenti teorizzazioni dei discorsi e dei codici che permeano la vita delle istituzioni e della società.
Queste riflessioni sono lo sfondo su cui si stagliano le figura concettuali della luce e dell’onda, metafore con cui Recalcati illustra il movimento creativo insito in ogni processo di trasmissione del sapere. Il sapere è sempre intrecciato alla vita, il sapere non definisce un universo ordinato di concetti separati dalla perturbazione e dall’imprevedibilità della vita, anzi: il sapere si presenta come un campo di esperienza dove maestri e allievi compiono quegli esercizi di soggettivazione che sono necessari per fare della vita l’occasione per realizzare la propria vocazione personale. Le conoscenze e le competenze rischiano di rimanere materiale inerte se non diventano gli ingredienti per attraversare una soglia, per scandire un prima e un dopo che genera quelli che il filosofo Althusser, ripreso da Recalcati, nomina “effetti di soggettività”.
Insegnare significa dunque, innanzitutto, sostenere un movimento trasformativo che consiste nel diventare “soggetti”, cioè fare esperienza del valore unico e insostituibile della propria singolarità desiderante. Se l’insegnamento non provoca l’accensione del fuoco del desiderio non solo non riesce ad attivare le motivazioni principali che spingono uno studente ad apprendere, ma manca anche il fine etico più profondo, ovvero stimolare e valorizzare la partecipazione a un legame sociale capace di accogliere la singolarità di ciascuno. Se riprendiamo tanti altri testi di Recalcati troviamo qui uno dei temi che attraversano le sue opere: come tenere insieme l’universale e il singolare, la Legge e il desiderio. Ora, per Recalcati la scuola è il luogo dove si può, e si deve, fare questo esercizio di soggettivazione, imparando a esprimere la propria singolarità attraverso il legame con l’Altro, un Altro che trasmette il sapere come una luce che apre nuovi orizzonti, nuovi mondi che sollecitano il desiderio di esplorazione degli allievi e anche dei maestri.
Quando i maestri o le maestre insegnano trasportano gli studenti in un nuovo mondo, dove oltre alla chiarezza dei contenuti, si trovano anche elementi che restano oscuri, quegli aspetti di ogni disciplina che non possono essere rischiarati dal sapere già saputo. È qui che entra in gioco la luce del maestro, perché si tratta di una luce che illumina ciò che si sa già e, al contempo, è rivolta verso ciò che ancora non è stato scoperto o compreso. In questa tensione verso la dimensione della scoperta il maestro può trovare una forza rigenerante che può sostenerlo nella riproposizione dei contenuti che già conosce. In fondo, nella pratica quotidiana dell’insegnamento, la sfida motivazionale a cui sono sottoposti i maestri riguarda innanzitutto il desiderio che li spinge a trasmettere argomenti che conoscono già. Come introdurre nella ripetizione degli argomenti e dei programmi didattici quell’elemento che può far sorgere l’esperienza del nuovo? Come può un maestro o una maestra insegnare gli stessi contenuti con la passione delle prime volte? Come può imparare qualcosa di nuovo nell’atto stesso di insegnare? Sono questioni cruciali perché riguardano la possibilità di trasmettere un sapere vivo. Se il maestro tratta il proprio sapere come un sapere mai compiuto una volta per tutte, potrà allora presentarlo come un sapere che stimola la ricerca, un sapere dove i presupposti già consolidati aprono la strada per ciò che ancora non si sa.
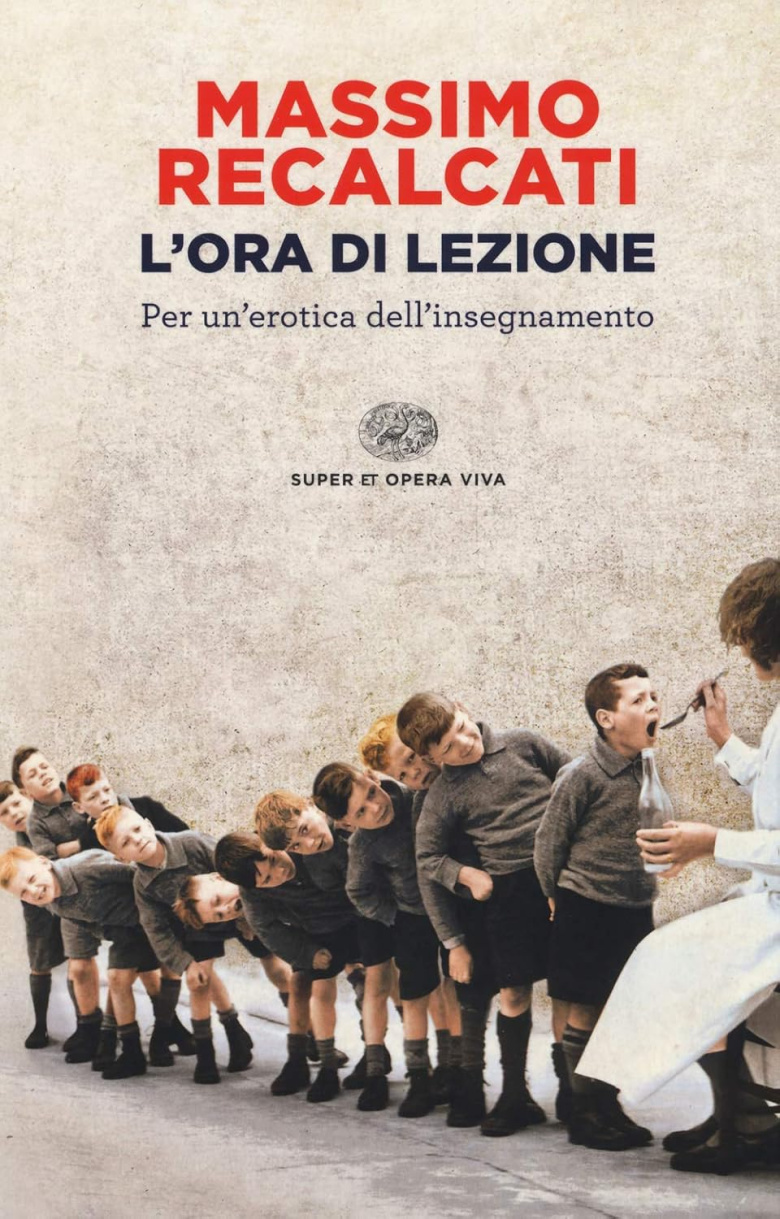
Quando l’insegnamento si svolge mantenendo la dimensione insatura del sapere, è possibile coinvolgere gli studenti e gli allievi in questa avventura dove l’acquisizione delle basi di una disciplina può diventare il punto di partenza per il viaggio nel sapere. Dopo la lettura di La luce e l’onda mi sono imbattuto per caso in alcuni versi della poesia Scritta da un margine di Pierluigi Cappello: “non si tratta di riempire, si tratta di far parlare il vuoto”. Versi, questi, in perfetta risonanza con il messaggio di Recalcati: è dal vuoto che bisogna parlare. La chiarezza dei contenuti non è sufficiente: il maestro deve dare testimonianza del proprio rapporto con il vuoto di sapere, con quel vuoto che non permette al sapere di chiudersi su sé stesso e di rimanere invece come un campo di ricerca da esplorare ancora, ancora una volta insieme. I maestri e le maestre devono essere sicuramente competenti nelle materie che insegnano, ma non tanto nel senso di essere padroni della materia, perché ciò che rende vivo il rapporto con il sapere deriva da ciò che rende incompleto quel sapere. Il coinvolgimento degli studenti, anche dei più giovani o piccolini, scaturisce dalla dimensione della scoperta, che deve essere vissuta e testimoniata in primo luogo dal maestro: solo in questo modo i maestri possono trasmettere un’autentica credibilità e ricevere l’attenzione che meritano, soprattutto in un’epoca in cui, a causa dell’evaporazione di tante certezze sociali e con l’incalzare delle innovazioni tecnologiche, il loro ruolo non viene riconosciuto per la valenza simbolica e generativa che ha dentro e fuori la scuola.
All’atto della testimonianza, che tiene insieme la dimensione simbolico-relazionale e la vibrazione desiderante dell’insegnamento, Recalcati aggiunge un altro tipo di atto, che potremmo definire come l’atto dell’esposizione all’onda. Infatti, oltre a dare testimonianza della luce – la luce che non copre tutto l’esistente ma preserva anche quel non-tutto che fa riecheggiare il mistero e il vuoto centrale di ogni sapere – il maestro invita l’allievo a compiere in prima persona un esercizio di soggettivazione del sapere. Nell’esposizione all’onda l’allievo non può più prendere come riferimento ciò che il maestro gli stava illustrando un momento prima, nell’immergersi nell’onda ciascun allievo è chiamato a metterci qualcosa di suo, perché l’onda, come la vita, non si presta a essere padroneggiata con un sapere preesistente, neanche quello testimoniato dal maestro. La testimonianza del maestro non è mai una presentazione di un sapere esemplare che consente di essere più capaci nell’atto di nuotare in prima persona. La testimonianza del maestro mostra, semmai, la possibilità di abitare e gioire del transito che conduce dal sapere appreso dall’Altro verso il momento in cui quel sapere viene soggettivato nell’atto di esporsi alla vita. Ecco perché Recalcati sottolinea l’importanza di mantenere l’esperienza della prova nella scuola. Non si tratta di costruire dispositivi di valutazione sempre più sofisticati che si presume possano misurare oggettivamente il merito di un soggetto.
La questione del merito non è da escludere, se la si considera però nell’ottica di mantenere la consapevolezza che è inevitabile che esistano delle differenze (e non delle disuguaglianze!) tra le persone. Tuttavia, non è questo il punto su cui Recalcati approfondisce le sue argomentazioni, ciò che sottolinea con chiarezza riguarda la necessità di valorizzare la prova come esercizio di soggettivazione, come occasione per esporsi all’onda, non solo all’onda che viene dal mondo esterno ma anche all’onda vibrante che attraversa ciascuno di noi ogni qualvolta prendiamo la parola in prima persona, senza la garanzia dell’Altro. Non esiste un Altro in grado di confermare in anticipo un’esperienza di sé che si può constatare solo dopo l’impatto con l’onda. È in gioco, qui, anche un atto di fiducia che il maestro compie verso gli allievi: è solo nell’incontro con l’onda potranno realizzare un’esperienza di sé che riconfigurerà il loro rapporto con il sapere. La creatività in gioco nel momento della prova non riguarda necessariamente la formulazione di un nuovo sapere che potrà portare al riconoscimento di premi o votazioni eccellenti. Si tratta piuttosto della creatività che ciascun soggetto, sin dai primi anni di scuola, può sperimentare, con vari livelli di intensità e con differenti qualità, quando fa esperienza di transitare dalla posizione di esecutore di un sapere precostituito alla soggettivazione di quel sapere, che magari non lo rende autore di un nuovo sapere, perché ciò che è davvero importante e irrinunciabile è la sensazione, che si scrive nel corpo e permea ogni processo mentale, di diventare soggetto attraverso un esercizio di sapere. Il sapere diventa allora la chance per scoprire contemporaneamente nuovi stati del Sé e nuovi aspetti della vita che probabilmente non sarebbero mai esistiti senza l’incontro con la luce e l’onda del maestro.