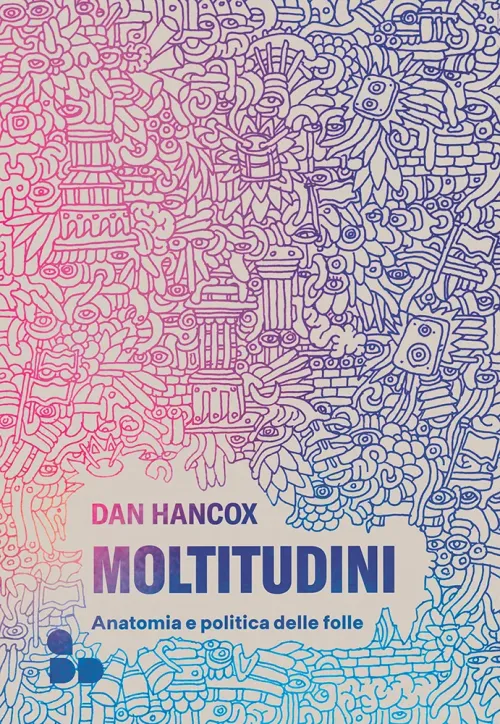Dan Handox: masse e politica
Moltitudine è una categoria di analisi che ha attraversato l’intero arco del ‘900.
Vi si misurano per primo Elias Canetti e da ultimo Toni Negri insieme a Michael Hardt all’inizio di questo millennio.
Ciò che discende da questi due diversi laboratori intellettuali è interessante per comprendere all’interno di che cosa si muova e come si distingua Dan Hancox nel suo Moltitudini. Anatomia e politica delle folle (Add).
Ha scritto Elias Canetti in Massa e potere – che la massa vera e propria è una massa aperta che si abbandona liberamente al suo impulso naturale di crescita e che una dimostrazione di questo modello di azione è dato dalla decisione di abbassare le braccia e iniziare un’azione di sciopero. Quell’atto, osserva, esprime la sua potenza non tanto nel fatto che tanti singoli compiono lo stesso gesto, bensì nel produrre improvvisamente e immediatamente una condizione di eguaglianza tra i partecipanti. Non importa, sottolinea, quale sia la loro funzione, quali le competenze, che ruolo svolgano nel complesso del sistema produttivo, “le mani che ricadono – scrive – creano una condizione di pariteticità”.
Diversamente Negri e Hardt nel loro Moltitudine (Rizzoli) hanno il problema non tanto di descrivere, quanto di distinguere: moltitudine, precisano, non ha connessione con il concetto di «popolo», né con quello di «massa», né, ancor meno, con «classe operaia». E tornando su quel concetto nelle pagine conclusive di Da Genova a domani (Ponte alle Grazie), Negri individua nella moltitudine una condizione di insorgenza a fronte della quale il potere si rapporta, meglio si contrappone per fare in modo che tale rimanga, che non acquisisca una consapevolezza di sé. “La forza del padrone è tutta rivolta a impedire che dalla moltitudine rinasca la classe. Che dalla moltitudine risorga la forza politica organizzata propria di un «individuo sociale».
Tenendo conto di questo doppio registro Dan Hancox nel suo Moltitudini. Anatomia e politica delle folle (Add), propone di tornare a riflettere sul comportamento delle moltitudini. un testo che ha tra l’altro lo scopo di depotenziare la forza comunicativa di un classico del tema, La psicologia delle folle di Gustave Le Bon, che dal 1895 costituisce una lettura obbligata e che torna in libreria in queste settimane con una nuova traduzione per Bollati Boringhieri. Su questa nuova edizione tornerò più avanti.
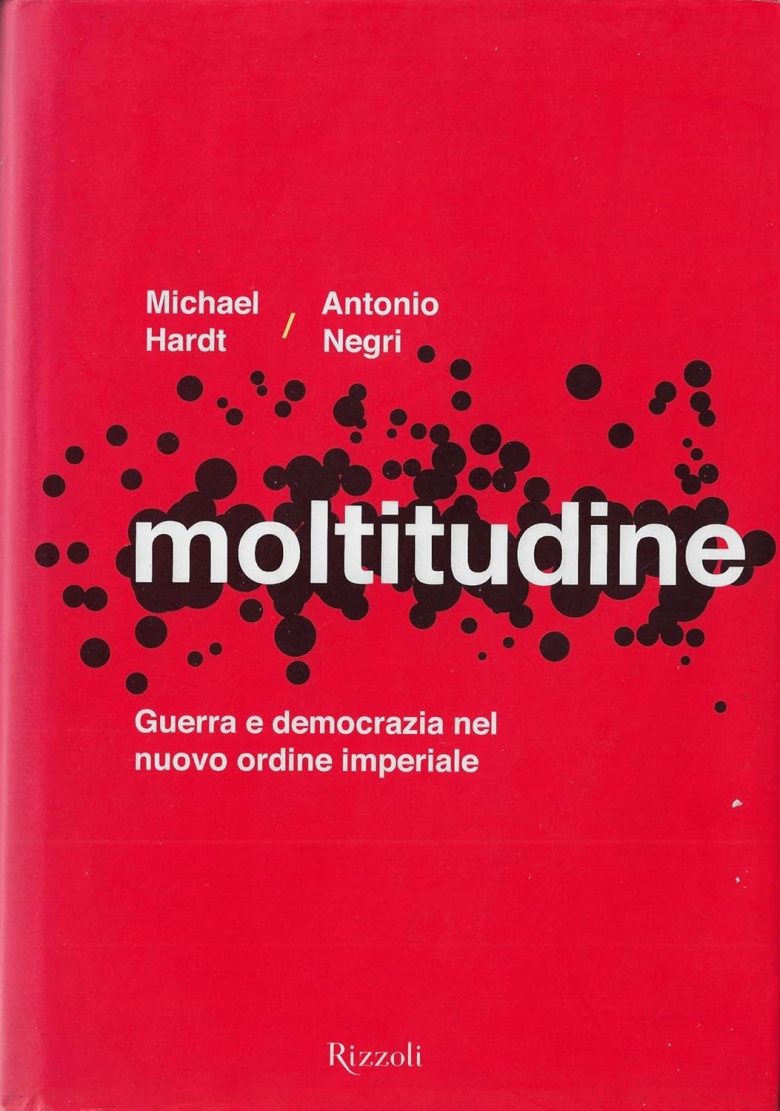
Prima vale la pena cogliere dove stia il nucleo della proposta interpretativa di Handox sulle moltitudini, un attore collettivo che indubbiamente è tornato nel discorso pubblico. La folla, scrive Handox, spesso ci appare una condizione da evitare: immersi in una massa di persone, abbiamo l’impressione di veder aumentare i condizionamenti, di perdere la capacità di controllo e le possibilità di fuga. In breve, l’immagine della folla è quella della perdita di autonomia. Tuttavia, aggiunge, “ci uniamo alla folla perché là dentro, in mezzo a tutto quel caos e movimento, troviamo qualcosa di fondamentale per la nostra natura umana. Esaltati e ispirati dai nostri compagni di viaggio, veniamo travolti da una marea emotiva. Le debolezze individuali scompaiono: diventiamo più grandi della somma delle nostre misere arti”. E conclude: “Appartenere a una folla ci rafforza e ci elettrizza; alimenta l’autostima e afferma la nostra identità”.
Quella condizione, precisa Handox, non riguarda solo le istanze di movimento sociale nate all’interno di lotte per i diritti, ma riguarda anche le folle urbane, spesso accusate di violenza, ma che sono la molla della socializzazione dei grandi eventi: dalle esposizioni alle fiere, ai momenti pubblici collettivi legati alle varie settimane della moda, del libro, e quant’altro. Si esprime nella partecipazione a eventi collettivi, come concerti, manifestazioni di strada, partite di calcio o di rugby. Le folle del tifo calcistico, spiega, non sono solo “spettatori”, ma costituiscono uno stimolo al gioco e proprio per questo sono parte integrante della partita: consentono alla squadra di rispondere a delle richieste, di percepire l’attesa di un risultato richiesto e dunque appunto per questo non sono solo occhi che guardano, ma stimolo del gioco.
Handox, proprio in relazione al tema del rafforzamento dell’identità, sottolinea la fisionomia delle folle autoritarie, le quali si muovono in relazione a due aspetti: da una parte non prendono l’iniziativa dell’azione in autonomia, ma rispondono a una convocazione dall’alto; dall’altra si fondano sull’identificazione assoluta con un leader carismatico. Il riferimento più recente (la prima edizione del libro è del 2024) è l’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. Contemporaneamente, ricorda come gran parte della retorica sulla violenza delle folle, e dunque sulla necessità di governarle e di “incapsularle”, nasca dall’esplosione delle folle rivoluzionarie che improvvisamente irrompono sulla scena della Storia soprattutto a metà Ottocento e, in particolare, al tempo della Comune di Parigi (marzo-maggio 1871).
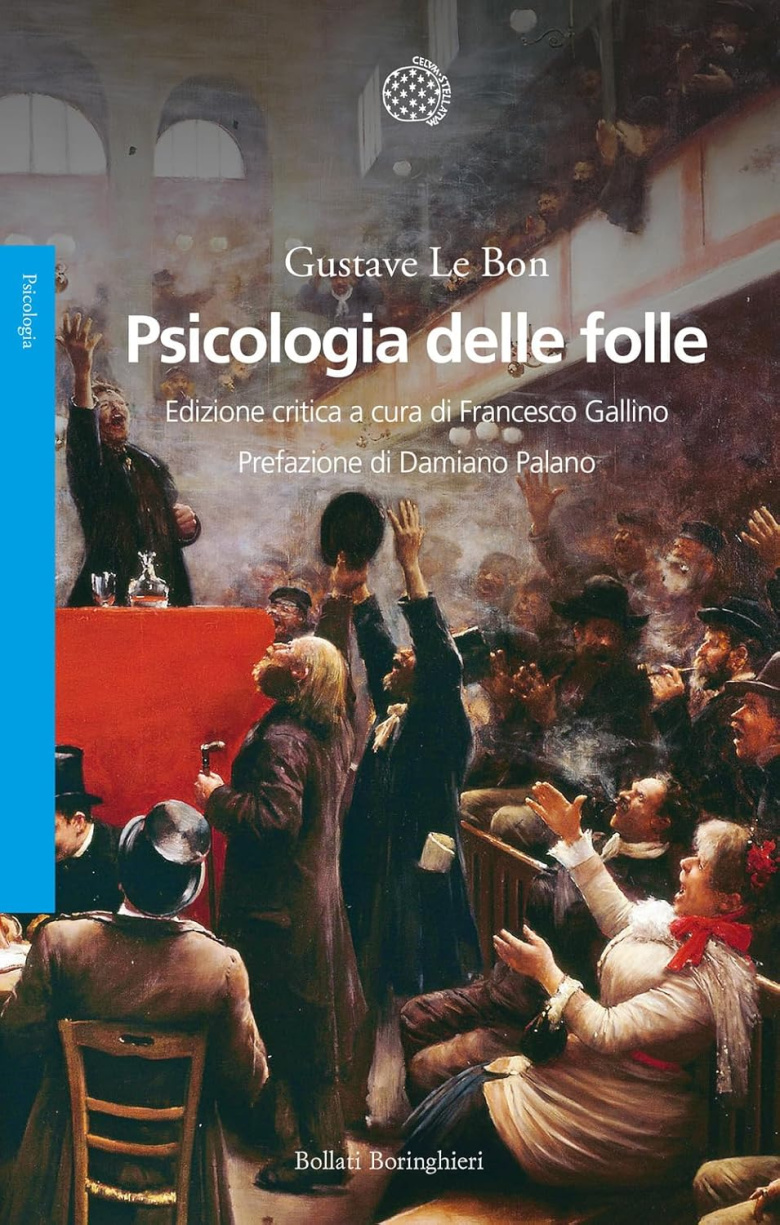
Qui si innesta il richiamo costante che, nel corso del suo libro, Hancox fa al saggio di Le Bon, che egli interpreta come la risposta al panico di fronte all’emergere delle folle. Ora, se è vero che per Le Bon, come richiama Damiano Palano nella prefazione alla nuova edizione Bollati Boringhieri, “le folle sono come la Sfinge della favola antica: bisogna imparare a risolvere i problemi che la loro psicologia ci pone, o altrimenti rassegnarsi a esserne divorati”, è anche vero, scrive Francesco Gallino nell’introduzione al medesimo volume, che la Psicologia delle folle “ci offre validi strumenti per riflettere su alcuni tratti tipici del XXI secolo. Si pensi all’online. Le pagine sulle pièce teatrali (...) sono perfette per ragionare sui meccanismi della viralità. Mentre l’intuizione secondo cui una folla per essere tale non necessita di vicinanza fisica, ma soltanto di stimoli analoghi e simultanei, rende il testo eccezionalmente adatto a riflettere sulla politica ai tempi delle «bolle» social (...)”.
Le pagine di Le Bon, continua Gallino, sono fondamentali, per il lettore di oggi, almeno intorno a due diverse questioni. La riflessione di Le Bon muove non tanto dalla comparsa delle folle come attori collettivi, quanto dalla necessità di non potervi rispondere con la repressione, né con l’instaurazione del regime di eccezione: il suo saggio, infatti, non auspica l’abolizione del voto popolare, bensì un uso accorto delle parole da usare per stimolare, governare e guidare la partecipazione. La folla è per Le Bon un’entità irrazionale e tendenzialmente violenta, costituita intorno a un «trascinatore»: “figura terribile, piena di fascino che parla in modo semplice e ripetitivo, evoca immagini forti ed è in grado di infondere una fede fanatica (religiosa, politica o militare che sia)”.
Si tratta di una dinamica che Georges Lefebvre, nei suoi saggi sulle folle rivoluzionarie, aveva messo al centro della sua ricerca storica. L’oggetto di indagine è la folla che si riunisce casualmente per strada, formata dalle persone e dalle professioni più diverse, e che decide di compiere un’azione, di esprimere una protesta o rivendicare un diritto dopo essersi formata. L’ipotesi di Lefebvre risente dell’epoca in cui venne formulata, gli anni Venti e Trenta del XX secolo: epoca di masse organizzate e disciplinate dai regimi totalitari, ma anche delle masse, altrettanto ordinate e passive, dell’incipiente società dei consumi.
Il tema rimane comunque il medesimo: come si agisce in base a ciò che si crede? Come si forma un’opinione? Sulla base di una consuetudine, o a partire da uno scambio di opinioni che si consolidano, confermandosi e compattandosi insieme?
Tema, quest’ultimo, che nel nostro tempo non è solo inaugurato dalla fine del partito politico di massa, ma dai fenomeni di assembramento, non autorizzati, dalla volontà di superare il distanziamento imposto e normato nel tempo della pandemia.
Improvvisamente si sono formate folle e sono tornate a formarsi, proprio in assenza di una struttura come il partito politico. Si sono formate “andando in strada”, scambiandosi opinioni e riflessioni che avevano dietro la condizione di isolamento e con la convinzione che già solo l’atto di trovarsi e di parlarsi fosse un segno di vitalità e di sottrazione al dominio. Condizione ed emozioni che hanno contribuito in misura non marginale alla definizione di un vissuto complottista del tempo presente, come piattaforma per riprendere nelle proprie mani il destino che si teme qualcuno voglia imporci o come replica per dire “Io non subisco”. Non solo una replica che raccoglie l’eredità dell’urlo di Antonio Gramsci contro l’indifferenza nel febbraio 1917, ma che si propone come replica alla condizione di apatia su cui aveva fatto i primi passi della sua scrittura pubblica il giovane Piero Gobetti nelle settimane immediatamente successive alla fine della Prima guerra mondiale. Era il dicembre 1918. Quel testo si intitola Commenti e giustificazioni. Vale la pena rileggerlo.