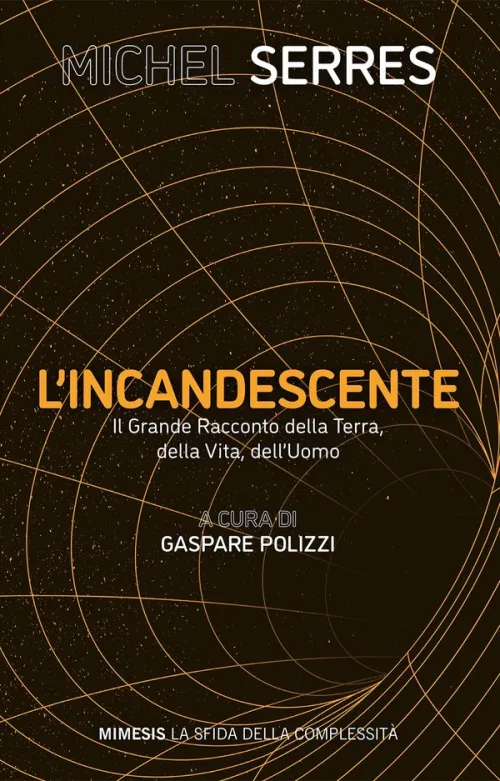Michel Serres: la terza cultura
Una bambina di tre anni gioca nel prato davanti alla fattoria costruita dai suoi antenati ai primi del Novecento sulle rovine di un antico mulino, dove una volta sorgeva un monastero e prima ancora un tempio pagano. Il tempo breve dell’esistenza e della storia si staglia sullo sfondo delle montagne pirenaiche, da sempre immobili agli occhi degli abitanti del luogo. Nel sovrapporsi degli strati rocciosi vediamo però scorrere un altro tempo, quello lungo dell’orogenesi, in parte nascosto sotto le nevi che dicevamo perenni ancora qualche decennio fa, prima che il clima sciogliesse i ghiacciai sotto il Sole, stella di cui oggi prevediamo la futura scomparsa. Eccoci immersi, fin dalle prime pagine di L’incandescente (2003, Mimesis, 2025, traduzione di G. Polizzi e G. Baldrati, a cura di Gaspare Polizzi), in quello che Michel Serres chiama il Grand Récit: le scienze contemporanee – dalla chimica all’astrofisica, dalla biologia evolutiva alla geologia –, maestre nell’arte delle datazioni, ricostruiscono una scala temporale che scorre, come una cascata dai mille rivoli, verso di noi, umani che portiamo scritta nei nostri geni la memoria delle metamorfosi dei viventi. Un estratto del “Grande Racconto” è raccolto nel numero 35 della rivista “Riga” dedicato a Michel Serres (Marcos y Marcos, 2015, a cura di Mario Porro e Gaspare Polizzi, al quale spetta il merito di aver promosso la conoscenza del pensiero serresiano in Italia).
La nostra storia, che impropriamente datiamo dall’avvento della scrittura in poche migliaia di anni, affonda le sue radici nel processo evolutivo che la natura, non solo quella vivente, ha percorso prima di noi: dall’origine dell’universo, 14 miliardi di anni orsono con il Big Bang (se vi fu), attraverso la formazione del sistema solare, fino alla comparsa della vita sulla Terra (quattro miliardi) che condusse, lungo un intrico cespuglioso di sentieri a Homo sapiens. Ma noi continuiamo a vivere in quella che Serres definisce, citando Fontenelle, l’illusione del giardino: “de mémorie de rose, jamais l’on ne vit mourir de jardinier”; permane in noi la credenza che la civiltà si svolga sullo sfondo di una geografia immutabile, quando invece “una successione di mille fontane dai ritmi diversi” traccia il fluire eracliteo dell’intero universo. Non siamo i soli a poterci dire mortali: sul nostro corpo si scrivono le ferite del tempo breve che ci è dato, ma esso conserva le tracce della lunga durata dell’evoluzione cromosomica che lasceremo in eredità ai nostri figli. Condividiamo gli strati più arcaici del nostro cervello con i rettili e le scimmie, anch’esso è stratificato come gli archivi della Terra sulle pareti rocciose; i batteri e i virus che ospitiamo nell’organismo – ha spiegato la biologa Lynn Margulis – risalgono ai primi tempi dell’apparizione della vita.
Rabelais forgiava ai primi del Cinquecento il vocabolo “enciclopedia” per indicare la circolarità dei saperi che si sovrappongono ad anello al mondo, nell’illusione di esaurirlo; era l’epoca in cui Mercatore rinchiudeva in una proiezione cilindrica la Terra conosciuta. Il Grand Récit si distende invece in un paesaggio variegato di spazi sovrapposti, sui quali oggi leggiamo una “cronopedia”: le morfologie del paesaggio e degli organismi che lo abitano ricapitolano il cammino contingente dell’evoluzione cosmica, una sirresi di tempi che percolano gli uni negli altri, come un fiume che scorre su più letti. La doppia elica del DNA agisce da sonda temporale: i cromosomi si fanno “cronosomme”, su cui possiamo leggere le tappe delle mutazioni, la singolarità di ogni specie e dei gruppi umani. All’angoscia pascaliana di fronte agli spazi infiniti succede quella che proviamo di fronte al mosaico dei ritmi dell’universo. “Non la si fa mai finita con lo spazio. Non si parla mai che di esso e in esso. Non lo si abbandona mai. Per andare dove, vi chiedo? Il tempo è l’energia che lavora lo spazio”, scriveva Serres in Esthétiques sur Carpaccio (1975, Hopefulmonster, 1990).
L’Incandescente si chiude con un appello pedagogico, lanciato tramite l’Unesco e rivolto alle Università di tutto il mondo, affinché si diffonda, attraverso Il Grande Racconto unitario di tutte le scienze, un ceppo comune del sapere. L’eredità milionaria (in termini di anni) che abbiamo ricevuto val bene una dichiarazione universale che sancisca l’uguaglianza naturale, quella “democrazia creaturale” che era di Francesco. È qui che approda il percorso intrapreso da Serres fin dai primi anni Sessanta: nel riconoscimento di una “carta dei diritti delle cose”, nella proposta di un “contratto naturale” (Feltrinelli, 1990), che all’antico dominio parassitario sostituisca un rapporto di reciprocità fra l’uomo e il mondo. In nome di un realismo “duro”, che rifiuta di considerare le cose come nostra rappresentazione o costruzione, Serres ricorda che i nostri sensi non aprono il corpo al mondo, lo fanno discendere verso una durata immemoriale, verso ambienti e cronotopi arcaici. La nostra cultura, amnesica e acosmista, dimentica che le sue radici sono nelle cose (in questo, il progetto serresiano è accostabile all’oggettologia proposta da François Dagognet), che le funzioni di cui la nostra specie orgogliosa si vanta sono già attive nel mondo: la scrittura ci precede, gli organismi viventi portano memoria e trasmettono informazioni, la materia che vorremmo inerte è sede di scambi e comunicazioni. Si tratta di costruire una “terza cultura” che, prendendo distanza dal buco nero della soggettività e dall’esclusiva attenzione ai rapporti sociali, possa rivolgersi alla formazione stessa delle cose, al caos del clima, al fremito dei viventi, insomma al nostro habitat globale. “Abbiamo trasformato o sfruttato il mondo a sufficienza, è giunto il tempo di comprenderlo. O meglio di comprendere che comprende”, scriveva Serres in Atlas (1994).
La “filosofia naturale” del filosofo francese recupera il senso originario del verbo latino nascor, nascita ed emergenza del nuovo: la Natura appare allora come l’integrale indefinito di tutte le biforcazioni attraverso le quali è transitato il grappolo esplosivo del Grande Racconto. E il divenire degli umani segue lo stesso andamento dell’evoluzione naturale: non la traiettoria lineare determinata dalle condizioni inziali, ma un percorso d’infinite biforcazioni contingenti all’interno di uno spazio-tempo a più dimensioni. È la logica processuale su cui il pensare di Serres, sul crinale fra le scienze, la letteratura e le arti, si è soffermato di continuo, a partire dalla riflessione sulla molteplicità nel pensiero di Leibniz; è il tema dei saggi raccolti negli ultimi due volumi della serie Hermès, La distribution (1977) e Il passaggio a Nord-Ovest (Pratiche, 1984), un “pensiero della complessità” che si rivolge al formarsi dell’ordine a partire da una distribuzione caotica, un processo che si può dire a più voci, nel lessico termodinamico di Ilya Prigogine o in quello della vittima sacrificale di René Girard, amico e collega a Stanford. L’evoluzione procede per suspense e rotture, equilibri punteggiati interrotti da brusche variazioni; è la logica stessa della narrazione (récit), così isomorfa a quella della vita, nell’opera di Jules Verne e di Émile Zola, o nella rilettura, in Genesi (Il melangolo, 1988), del racconto di Balzac “La belle noiseuse” (Il capolavoro sconosciuto). I modelli elaborati dall’atomismo antico sul formarsi di vortici nei mezzi fluidi (Lucrezio e l’origine della fisica, Sellerio, 1980) sono ripresi per la comprensione della storia di Roma (1983, Mimesis, 2021) e tornano di continuo nelle pagine dell’Incandescente.
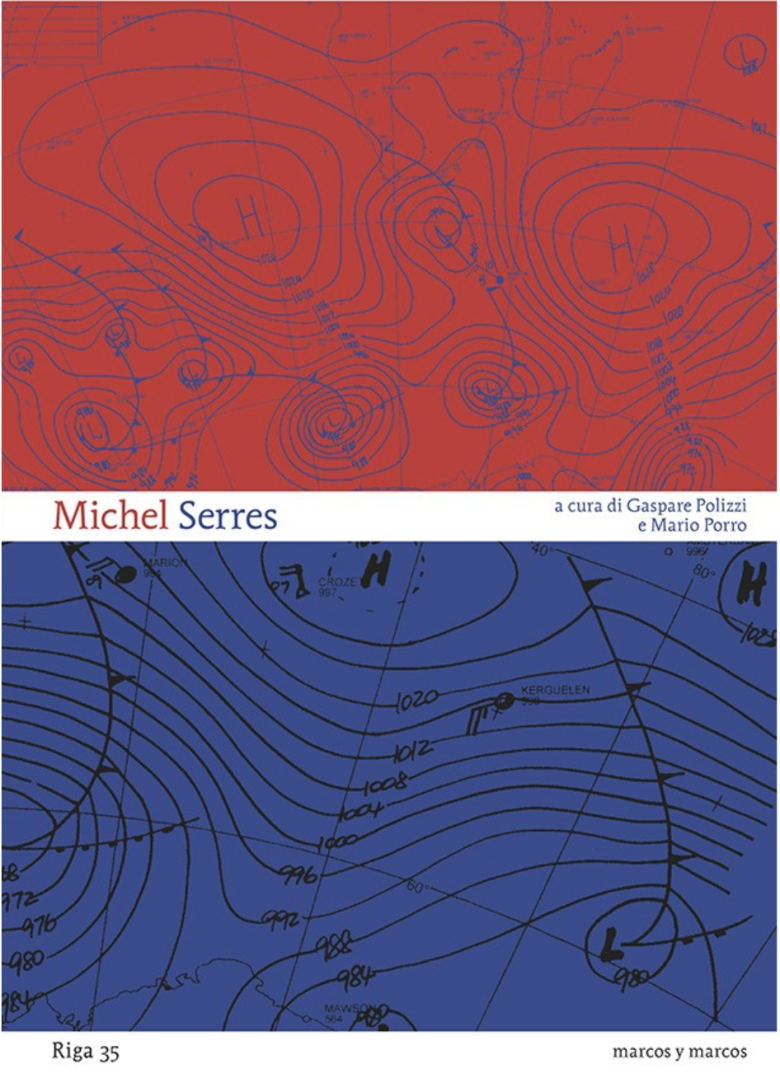
Quest’ultimo libro recupera soprattutto la trasformazione antropologica, tematizzata nel testo forse più significativo dell’ultima fase di Serres (morto nel 2019, all’età di 88 anni), Hominescence (2001). Il neologismo “ominescenza”, ad indicare un differenziale dell’evoluzione (al pari di “adolescenza”), si sofferma sulla mutazione, innescata dalle novità della tecnoscienza, che ha dato nuova forma agli antichi legami con il corpo, con il mondo e con gli altri. Tra i “felici pochi” dell’Occidente, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, si è prodotta una sorta di liberazione dalle costrizioni corporali: alla crescita della speranza di vita si accompagna la cancellazione del dolore che rende obsolete le antiche morali della sopportazione. La nascita e la morte non sono più affidate alla sorte di una natura matrigna, sono diventate culturali nel senso che le abbiamo addomesticate; le biotecnologie pongono nelle nostre mani la nascita d’individui e specie, da naturati siamo diventati naturanti, non più sottoposti alla necessità ma possibili “creatori”, al punto di modificare la direzione dell’evoluzione, non più intervenendo sulla selezione ma sulla mutazione. Dopo Hiroshima però, la morte non è solo individuale, è diventata globale e dipende da noi, sotto forma di catastrofe nucleare o di lenta riduzione della biodiversità. Finita l’epoca in cui l’agricoltura era l’attività dominante, quando si viveva nella codomesticazione dell’uomo con animali e piante, al vecchio Homo faber, la cui efficacia si esercitava solo localmente, si è sostituito Homo universalis (“volto tutto in una direzione”, suggerisce l’etimo), la cui azione ha un potere globale d’intervento sugli uomini e le cose, si tratti di beneficio o di sterminio.
“La storia globale entra nella natura; la natura globale entra nella storia: ecco qualcosa di veramente inedito in filosofia”, scriveva Serres nel Contratto naturale; gli oggetti che produciamo sono sempre più ibridi di natura e cultura (tema caro a un discepolo di Serres, Bruno Latour). I nuovi sistemi di comunicazione, dal computer agli smartphone, annullando le distanze spazio-temporali con i nostri simili, ci hanno reso ubiqui, un aggettivo che un tempo era riservato a Dio. Mai era accaduto che disponessimo di mezzi così potenti ed efficaci per cambiare il mondo e noi stessi, per poi dipendere dalle cose che abbiamo prodotto. Serres definisce “exo-darwinismo” il processo grazie al quale le nostre funzioni vitali vengono portate all’esterno dell’organismo: dal martello al computer, gli strumenti tecnici, inerti e intelligenti, migliorano le nostre prestazioni e proseguono il nostro percorso evolutivo. L’umano si caratterizza infatti per la capacità di metamorfosi, è l’unico vivente in via di auto-evoluzione al punto di diventare soggetto attivo dei propri cambiamenti, sempre nella condizione naturale, cioè alla lettera “allo stato nascente”. Sta in questo il senso di incandescenza: rimanda alla nostra imperfezione biologica, quella neotenia che fa del neonato un feto non pienamente sviluppato. La morfologia del corpo umano testimonia una non-specializzazione che consente l’apertura al possibile: l’imperfezione originaria si traduce in flessibilità e noi, esseri inadatti, siamo diventati “tecnici onnivalenti”.
La consapevolezza di essere immersi nel “tronco comune” del Grand Récit dovrebbe indurci a praticare un umanesimo non più antropocentrico, finalmente degno del suo nome, “unico e universale perché scritto nella lingua enciclopedica di tutte le scienze” e traducibile in tutte le lingue: “cosa aspettiamo – chiede Serres – ad inventare, non un secondo umanesimo, ma l’umanesimo in quanto tale, poiché, per la prima volta nel processo milionario dell’ominizzazione, abbiamo i mezzi scientifici, tecnici e cognitivi, per dargli un contenuto federatore non esclusivo?”. Nuova tappa di quella speranza di pace che la ricerca filosofica di Serres ha sempre perseguito, nel solco del catarismo della sua terra d’origine, il Sud-Ovest della Francia, e certo anche per fedeltà al lascito di Simone Weil, “l’unico filosofo che mi abbia veramente ispirato”, diceva. Ma questo non cancella l’acuta consapevolezza del male che implica l’abbandono delle logiche binarie a cui si affidavano le vecchie metafisiche, l’iconografia del duello, sul modello del san Giorgio in lotta contro il drago, mirabilmente illustrata da Carpaccio sulle pareti degli Schiavoni. Il male appartiene alla vita e al suo destino mortale, l’evoluzione stessa è un processo insieme costruttivo e distruttivo, ma si può comunque prospettare una “soluzione minimale al problema del Male”. La saggezza contadina e la verità scientifica parlano a una sola voce: bisogna acclimatare il male, trasformare il veleno in farmaco, il bacillo in vaccino, “addomesticare” il lievito, come facciamo da migliaia di anni per produrre vino, pane e birra. La salute, ricorda Serres, ha la forma del formaggio, accoglie l’impuro, lo integra e se ne fa forte: a differenza del Nietzsche dell’Anticristo, in cerca di purezza fra i ghiacci montani, lontano dalla “putrida pace” e dalla sozzura del moderno, è il formaggio, non l’oltre-uomo, ad essere “al di là del bene e del male”. Se eliminiamo la sporcizia, finiamo per vivere in uno spazio fragile, un organismo troppo pulito è già sull’orlo della malattia: il Nietzsche spesso infermo non ha compreso che Pasteur ha reso scientifico Mitridate, che non si tratta di tradurre l’arcaico contrasto fra bene e male in quello tra salute e malattia. “L’inferno è la separazione fra il paradiso e l’inferno”, scriveva Serres.
Per evitare di considerare l’altro come il male impuro, occorre sfuggire alla logica dell’appartenenza e dell’esclusione. Ogni nascita passa da un utero, l’unico organo che sfugge alla regola del sistema immunitario di difesa dell’organismo da aggressioni esterne; nell’incandescenza dello spazio bianco di accoglienza penetra l’alterità fino a trasformarlo in mosaico. Nella rilettura laica proposta da Serres delle nostre radici cristiane – in cui si ritrova la lezione di Girard –, il messaggio evangelico opera la separazione dello spirituale dal radicamento terreno: duplice abbandono, del pagus reso sacro dalla presenza delle spoglie dei nostri antenati e del legame di sangue che chiama alla vendetta. Il razzismo ha origine dalla riduzione della relazione d’appartenenza al principio d’identità, rimanda a un’ontologia che riconduce l’altro a un’unica categoria e lo reclude nel collettivo da escludere. Ma la nostra identità non è espressa da una statica definizione, è l’intersezione fluttuante nella durata di una varietà di appartenenze, non l’una o l’altra di esse: siamo tanto più ricchi quanto più moltiplichiamo le nostre relazioni, quanto più la nostra carta d’identità assume i tratti del mantello d’Arlecchino, ci affermiamo come singolari quanto più le mescolanze dei nostri incontri s’imprimono su di noi.
L’arcaico universo microbico oggi è al cuore delle rivoluzionarie tecniche della medicina: sappiamo trasformare i parassiti in alleati, con le pratiche vaccinali e la bio-ingegneria, il nostro corpo diviene un “biosoma”, un corpo comune a tutto ciò che vive. Nuova contingenza, di cui non prevediamo l’esito. E “monumento alla contingenza” sarà Rameaux (2004), apparso l’anno dopo L’incandescente: stiamo entrando in una nuova “ramificazione” evolutiva, nella biforcazione in cui oscilliamo incerti fra la comparsa di un nuovo uomo e la scomparsa dell’umanità. La filosofia di Serres gioca sulle preposizioni e sugli avverbi al fine di designare lo spazio-tempo della nostra epoca, varietà topologica affidata all’incerto: il suo pensiero delle relazioni non fa ricorso al “contro”, l’ob- dell’oggetto e dell’ostacolo, al “non” che era di Bachelard e della dialettica, invita a vivere “con” (syn), a praticare la simbiosi anche con il parassita, che si pone “accanto” (para) all’alimento. Tutto si gioca agli incroci, dove siede Ermes, dio della comunicazione e dei commerci, nel “tra” delle transizioni, nel punto di tangenza, “contingenza” in senso letterale, incrocio inatteso e casuale, dove catalizzatori ed intermediari si fanno vettori del nuovo. La sostanza e l’identità sono l’esito di circostanze (quel che sta attorno all’istanza), svolte da cui s’irradiano a stella possibilità inattese, senza che si possa sapere cosa promette il loro divenire. La conversazione associa cum e versus: una molteplicità d’interlocutori forma una rete fluttuante di scambi, vettore munito di una freccia e di un angolo d’inclinazione, clinamen lucreziano che indica un cambio di direzione e di senso (del moto e del discorso). “Il cammino della storia non è quello di una palla di biliardo che una volta partita segue una certa traiettoria, ma somiglia al cammino di una nuvola, a quello di chi va bighellonando per le strade …”, scriveva l’ingegnere-filosofo Robert Musil. Il suo procedere vorticoso segue le dinamiche caotiche del volo degli storni, un modello in cui il pensiero serresiano ritrova gli studi del premio Nobel Giorgio Parisi e le descrizioni del signor Palomar/Calvino dalla terrazza romana. Così funziona anche il pensiero: nessun verbo lo esprime meglio di cogitare, un succedersi di agitazioni rigorose e aleatorie insieme, simile all’azione di guidare (agere) greggi disperse e riunite (cum) dal pastore.
Leggi anche:
Mario Porro, Michel Serres, o della gioia di pensare
Mario Porro, L'ultimo dono di Michel Serres
Francesco Bellusci, Michel Serrs. Pollicina ci salevrà da populismo
Gianfranco Marrone | Michel Serres: Mercurio e la comunicazione
Francesco Bellusci | Il parassita di Serres: la relazione come dono
Mario Porro | Michel Serres, Roma. Il libro delle fondazioni
Michel Serres | Michel Serres, l’arte di scrivere