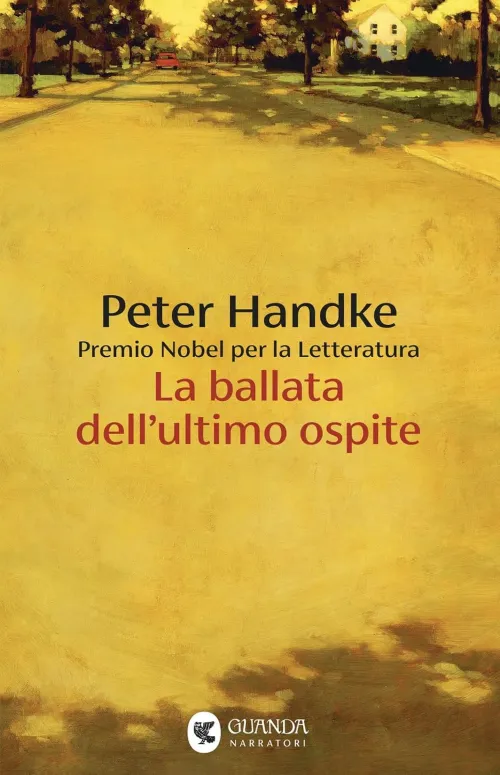Peter Handke torna a casa
Ma chi l’avrebbe mai detto che quel giovanotto provinciale, nato nel deep South dell’Austria in un villaggio di confine con la Slovenia, e cooptato nel Gruppo ’47, avrebbe attaccato nel 1966, nella riunione annuale in scena a Princeton, così ruvidamente e senza alcun riguardo i ‘grandi’ della letteratura tedesca, tra cui Böll, Grass, che negli anni seguenti ricevettero il Premio Nobel, un premio che Handke, in un’esaltazione polemica, criticò duramente, ma che nel 2019 accettò pur volentieri. In mezzo secolo si cambia. Insomma la coerenza non è una sua virtù. La conferma è sempre del 1966 quando nel suo primo dramma, Insulti al pubblico, se la prese direttamente con gli spettatori. Questi atteggiamenti si spiegano nella disperata ricerca del giovane scrittore d’avanguardia di risvegliare lettori e spettatori in nome della letteratura intesa quale esperienza fondamentale della vita e della cultura. Rapidamente Handke, rassegnato, capì la lezione e mutò radicalmente, comprendendo che i giorni della rivolta erano ormai contati. Così iniziò la grande fuga, cominciò a vivere la vita come un espatrio dalla sua terra e da sé. La ribellione venne occultata in un’immersione nel “grande stile”, quello della tradizione ottocentesca e del Primo Novecento, come conferma anche la sua ultima prosa La ballata dell’ultimo ospite (Guanda, pagine 206, € 19, nella traduzione, collaudata e sicura, di Alessandra Iadicicco). Di nuovo uno scrittore tedesco in fuga: «Dev’essere stato un giorno tranquillo di tarda estate o di primo autunno. La persona in questione era in viaggio verso la sua regione nativa», così l’incipit. Di nuovo un Wanderer, un autore in cammino verso la ‘terra dell’interiorità’, il grande spazio della letteratura germanica. Germanica? Non del tutto per quanto riguarda Handke, che è nato in un villaggio austriaco con una forte presenza slovena e slovena era la madre del poeta che per lei, – alla sua memoria tragica: si era suicidata –, ha scritto il suo libro più bello, Infelicità senza desideri, quello che non tramonterà, breve e folgorante. Il tema della madre è una costante di autenticità nella scrittura di Handke, che affiora proprio all’inizio del suo discorso per l’assegnazione del Nobel. Nell’anno del suicidio, Handke aveva intrapreso un lungo viaggio negli USA, durante il quale da un giornale venne a sapere della morte di lei. Il viaggio e il suicidio sono all’origine di due racconti intensi, commoventi e commossi, tra i migliori dello scrittore austriaco e tra i più intriganti e struggenti della letteratura di lingua tedesca contemporanea. Dal viaggio nasce nel ‘72 il racconto Breve Lettera del lungo addio. È un testo autobiografico che segna una svolta nella scrittura di Handke, che lascia le pratiche avanguardistiche per immergersi nel magma narrativo sospinto da una forte tensione interiore, alla ricerca di un senso, nel gorgoglio del caos, della sua esistenza e della sua esperienza di scrittore. Il racconto partiva da una crisi matrimoniale e dalla curiosità per il Nuovo Mondo per terminare con un’imprevista nostalgia per “Good Old Europe”: il viaggio si tramuta in un percorso di riconoscimento e ritrovamento e così il giovane provinciale realizza la scoperta della propria identità austriaca e mitteleuropea. Eppure la conciliazione adombrata fu di breve durata: di nuovo lascia l’Austria per trasferirsi definitivamente in Francia, nei pressi di Parigi. La sua scrittura si trasforma lentamente in un percorso senza compromessi, in una esperienza poetica unica, che afferra, spaventa, costringe a inoltrarsi sui sorprendenti sentieri dell’essere per giungere infine ai limiti del silenzio, che viene esorcizzato in lunghissime scritture, vieppiù ineffabili. Handke è attratto da questo inoltrarsi nella terra dell’interiorità, alla ricerca di una Mutterland, di una terra madre smarrita. Ed è questa la chiave per comprendere la sua ‘stravaganza’, il suo impegno per la Serbia di Milosevic, un gesto più che politico, disperato, polemico, espresso dalla sua scrittura singolare, disorientante, irritante e sempre avvincente.
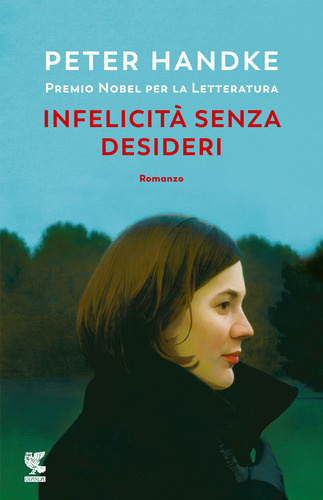
Ora però siamo all’ultima ballata: si avverte un’aria di congedo. Il viaggio porta il protagonista Gregor – il ‘risvegliato’ – di nuovo nella sua terra, ma quel paese dai tanti villaggi è ormai un informe agglomerato metropolitano. È arduo ormai fantasticare di una Heimat, di una patria romantica: l’orto casalingo è definitivamente inselvatichito, la cura degli uomini è andata persa nella corsa affrettata del tempo. Il protagonista visita la sua improbabile famiglia, viene a sapere della morte del fratello e della nascita di un nipotino, figlio della sorella, tutta qui la story. Tutto gli è estraneo perché è lui lo straniero al paese e a se stesso, l’outsider, il girovago inesausto, tutto sommato ripetitivo. Quello che lo interessa ancora è la sapiente osservazione dei particolari. Così si trasformano in esperienze, acquistando un’imprevista intensità, che costituisce lo stile di Handke. È in questo attento lavoro stilistico che avviene la graduale metamorfosi della sua prosa in liricità, in cui i ricordi d’infanzia svaniscono, si scolorano: presente e passato s’intrecciano nell’esperienza unica del soggetto, sfumano, perdono i contorni esuberanti della realtà e così si sollevano a poesia, animata da una sottile musicalità, che risuona persino nella bella traduzione. Nella Ballata c’è tutto Handke: le sue riflessioni, il suo vagare per la città, preferibilmente di notte, in una scrittura diaristica – quella handkiana da anni. Alcuni critici tedeschi registrano che il viaggio dello scrittore è ormai alla fine, altri a ragione esaltano questo linguaggio libero, mai giornalistico, lontano dai romanzi d’inverosimili avventure, dai thriller scandinavi o partenopei, dai memoir di struggente nostalgia. È il ben noto sound della scrittura intima, sommessa, di Handke, è lo smarrimento nel mondo. Per chi lo ama è una conferma che l’antico slancio non è andato perduto. Certo il titolo per un autore nato nel dicembre 1942 assomiglia a un addio: il commiato dell’ultimo ospite di una grande stagione letteraria –quella della Bachmann e Bernhard, per restare in Austria –, di una languida ballata, a mo’ d’estremo saluto. A chiusura del libro, si ha l’impressione di averlo già letto poiché da anni Handke scrive sempre lo stesso libro, o meglio scrive la sua scrittura eccezionale, avvincente, in un tedesco raffinato, lavorato, che ha perso concretezza e spigolosità per avvicinarsi con un movimento asintotico a pura esperienza linguistica, quasi sollevata dal «centro di gravità permanente», per raggiungere una libertà, libertà sempre a rischio, fragile e insieme vicina alla poesia quale esperienza metastorica. Non a caso, al centro del romanzo, lo scrittore rievoca Odisseo e Euriclea, la fida ancella che dalla ferita lo riconosce. Dalle nostre ferite saremo riconosciuti, pare suggerire lo scrittore.
Leggi anche:
Luigi Grazioli | La vendetta perfetta di Peter Handke
Fabrizio Sinisi | Peter Handke. Attacco al sistema
Luigi Grazioli | Handke scrittore di saggi
Marco Ercolani | Peter Handke: un impressionista sonnambulo
Enrico Filippini | La caffettiera e l'estasi
Luigi Grazioli | Il Nobel a Peter Handke