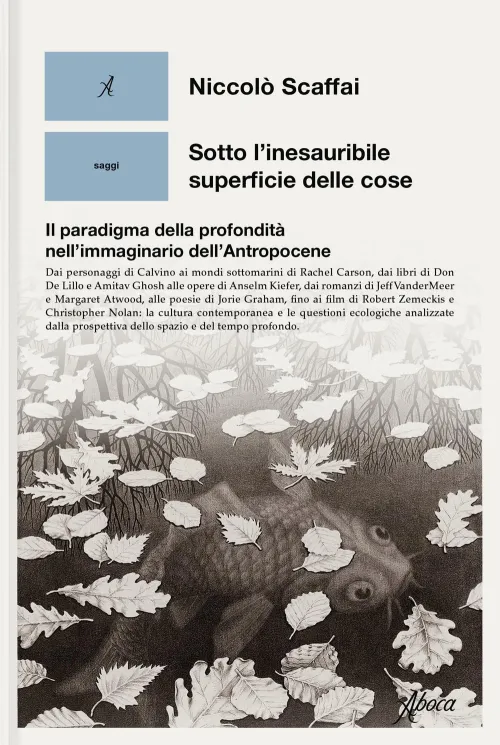Antropocene e paradigma della profondità
"La conoscenza procede sempre attraverso modelli, analogie, immagini simboliche”. Così scriveva Italo Calvino nel recensire sulle pagine di “Repubblica” L’occhio e l’idea di Ruggero Pierantoni – lo studioso della percezione da poco scomparso –, una storia dell’ottica scandita dal succedersi di modelli della visione. Che la mente umana, nella scienza come nella poesia, funzioni solo in base a “codici mitici” era convinzione già formulata nel “Protocollo della riunione tenuta a Bologna nel dicembre del 1968”, steso da Gianni Celati, nella fase di progettazione di una rivista che non vedrà mai la luce (“Alì Babà”. Progetto di una rivista 1968-1972, a cura di M. Barenghi e M. Belpoliti, “Riga” 14, Marcos y Marcos, 1998, di cui si annuncia prossima una ristampa ampliata). È alla letteratura che lo scrittore sanremese affida il compito di discutere e contestare le coppie d’immagini che risalgono alla prima esperienza umana: “il sopra, il sotto; il dentro, il fuori; l’inverno, la primavera”. Anche la coppia superficie-profondità ha dietro di sé una “lunga ombra simbolica”, avrebbe detto Primo Levi; ha contribuito a promuovere il tessuto verticale e gerarchico su cui la metafisica si è edificata, opponendo gli ingenui, che si fermano alle apparenze, ai sapienti (filosofi, sacerdoti o scienziati) che squarciano il velo delle illusioni e consentono alla verità di rivelarsi.
In Sotto l’inesauribile superficie delle cose. Il paradigma della profondità nell’immaginario dell’Antropocene (Aboca, 2025), Niccolò Scaffai, docente all’Università di Siena, offre un ricco campionario dei modi in cui la letteratura contemporanea intreccia il motivo della profondità e l’accelerata ingerenza dell’attività umana sui processi bio-geologici. Se è vero che nei ghiacci islandesi troviamo ancora le tracce degli scarichi emessi dalle fornaci arcaiche dell’età del bronzo, solo da pochi decenni Homo universalis ha compiuto il salto dal locale al globale, fino a sconvolgere gli equilibri planetari e, potenzialmente, distruggere la Terra. In un racconto del ’74, “La pompa di benzina” (poi nella raccolta postuma Prima che tu dica pronto), Calvino costruiva un cortocircuito temporale che dalla “crisi petrolifera” risaliva alle “ore meridiane del Cretaceo”, quando una pioggia leggera di detriti vegetali e animali, “masticata dalle mascelle delle rocce calcaree”, formava i depositi da cui avremmo estratto il greggio: quel che si era costituito nella lunga durata della “memoria del mondo” subiva l’assalto della miope velleità di sfruttamento della natura. I Racconti del pianeta Terra di Margaret Atwood (a cura dello stesso Scaffai, Einaudi) immaginano gli scenari di un futuro senza petrolio e i possibili squilibri socio-politici che ne derivano. Gli strati del sottosuolo non servono solo ad estrarre combustibili, in essi abbandoniamo all’oblio gli stoccaggi degli scarti, scorie tossiche o rifiuti nocivi delle ecomafie. Terre contaminate e “terre di sangue”, in cui occultare le vittime dei tanti crimini che hanno segnato il Novecento: foibe del Carso e fosse comuni di Katyn, sottosuoli dei campi di sterminio e dei gulag, da cui ancora esumare resti umani, a Srebenica o nel deserto di Atacama in Cile (sede di un radiotelescopio), dove servirebbe un telescopio al contrario per ritrovare i corpi dei desaparecidos della dittatura di Pinochet. Un inconscio materiale della rimozione storica collettiva: non è forse la storia “la somma totale delle cose che ci tengono nascoste”, scrive Don De Lillo in Underworld (1997, Einaudi), narrazione sotterranea della guerra fredda. Il motivo dominante del romanzo è quello delle scorie: il protagonista si rende conto di percepire ogni cosa “in termini di spazzatura”, anche le merci luccicanti sugli scaffali dei negozi, feticci della civiltà dei consumi cioè dei rifiuti, come ricorda Marco Armiero, L’ero degli scarti. Cronache dal Wasteocene, la discarica globale (Einaudi, 2021): la materialità degli scarti si connette alle relazioni sociali che producono esclusi, in tal senso le discariche appaiono l’emblema più concreto di ogni ciclo economico, ha scritto Roberto Saviano in Gomorra, nel capitolo dedicato alla “terra dei fuochi”.
Non è casuale, rileva Scaffai, che l’allegoria della profondità come sede di trame criminali occulte si ritrovi nell’incompiuto Petrolio, in cui Pasolini evocava le “imprese” di Eugenio Cefis, presidente delle principali aziende energetiche italiane. Da un giacimento di bitume nello stato canadese dell’Alberta si scatenò nel 2016 un gigantesco incendio che distrusse le foreste soprastanti e l’altezza delle fiamme risultò proporzionale alla profondità dei depositi bituminosi (lo racconta John Vaillant in L’età del fuoco, Einaudi). Dallo sfruttamento delle risorse del sottosuolo si promuovono effetti che varcano i confini del nostro pianeta; nel ’59, in occasione di un congresso sull’energia, a replicare alla fiducia interessata di Robert Dunlop sui benefici del petrolio fu Edward Teller, noto per il progetto della bomba all’idrogeno osteggiata da Oppenheimer e ispiratore della figura del dotto Stranamore nell’omonimo film di Kubrick. Da fisico esperto, fece notare che la combustione dei materiali fossili avrebbe condotto alla crescita dell’anidride carbonica nell’atmosfera e il ridotto assorbimento delle radiazioni infrarosse emesse dalla Terra avrebbe provocato l’“effetto serra”.jn
La preziosa rassegna proposta da Scaffai evidenzia una discontinuità tematica rispetto all’immaginario antico e moderno della profondità: il registro del meraviglioso o del fantastico caro a Jules Verne e alla letteratura per l’infanzia (o all’infanzia della letteratura) si ritrova nelle cavità sotterranee abitate da esseri malvagi e inquietanti, come nel ciclo di Tolkien, o nelle quali sopravvive l’umanità superstite di un mondo post-apocalittico trasformato in rottame. Vi si scorgono le tracce di quella immaginazione intimista che Gaston Bachelard indagava in La terra e il riposo (1948, Red, 1994): tornare nel grembo della madre terra equivale ad affidarsi a una morte profonda da cui si può rinascere. L’immaginario contemporaneo degli spazi sotterranei o sottomarini sviluppa invece il motivo della catabasi in termini realistici, propone una scienza-coscienza del sistema della natura: esorta ad uscire, secondo la formula di Calvino, dal “parochialism antropocentrico”, “da ogni teleologia umanistica”, suona come invito a integrare “il limitato aneddoto d’ogni vicenda umana” nel mosaico della “storia della materia”, nel percorso di un’evoluzione che non è solo quella del vivente, ma dell’universo intero. La profondità non nasconde un mondo altro, ma rivela i principi su cui si regge questo mondo, ne offre una spiegazione, se non una previsione. Guardare verso il basso – in senso contrario al sogno della modernità prometeica di giungere su Marte, ricordava Bruno Latour – aiuta ad assumere consapevolezza non solo della struttura che connette l’umanità alla biosfera, ma anche dell’implicazione tra fattori ambientali e fattori socio-economici.
“Dalla profondità viene un’ipotesi di unità conoscitiva”, ricorda Scaffai: è la direzione suggerita dall’invito della deep ecology di Arne Naess a sviluppare un sé ecologico che riconosca il rapporto di simbiosi con l’ambiente, fino a identificarsi con la natura comune a tutte le cose (si veda il numero 46 di “Riga”, a cura di Franco Nasi e Luca Valera, edizioni Quodlibet). È la consapevolezza che si esprime nella “grande narrazione” che Michel Serres ha proposto, sulla base delle acquisizioni recenti promosse dalle scienze della vita e della Terra, in L’incandescente (Le Pommier, 2003; la traduzione è da poco apparsa per le edizioni Mimesis, a cura di Gaspare Polizzi). La nostra storia non è che l’illusione del giardiniere, scrive Serres, ricordando la formula di Fontenelle, “de mémorie de rose, jamais l’on ne vit mourir de jardinier”: persiste in noi la credenza che l’agire umano scorra su di una geografia stabile, quando invece la breve durata della nostra storia si staglia sul divenire dell’universo materiale, leggibile sugli archivi stratificati delle pareti rocciose, custodi delle tracce del tempo profondo.
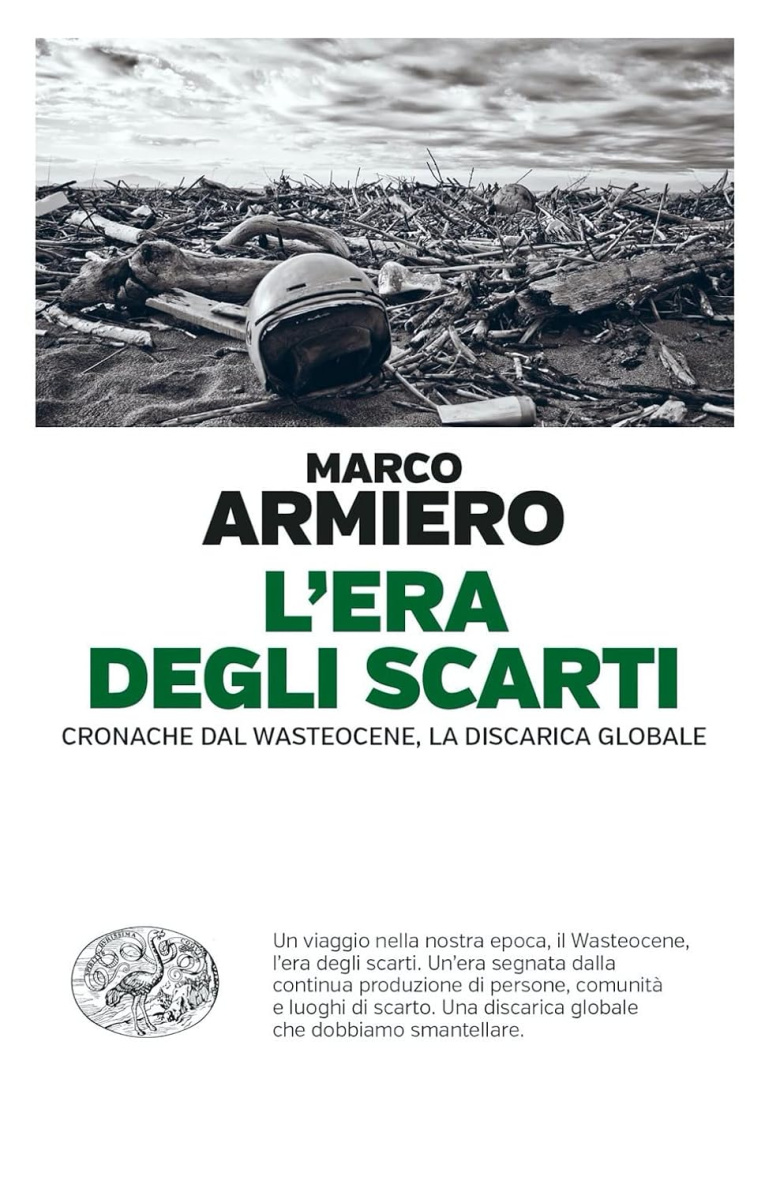
La dimensione narrativa non appare più estranea all’approccio tipico delle scienze. La scienziata-scrittrice Rachel Carlson, una delle voci fondatrici del pensiero ecologico – il suo Primavera silenziosa del 1962 lanciava l’allarme sulla scomparsa degli uccelli canori per la diffusione dei pesticidi –, fra gli anni Quaranta e Cinquanta ha dedicato una trilogia alla profondità del mare; l’esperienza letteraria consente di assumere il punto di vista dei viventi che popolano l’ecosistema marino, un’identificazione simpatetica che diventa una via di accesso alla conoscenza del mondo. Il biologo Carl Safina ha descritto “il viaggio della tartaruga” (Adelphi), una presenza animale che ci rituffa in un passato immemoriale, al tempo del Cretaceo: il sottotitolo, “alla ricerca dell’ultimo dinosauro”, evoca un “tempo profondo” messo in crisi dal cambiamento climatico e dal mare di plastica di cui quella creatura primordiale è spesso vittima. Robert Macfarlane in Underland (Einaudi) ha proposto la prospettiva spaesante di un geologo post-umano che, fra milioni di anni, giunge a visitare il sottosuolo per studiare le tracce lasciate dalla nostra specie: una discesa stratigrafica nello spazio per ritrovare i fossili del nostro presente, scorie nucleari e bottiglie di plastica. È la profondità a restituire al tempo la sua qualità di vettore: c’immerge in una temporalità multipla e fratta, in cui il presente s’interseca con un passato pre-umano e insegue a fatica un futuro che non sia catastrofico. Un tempo intersecato che Scaffai definisce “pre-postero”, di cui è testimonianza il romanzo Doggerland di Elisabeth Filhol (Neri Pozza, 2020): l’ambientazione contemporanea sprofonda nel passato della regione, ora sommersa, che durante l’ultima era glaciale si estendeva nella parte meridionale del Mare del Nord, unendo Inghilterra, Germania e Danimarca. Quel disastro originario si rinnova negli episodi periodici d’inondazione, aggravati dall’estrazione d’idrocarburi: temporalità variegate s’intrecciamo nelle dinamiche di superficie che sconvolgono le acque.
“Dare voce a ciò che non ha voce”, suonava la formula conclusiva delle Lezioni americane: missione di etica ecologica che Calvino affidava alla scrittura e al suo sforzo continuato di assumere un’ottica non-antropomorfa, e che si rende ancor più evidente nella poesia. Lo confermano i versi di Margaret Atwood (Brevi scene di lupi, Ponte alle Grazie) e di Jorie Graham (fast, Garzanti) sui danni della pesca con reti a strascico, la “geografia del disastro” nei paesaggi segnati dalle guerre e dal degrado tecnologico nei versi di Andrea Zanzotto e di Fabio Pusterla, o nella prosa lirica di Antonella Anedda. Sono esempi in cui la poesia dà voce all’intrinseco legame, non sempre armonico, con la natura: un sapere ombroso che mantiene l’aderenza alle cose, invece di porle a distanza come nel conoscere, un sapere integrato nell’ambiente che si affida al corpo e ai sensi per comprendere. “Come potrebbero le mie parole lasciar parlare, senza di me, il mondo senza parola? Posso cancellarmi abbastanza da lasciarlo suonare?”, si chiede il Serres di Biogea (Asterios, 2016), ricordando il rito della Roma antica a cui si dava il nome di Mundus patet, il mondo si apre: festività religiosa che si celebrava tre volte l’anno, quando si apriva una fossa nel santuario di Cerere, dea delle messi e del mondo sotterraneo dei morti. Quando la terra spalanca le sue porte, nelle faglie sismiche o nelle bocche dei vulcani, s’innalza il rumore di fondo del mondo, si avverte la “voce dal Profondo”, come recita il titolo del libro dello scrittore-viaggiatore Paolo Rumiz (Feltrinelli, 2023), evocazione del terremoto in Friuli del 1976. Forse anche i Romani, come diceva Nietzsche dei Greci, erano superficiali, ma per profondità.
Nel dualismo platonico, la caverna era il luogo dell’umanità prigioniera, incatenata alle ombre ingannevoli dissolte dall’uscita sotto il Sole del Vero. Nell’immaginario antico, la discesa agli inferi o all’Inferno aveva valore iniziatico, prova temporanea a cui l’eroe si sottoponeva per risalirne migliore. Oggi, conclude Scaffai, la discesa nello spazio-tempo profondo è ritrovamento del mondo autentico, rivelazione di uno stadio pre-umano, non per esaltare l’eletto ma per riscoprire l’umile condizione terrena, nella continuità che si tesse fra il prima e il dopo di noi. Al Signor Palomar, che volge il suo sguardo all’inesauribile superficie delle cose, Calvino aveva inizialmente pensato di accostare il signor Mohole, partigiano della profondità (lo ha ricordato Marco Belpoliti nel primo degli articoli della serie “Underworld” di “doppiozero”); il suo primo dialogo avrebbe riguardato i sequestri di persona, a confermare l’archetipo della profondità come minaccia e abiezione morale. Il nome era ispirato a un progetto abbandonato di trivellazione elaborato negli anni Sessanta dalla statunitense National Science Foundation. Mohole allude alla discontinuità di Mohorovičić, quella che separa la crosta terrestre dal mantello sottostante, scoperta all’inizio del Novecento dal sismologo e meteorologo croato da cui ha preso in nome. Non è casuale che l’ipotesi sia stata avanzata in seguito a un terremoto avvenuto nel 1909; il tipo di onde sismiche poteva spiegarsi solo con un brusco aumento della densità del suolo a una profondità di una quarantina di chilometri.
Sono le manifestazioni in superficie a consentire di leggere quanto accade in profondità: “la natura ama nascondersi” recita un aforisma di Eraclito, ma il segreto delle scienze della vita e della Terra consiste nell’elaborare procedure “esteriorizzanti” che portino fuori il dentro e lo costringano a esprimersi, a rendersi manifesto. È quanto avviene esemplarmente nella tecnologia della medicina: Carlo Emilio Gadda poteva scrivere in Anastomosi, descrivendo un’operazione chirurgica, che “non vi è legge se non dalle viscere torturate”. Ma oggi, grazie a strategie d’indagine non invasive (dalla radiografia alla scintigrafia), la medicina è diventata un’arte in grado di cogliere, con il suo “simbolismo figurativo”, quel che avviene nel corpo: “Tutta la medicina risiede secondo noi in questa volontà: inventare dei mezzi che consentano di esplorare, d’individuare e di visualizzare le profondità» (François Dagognet, Philosophie de l’image, Vrin, 1984). Anche le scienze contribuiscono a modificare i “nuclei mitici” che strutturano l’immaginario, ad esempio a rivalutare le apparenze, a non leggere più in termini di opposizione gerarchica il rapporto tra profondità e superficie. Alla verticalità prediletta dalla filosofia, a partire dalla tensione platonica verso l’alto per fuggire l’impurità terrena, il medico-filosofo Dagognet ha sostituito indagini sulle dimensioni orizzontali, una morfologia e cartografia esemplificata dal “metodo inventivo” della geomorfologia (Une épistémologie de l’espace concret, Vrin, 1977): sul suolo possiamo leggere l’architettura interna del mondo sotterraneo, tracce dei drammi nascosti con cui il tempo ha scritto sullo spazio. È il metodo che Darwin, nel corso del suo viaggio di esplorazione, ha utilizzato per comprendere il formarsi delle barriere coralline e la conformazione degli atolli: grazie all’esame indiziale delle superfici, il geografo anticipa il teorico dell’evoluzione, ricostruisce la dinamica delle acque e delle terre o le trasformazioni dei viventi, uomo compreso.
Per smembrare Dioniso, il dio dell’infinito succedersi di generazione e corruzione, i Titani emergono da Ctòn, l’oscurità del sottosuolo di contro a Gé, la Terra come superficie visibile; costringono il dio dell’ebbrezza a guardarsi allo specchio, cioè a “fissare” la sua immagine. Ma il mondo sotterraneo non è un ammasso confuso e indistinto, brilla per la sua segreta organizzazione, come sanno gli studiosi dei filoni minerari. “L’ordine regna nelle profondità” e da un granello di sabbia, dalla polvere amorfa e disprezzata, possiamo (es)trarre le opere del tempo, cogliere in un frammento il costituirsi del nostro pianeta. Nel diffidare del “miraggio della profondità che seduce e al contempo acceca il filosofo”, Dagognet ricordava che la superficie non è il superficiale, è l’interfaccia che separa e collega il dentro e il fuori e in cui, come avviene per la pelle, la profondità si esprime: la verità si coglie nelle trame dell’apparenza, tra le maglie della superficie, quando ne sappiamo decifrare il codice.