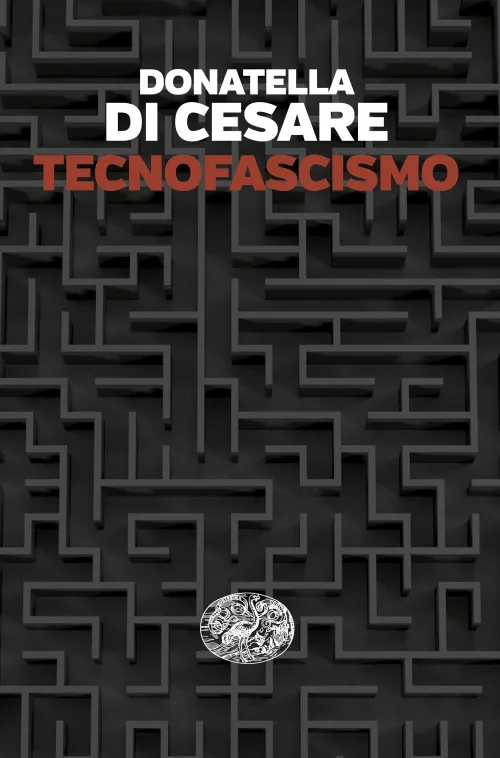Tecnofascismo, morte e modernità
Fascismo, neo-fascismo, post-fascismo, a-fascismo, democrature, autocrazie – fascismo ormai morto e sepolto oppure che risorge in modi nuovi e insieme antichi (Casa Pound, i giovani di FdI di Parma che inneggiano al Duce, il neo-maccartismo, Trump e Musk che sostiene Trump e l’AfD neonazista tedesca, le guerre ai migranti e alle Ong, il neoliberismo, il genocidio a Gaza, il negazionismo climatico), modi spesso così ben mascherati da sembrare libertari come l’anarco-capitalismo.
Piero Gobetti aveva scritto che il fascismo è l’autobiografia della nazione, cioè dell’Italia, ma poi il fascismo si è moltiplicato e diffuso nel mondo e quindi di cosa è l’autobiografia e perché a volte ritorna? E poi, un fascismo o molti fascismi? È un fenomeno politico e sociale (antropologico) oppure il fascismo è forse l’autobiografia della modernità occidentale e industriale, ben nascosto da false libertà e democrazie solo formali?
E nel caso si premettessero neo o post a fascismo, cosa vorrebbero significare? Non abbiamo forse usato troppo facilmente termini e concetti come post-modernità e post-industriale o neo-capitalismo per poi ritrovarci oggi in una società iper-moderna, iper-capitalistica e iper-industrializzata e taylorizzata digitalmente fino al taylorismo cognitivo della IA? E quindi – e ci limitiamo a qualche veloce richiamo preliminare – esiste forse un Ur-Fascismo, come lo aveva definito Umberto Eco, un fascismo eterno, elencandone 14 caratteristiche che certo “non possono venire irreggimentate in un sistema; molte si contraddicono reciprocamente e sono tipiche di altre forme di dispotismo o di fanatismo. Ma è sufficiente che una di loro sia presente, per far coagulare una nebulosa fascista”. Aggiungendo un monito (era il 1995): “L’Ur-Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme, ogni giorno, in ogni parte del mondo”. Oppure andiamo a T. W. Adorno e a quando, nel 1950, analizzava i caratteri del fascismo potenziale e della personalità autoritaria negli Stati Uniti, con un individuo “la cui struttura mentale e tale da renderlo particolarmente suscettibile alla propaganda anti-democratica” – ed è la realtà di oggi con la pianificata e accettata disarticolazione/cancellazione del bilanciamento dei poteri (tipico di uno stato di diritto), sostituito con governi (politici o tecnico-industriali) che si vogliono invece autocratici e incontrollati – come in ogni fascismo.
E oggi viviamo un ulteriore passaggio degenerativo/disruptivo della democrazia con il Tecnofascismo, come il titolo di questo nuovo saggio di Donatella Di Cesare (Einaudi, pag. 146, € 16.00) – che insegna Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma – e che ad ogni pagina ci interroga con saggezza e passione su questa che chiamiamo morte in progress della democrazia e a cui tutti stiamo partecipando: attivamente e deliberatamente alcuni (gli oligarchi del Tech, i tecnofascisti appunto, i propagandisti della paura); rassegnati o indifferenti, i più. Un saggio che è “il tentativo di inoltrarsi nella terra incognita del nuovo totalitarismo che si afferma in modo sempre più inquietante erodendo la democrazia. Termini fuorvianti, luoghi comuni, frasi fatte rischiano di produrre una nebbia interpretativa che, se da un canto impedisce di guardare al fenomeno nella sua gravità, dall’altro spinge a credere che si tratti di temporanee spinte regressive” e così “non ne viene colto il pericolo”. E soprattutto la sua globalità.
Un libro che non parla del passato, “bensì del futuro, o meglio di ciò che già si fa presente”. E tuttavia “i fantasmi del fascismo offrono un modello tutt’altro che fittizio e il procedere comparativo fa sì che la conoscenza di ciò che è accaduto ieri getti luce sugli eventi di oggi”: quando “la sospensione tecnica della democrazia si coniuga con una gestione dei popoli su base etnica” – e questa è la tesi centrale del libro, tesi che porta Di Cesare a usare appunto il concetto di totalitarismo e che anche noi usiamo per definire la società tecno-capitalista, oggi digitale. Creandosi una convergenza tra “due cardini apparentemente distanti, attorno ai quali però si organizza il mondo neototalitario, appunto la tecnica e il sangue” – il nuovo con il vecchio, ipermodernità con arcaismi, la tecnica e l’artificiale transnazionale con nazionalismi e sovranismi. Un totalitarismo che “non si imporrà con un atto di violenza brutale […] ma si insinuerà con zampe di velluto, senza troppi ostacoli e, dunque, senza ricorso a sopraffazioni palesi ed eccessivi abusi”. Anche perché la destra globale “è riuscita a spacciarsi per nuova aggirando censure e riprovazioni di un tempo” – e così si sono “aperte le porte a quegli spettri del passato che si riteneva fossero ormai impresentabili”, la destra tecnofascista producendo una amnesia di massa sul passato e così riuscendo persino a proporsi in nome della libertà, nel momento stesso in cui la nega.
Ecco quindi che “i nuovi regimi di guerra sono il passaggio in cui, mentre il capitalismo si lancia nell’impresa estrema di una devastazione catartica [sociale e ambientale], la nuova destra riduce la democrazia a etnocrazia e persegue una composizione monoetnica dei popoli. E dove dominano comunità chiuse, animate da suprematismo, non c’è posto per i migranti, quegli indesiderati che si possono deportare, quei superflui di cui è [diventato] lecito sbarazzarsi. E in questa gestione neototalitaria dei popoli, il rifiuto di coabitare con gli altri può portare non solo e non tanto all’epurazione, quanto alla pulizia etnica”. Perché dalla nostra paura di essere distrutti – la sostituzione etnica paventata dai produttori e gestori della paura – “alla distruzione dell’altro il passo è breve” – che sia distrutto da una guerra, da un genocidio o fatto annegare nel Mediterraneo o stuprato in un lager libico. Siamo cioè in una necropolitica globale e in una non-democrazia crescente, ma con il consenso di molti, di troppi.
E come avviene questa erosione della democrazia, in corso da tempo? – e ricordiamo un altro importante libro di Donatella Di Cesare, Democrazia e anarchia (Einaudi, 2024 – se ne parla qui). Quella democrazia “che non è un regime […] e proprio la sua flessibilità e la sua apertura sono invece baluardi contro ogni violenza che, dentro come fuori, potrebbe svuotarla ed esautorarla”. Due sono i modi, come anticipato, con cui si produce questa erosione, questa progressiva rimozione della demo-crazia e insieme la normalizzazione dell’anti-democrazia e dell’autocrazia: la prima è la tendenza tecnocratica, “che si traduce nella completa subordinazione all’economia di una politica ridotta ad anonima governance amministrativa, che fa il gioco di grandi imprese, industria militare e capitale finanziario. La seconda è la tendenza etnocratica che si realizza […] in una gestione dei popoli intesi come iperfamiglie, comunità naturali chiuse […], rese salde e stabili da legami di sangue e di suolo, capaci di essere ripari adeguati in un mondo sempre più caotico e inospitale”. Ma “l’Uno etnico è un collettivo paranoico”. È una mistificazione.

E il totalitarismo che si sta di nuovo producendo, dopo quelli novecenteschi, è allora “una patologia della democrazia, che si chiude e si inceppa”, alimentando il proprio dissolvimento. Ma “protagoniste del nuovo totalitarismo, verso cui il mondo sembra avviato, sono le élite occidentali che, incapaci di farsi carico del passato – dal saccheggio colonialista alle due guerre mondiali – si mostrano, anzi, decise a rivendicare la propria egemonia reclamando maggiori risorse e arrogandosi ulteriori diritti. Incuranti dell’impoverimento a cui è consegnato il resto del pianeta, aggravano le disuguaglianze, ovunque sempre più acute. […] Tutto pur di mantenersi al comando […]”. E dove “l’alleanza tra manager delle grandi aziende belliche, rappresentanti delle gerarchie militari e ceto politico non è che l’aspetto più subdolo di un capitalismo che coinvolge, consuma e devasta le democrazie spinte, per garantirsi benessere ed extraprofitti, a diventare principali azioniste del mercato della guerra” (come il riarmo dell’Europa), élite ferme ancora, aggiungiamo, al sempre falso, ma sempre molto profittevole per l’industria bellica e per l’industrializzazione della guerra, si vis pacem para bellum.
A queste élite “si è poi aggiunta una élite delle élite”, quella delle imprese hi-tech, “che concentra nelle proprie mani una quantità crescente di risorse e ne rivendica l’uso a pieno titolo e a proprio profitto”, determinando la fine anche dello Stato nazionale. Élite che “possono mantenersi salde appunto solo facendo leva su un immaginario arcaico”, come la nazione, il sangue & suolo che promette un’identità e soprattutto una immunità in realtà impossibili, ma utili, come immaginario collettivo, “alla gestione di popoli progressivamente spossessati di ogni kratos”. Perché al di là della propaganda apparentemente contraria, forte e funzionale è ancora una volta il “nesso ben saldo dei sovranisti con le reti transnazionali del capitale e della tecnica” – e non a caso tutti i sovranismi, nazionalismi, populismi (aggiungiamo) sono contro i sindacati e sono negazionisti del cambiamento climatico e meno che meno sono per una riforma del modello economico capitalistico (come invece invocato dall’IPCC) – cioè sono funzionali al tecnocapitale.
Di più: l’etnocrazia definisce “la riduzione sistematica del demos all’ethnos”, stabilendo il predominio di un presunto gruppo etnico omogeneo sulla molteplicità/pluralità che caratterizza invece il demos. E cioè la demo-crazia. Quindi “l’etnocrazia, pur mantenendo una facciata democratica, è a tutti gli effetti un regime non-democratico” – e la democrazia, come ricordato con Di Cesare, non è un regime, quindi “il demos non è un ethnos e la democrazia non è una etnocrazia”(per la contraddizione che non lo consente), anche se inglobare l’uno nell’altro “è un cardine del progetto politico delle nuove destre” – intanto arrivando a quella (per noi) oscenità/disumanità che si chiama remigration; che si chiama noismo, cioè (Di Cesare), “la forma sovranista del razzismo”; che si chiama Othering.
E nei capitoli del suo libro (“ogni capitolo ha una sua autonomia e può essere letto prescindendo dagli altri”), Di Cesare va in realtà a costruire la genealogia di questo tecnofascismo, a comporre il puzzle della sua autobiografia – e usiamo ancora Gobetti. E quindi – ma richiamiamo solo alcuni pezzi del puzzle – ecco la incapacità o la difficoltà di immaginare il futuro “che non ha forse precedenti nel passato”, perché “è tramontata ogni idea di progresso, “quel sogno che per secoli ha spinto gli esseri umani a marciare insieme verso obiettivi comuni; ma è venuta meno anche la fiducia che sia possibile incidere sul corso degli eventi”, oggi “ciascuna esistenza fa storia a sé”, sono recisi “i legami con le altre esistenze”. Così però “si rompe il patto tra le generazioni”, il futuro viene privatizzato (producendo “angoscia, ma anche violenza diffusa”), “non si immagina insieme il domani” (mentre – chiosiamo – si accetta il futuro predeterminato autocraticamente e con violenza ontologica e teleologica dalle imprese e dal capitale); ma “la privatezza del futuro è un ossimoro, un altro modo per dire: fine del futuro, arroccandosi nel presente”. E questa è la “disfatta della politica”, che ha perso ogni dimensione salvifica ma che soprattutto è “incapace di una visione complessiva, procede di emergenza in emergenza”. E infatti “l’irresponsabilità, la mancanza di risposte alle generazioni future, sembra il tratto peculiare della politica che evita sempre di parlare del diritto di coloro che non ci sono ancora”. E anche qui, tecnica ed etnocrazia si potenziano reciprocamente.
E persino l’etica “è stata via via corrosa, consumata, capitalizzata” in quello che Di Cesare chiama il capitalismo dell’etica – un’etica economicistica e tecnica (l’efficienza strumentale come unica etica, ammesso che sia un’etica, dell’ipermodernità). E quindi “è venuta meno l’immaginazione, il pensiero, che è sempre pensiero dell’oltre e dell’altro”, tutto si è ridotto a calcolo ripetuto, ad avere “un’anima monetaria” e anche gli umani sono diventati numeri/dati per essere meglio calcolabili e prevedibili. Un’etica secondo cui “tutto si negozia, mercanteggia […] dove si calcolano costi e benefici, si sceglie il male minore, [e vengono accettate] persino sevizie e torture […] se servono a garantire l’immunità dei cittadini” (“la frontiera come cordone sanitario”, con tutto che si riduce a “paradigma immunitario”; e la democrazia “non è più partecipativa, ma solo immunitaria”), finendo per “avallare e legittimare la situazione attuale” posto che “ogni alternativa è screditata in anticipo”.
E “se sulla politica incombe il crepuscolo della luce artificiale, sull’etica grava l’ubriacatura del disinteresse e l’indifferenza sovrana”. E gli uomini si svincolano/liberano così da ogni principio di responsabilità e tutto diventa permesso, anche il male assoluto del genocidio e dell’ecocidio e dell’ingiustizia e della forza. Dimenticando – come ricorda Di Cesare – che invece sempre “la responsabilità precede la libertà”, perché “la libertà non è autarchia, non è arbitrio […], ma c’è libertà solo in quanto c’è responsabilità” – che è “il nodo costitutivo di ogni esistenza”.
E “l’altro sono le ali che non ho” – scrive Di Cesare con bellissima immagine – ed è solo grazie a questo altro “che posso compiere il passo in fuori, che posso e-sistere. Senza questa uscita da sé verso l’altro, l’io non esisterebbe neppure”. Se invece neghiamo l’altro – anche quell’altro che sono la biosfera e le future generazioni – crediamo di esistere, felicemente immunizzati, mentre stiamo già morendo.