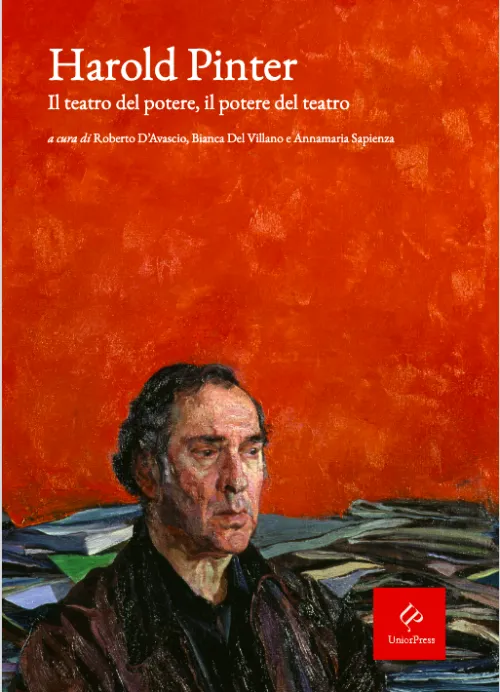Pinter, anatomia della sopraffazione
Nei primi anni della sua carriera di drammaturgo Harold Pinter è stato quasi unanimemente massacrato dalla critica, accusato di non avere nulla di interessante da dire, di essere oscuro, poco comprensibile e soprattutto di non confrontarsi con i temi urgenti dell’attualità. Troppo distante, si diceva, da quella linea del teatro inglese che, tra anni Cinquanta e Sessanta, faceva dell’impegno politico esplicito una sorta di dovere morale. A differenza di John Osborne o di Edward Bond, Pinter sembrava rifugiarsi in stanze chiuse, dialoghi ellittici, situazioni minime e fortemente ambigue (“assurde” si dirà poi sulla scorta di Martin Esslin), rinunciando a prendere posizione sul mondo. Eppure, la sua biografia racconta tutt’altro: un pacifista militante, obiettore di coscienza, che si espone su questioni di politica interna e internazionale, che fonda con altri scrittori un gruppo anti-thatcheriano, e che nel 1985, invitato all’ambasciata statunitense in Turchia per una cerimonia in onore di Arthur Miller, a tavola invece dei convenevoli fa un discorso violentissimo sulle torture contro la popolazione civile, ricavandone un’espulsione. Un intellettuale che per tutta la vita ha denunciato le violenze dei poteri costituiti, dalla politica estera statunitense al regime turco, fino alla feroce requisitoria pronunciata in occasione del discorso per il Premio Nobel ricevuto nel 2005.
Come è stato possibile che un autore, regista, attore, sceneggiatore tanto politicamente esposto sia stato a lungo percepito come disimpegnato? Il paradosso, evidentemente, è frutto di un fraintendimento – ancora diffusissimo – per il quale “arte politica” corrisponderebbe alla tematizzazione artistica di un certo conflitto politico o sociale ed eventualmente anche con il giudizio esplicito che la accompagna. Un’idea di impegno che coincide con la denuncia in qualche modo diretta. L’esatto contrario di quel che Pinter intendeva fare. Nel discorso di accettazione del Nobel ha infatti chiarito una volta per tutte la sua posizione sul tema, dicendo che “La verità drammaturgica è sempre elusiva”, che “non c’è mai una sola verità da trovare nell’arte drammatica”, che “la predicazione deve essere evitata a ogni costo” e soprattutto che “i personaggi devono poter respirare l’aria loro propria. L’autore non può porre loro dei limiti per costringerli a soddisfare i propri gusti o inclinazioni o pregiudizi”. Ma questa distanza dall’“impegno tematico” non riguarda solo le intenzioni dichiarate. È iscritta nella sua stessa scrittura, che mette in scena situazioni minime, chiuse in spazi domestici o neutri – una stanza riscaldata, un corridoio freddo, un seminterrato, una pensione sul mare – dove il tempo si dilata, le parole si inceppano, l’attesa diventa norma e il potere agisce come qualcosa di incorporato nella vita quotidiana. Nei suoi testi il drammaturgo inglese ha preferito infatti raccontare sì la violenza, ma quella che secondo meccanismi sempre identici si consuma nella più microscopica e fondamentale delle relazioni, quella tra una persona e un’altra persona. Le sue opere giovanili, puntualmente ambientate in una stanza chiusa da una porta dietro la quale incombe una qualche forma di minaccia, rappresentano l’emblema di una scrittura che non ha bisogno di riferimenti a fatti reali per raccontare con intenso effetto di realtà certi meccanismi della prevaricazione sui quali il drammaturgo non smetterà mai di riflettere. L’autore, quintessenza dell’intellettuale attento alle cose politiche del mondo, ha d’altronde spesso insistito su una distinzione cruciale. Se come cittadini siamo chiamati a distinguere il vero dal falso, a prendere posizione (cosa che lui ha puntualmente fatto), nell’arte dobbiamo diffidare delle verità assolute, perché la realtà non si lascia mai chiudere in una sola forma. È questa tensione, e non la sua risoluzione, a rendere il suo teatro straordinario: una scrittura che rifiuta la predica per non rinunciare alla responsabilità.
È di recente apparso per UniorPress un volume dedicato all’opera del drammaturgo curato da Roberto D’Avascio, Bianca Del Villano e Annamaria Sapienza, Harold Pinter. Il teatro del potere, il potere del teatro, che ha esattamente il merito, tra gli altri, di affrontare di petto uno degli aspetti che più hanno contribuito a depoliticizzare Pinter ai suoi esordi drammaturgici: l’uso del pinteresque come categoria interpretativa. Nato per indicare un’atmosfera – l’ambiguità, il silenzio, la sospensione – questo termine ha finito nel tempo per trasformarsi in una scorciatoia critica, riducendo talvolta la complessità politica della sua scrittura a un tratto stilistico riconoscibile, quasi a un marchio. Alcuni dei contributi del volume mostrano invece come proprio ciò che è stato a lungo letto come cifra estetica – l’indeterminatezza, la ripetizione, l’assenza di coordinate, la banalità delle situazioni – costituisca il cuore della riflessione pinteriana sul potere, sottraendola definitivamente all’equivoco di un teatro “dell’enigma” o, peggio, del disimpegno. Liberato dall’aura di mistero in cui è stato a lungo confinato, il teatro di Pinter riemerge qui per quello che è, ovvero una scrittura che non tematizza il potere ma lo mette drammaturgicamente in funzione.
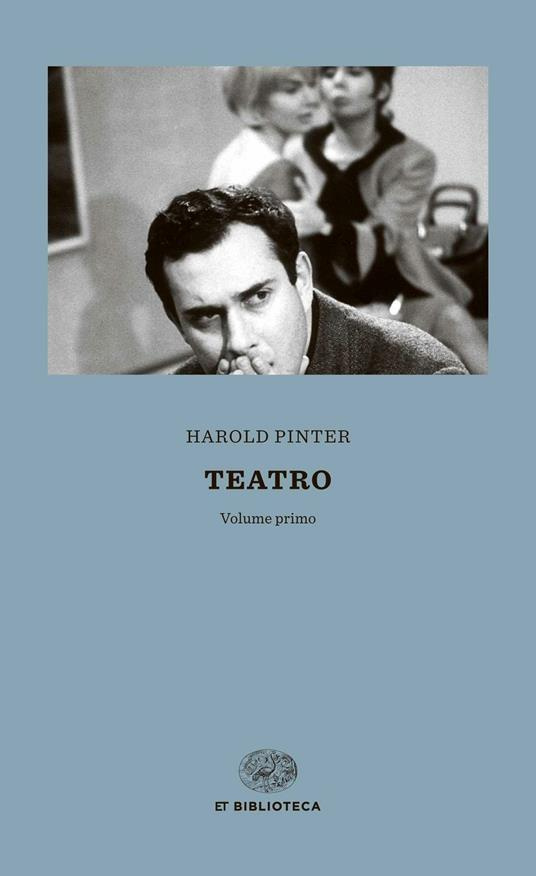
Basta tornare alle prime opere per vedere come questo dispositivo entri subito in azione. In The Room la scena è ridotta all’essenziale: una stanza riscaldata, una donna che parla senza sosta, un marito quasi muto. Rose riempie lo spazio con le parole, descrive il freddo del corridoio, la pericolosità delle scale, l’ostilità dell’esterno. Il linguaggio funziona come una difesa, come una barriera fragile contro una minaccia che non è ancora presente ma che incombe. Quando l’intruso arriva non porta rivelazioni né spiegazioni, non chiarisce nulla. La violenza non esplode, si deposita, e la stanza, che sembrava un rifugio, si rivela per quello che è, un luogo già attraversato dal potere, già organizzato secondo una gerarchia di voci, di presenze, di silenzi. In The Dumb Waiter il meccanismo si fa ancora più evidente. Due sicari attendono ordini in un seminterrato. Parlano di cibo, di giornali, di piccoli fastidi quotidiani. Nulla che, in apparenza, abbia a che fare con la violenza. Quando il montacarichi del titolo comincia a scendere dall’alto trasmettendo richieste assurde, ordini impossibili da soddisfare che ancora una volta non riguardano direttamente atti violenti ma qualcosa che ha a che fare con del cibo da servire, l’obbedienza si impone come un dato di fatto. È una violenza procedurale, amministrata, che non ha bisogno di manifestarsi come tale per funzionare. Il potere non appare sotto forma di comando esplicito, ma come una catena di gesti, di risposte dovute, di responsabilità sempre spostate un po’ più in là. È forse in The Birthday Party che questa dinamica raggiunge il suo punto più disturbante. L’arrivo di Goldberg e McCann in una pensione sul mare trasforma progressivamente un contesto banale in uno spazio di sopraffazione. Le domande rivolte a Stanley non cercano risposte: lo destabilizzano, lo confondono, lo svuotano. Non sappiamo quale colpa abbia commesso, né a quale “organizzazione” appartengano i suoi persecutori. Ma la colpa prende forma sotto i nostri occhi, prodotta dal linguaggio stesso. Qui il potere non ha volto, non ha ideologia, non ha motivazione dichiarata. È già all’opera nel modo in cui le parole vengono usate, ripetute, deformate, fino a rendere impossibile ogni resistenza.
Queste opere giovanili mostrano con chiarezza ciò che il volume mette in vario modo in luce: in Pinter il potere non coincide mai con l’evento traumatico, ma con il processo che lo prepara, con l’insieme di micro-spostamenti attraverso i quali una relazione diventa asimmetrica, una voce prevale sull’altra, un individuo viene progressivamente isolato. È in questa dimensione microscopica, quotidiana, che la violenza assume la sua forma più efficace, proprio perché smette di apparire eccezionale. Ma anche quando, negli anni successivi, Pinter renderà il contesto politico più riconoscibile, come in One for the Road o Mountain Language, il meccanismo resterà sostanzialmente invariato. Cambiano i riferimenti, non la struttura. Il torturatore di One for the Road parla con calma, quasi con cortesia; l’umiliazione passa attraverso il linguaggio prima che attraverso il corpo; l’abuso si presenta come normale amministrazione dell’ordine. Ancora nel discorso per il Nobel Pinter osserva che i torturatori si annoiano facilmente, che hanno bisogno di divertirsi. La violenza, anche in questo caso, non è eccezionale, è quotidiana, ripetitiva, noiosa. In Pinter le stanze, le conversazioni apparentemente insignificanti, le attese senza evento non sono il contrario della Storia, ma il suo livello più elementare, quello in cui il potere prende forma prima di diventare sistema, legge, istituzione; quello in cui si apprendono l’obbedienza, l’adattamento, l’accettazione di una gerarchia che non ha bisogno di giustificarsi. I suoi testi mostrano come la violenza nasca spesso dall’ordine stesso, dal suo funzionamento regolare, dalla sua capacità di presentarsi come normale amministrazione delle cose.

È in questo senso che le nozioni di pinteresque e di assurdo così come sono state a lungo utilizzate, appaiono spesso insufficienti se non fuorvianti. Trasformando un dispositivo politico in una cifra stilistica hanno infatti contribuito a disinnescare la forza di una scrittura che lavora proprio dove il potere preferisce non essere visto, cioè nella normalità delle relazioni, nell’apparente insignificanza delle situazioni. Mark Taylor-Batty, per esempio, critica la lettura di Pinter come autore dell’Assurdo e mostra come quella cornice abbia consolidato una percezione depoliticizzante della sua drammaturgia, riportando al centro concetti come autorità e abuso. Più che testi enigmatici The Room, The Dumb Waiter e The Birthday Party appaiono come veri e propri laboratori della sopraffazione quotidiana. Un’attenzione analoga al funzionamento della scrittura emerge nel contributo di Roberto D’Avascio, che concentra l’analisi sugli spazi pinteriani: stanze, corridoi, luoghi di passaggio, ambienti apparentemente neutri. Spazi che non fanno da semplice sfondo all’azione, ma che organizzano le relazioni di potere, stabilendo soglie, asimmetrie, possibilità e impossibilità di movimento. La stanza riscaldata di The Room o il seminterrato di The Dumb Waiter non sono mai luoghi protetti: sono dispositivi che producono soggezione, che isolano, che preparano il terreno all’intrusione e all’abuso. Margaret Rose mette invece a fuoco il modo in cui la parola, in Pinter, smette di essere strumento di comunicazione per diventare strumento di controllo. Rose legge infatti l’opera dell’autore inglese come un’indagine sulle identità minacciate, dove la coercizione – esercitata da individui o istituzioni – arriva a incidere sulle capacità linguistiche e sui processi mentali, fino all’annientamento.
L’interesse che questo autore continua a suscitare sulle scene deriva forse proprio dalla sua capacità di raccontare una forma di violenza pervasiva e procedurale (non quella dei chiaramente cattivi contro i chiaramente buoni) che, decennio dopo decennio, si è fatta sempre più intensa. Una violenza che si esercita attraverso l’amministrazione e si mimetizza nella quotidianità, diventando infrastruttura della relazione. Pinter mostra che il potere comincia nel momento in cui una voce riesce a imporsi su un’altra senza dover spiegare il perché, anticipando qualcosa che oggi riconosciamo con fin troppa facilità: il fatto che il potere più efficace non è quello che reprime apertamente, ma quello che organizza, distribuisce ruoli, assegna posizioni, produce comportamenti senza doverli imporre in modo esplicito. In questo senso il nuovo volume è prezioso, perché restituisce a Pinter la sua radicale concretezza. Chiarisce che la dimensione politica del suo teatro non risiede nella denuncia diretta, ma nella capacità di fare della scena uno spazio di analisi, dove i meccanismi dell’autorità vengono messi in funzione a vista. Le testimonianze raccolte nella seconda parte del volume – registi, attori, traduttori, da Roberto Andò a Lino Musella, da Elena Bucci ad Alessandra Serra – confermano quanto questo teatro sia tutt’altro che astratto o enigmatico. Pinter chiedeva agli attori una precisione quasi crudele, perché sapeva che ogni sbavatura psicologica avrebbe depotenziato il meccanismo che gli interessava di più: l’esposizione nuda delle dinamiche più sottili di sopraffazione.