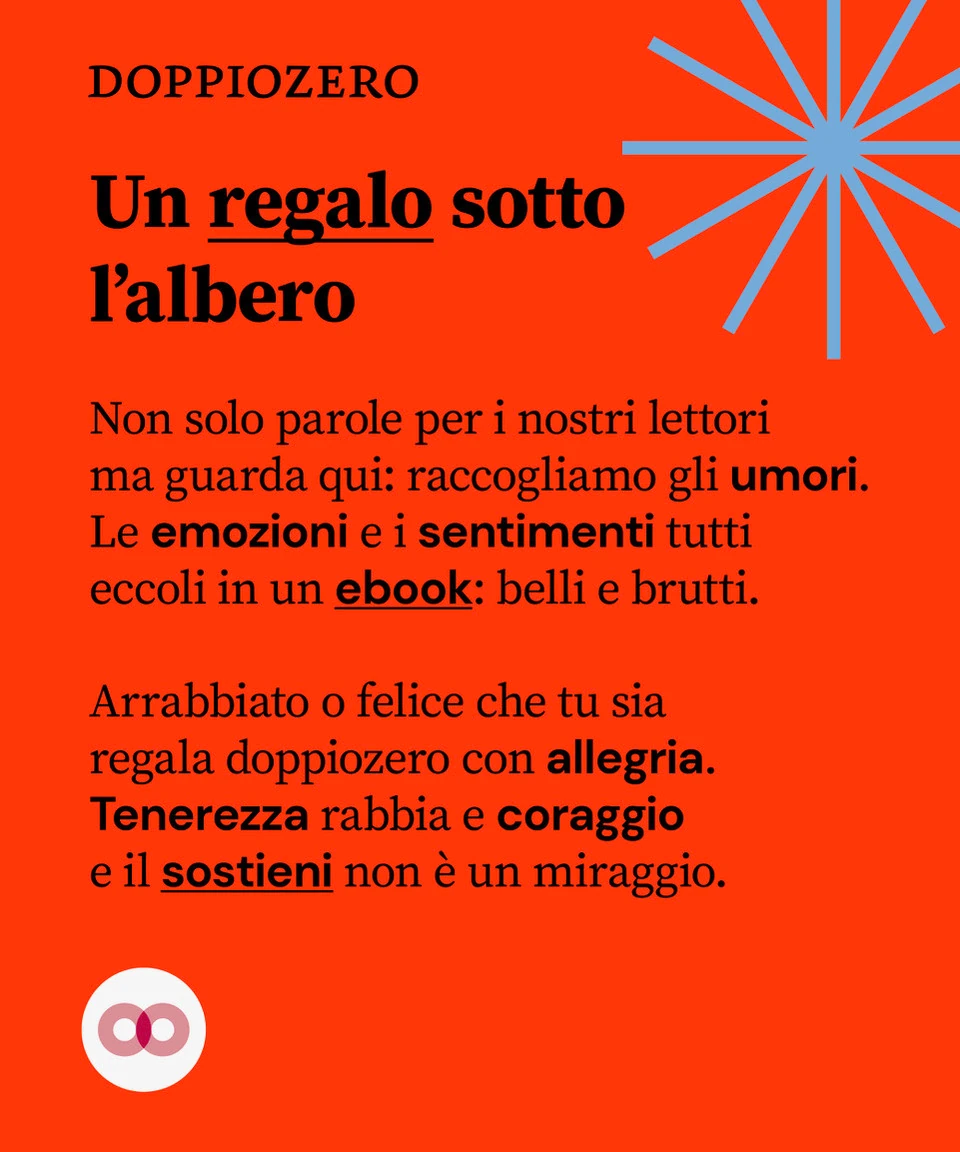Clorofilla / Sequoie sul tetto del mondo
Penso ai fortunati che al mattino spalancano le persiane e l’hanno a distanza di naso. E penso a lei – è al contempo maschio e femmina, quindi, meglio lei – che non riesce a sgranchirsi i rami, penso al deprimente spettacolo che vede dalla sua cima: una Brianza lecchese verde di colline un tempo, ora devastata da un’edilizia demente; dirimpetto, l’indigesto ossimoro delle squadrate ville a schiera di un rinomato architetto dalla mano infelice (almeno in questa occasione), arredate, si fa per dire, da una improbabile, bianchissima, neoclassica fontana, dono dell’homo œconomicus di questo territorio, che ora aspira a divenire re quirinalizio degli italiani.
È una sequoia, un esemplare di Sequoiadendron giganteum: vent’anni fa un fulmine l’ha scapitozzata abbassandola di parecchi metri, ma fa ancora la sua figura nella corte, che le sta un po’ stretta, di Villa Cornaggia a Merate. O meglio, quella che fu Villa Cornaggia, anch’essa ridotta a un complesso residenziale lontano dagli antichi fasti ma, almeno, più affabile delle nuove abitazioni cubiformi che lo fronteggiano.

Fu piantata da Paolo Passoni, fattore della nobile famiglia Cornaggia-Medici, nel 1878 o giù di lì. La nipote, appassionata vivaista, mi racconta la storia del suo arrivo tutta avvolta nella iuta; l’avevano regalata al marchese ed era, allora, dono prestigioso.
Gli europei scoprirono la Sequoia sempervirens grazie alla spedizione esplorativa lungo la costa dell’Alta California guidata dallo spagnolo Gaspar de Portolá. A redigere i diari di viaggio era il missionario francescano Juan Crespi che ne registrò il rinvenimento in data 15 ottobre 1769.
Tuttavia, i semi giunsero sul vecchio continente solo nel 1840 grazie al botanico austriaco Stephan L. Endlicher. Nel 1853 è il raccoglitore inglese William Lobb ad introdurre i semi di una specie simile, reperita sulle pendici della Sierra Nevada californiana. Venne battezzata Sequoia gigantea (o Wellingtonia gigantea); poi, nel primo spicchio del secolo scorso, catalogata come Sequoiadendron giganteum. Dunque, quella meratese è tra le prime ad essere arrivata in Italia. Il nome sequoia omaggia George Guess Sequoyah, figlio di una nativa americana e di un colono tedesco benemerito perché inventore dell’alfabeto della lingua Cherokee.
Sono piante entrambe longeve, di inusitate dimensioni e altezze: nella residuale zona d’origine, la fascia costiera tra Oregon e California, possono campare millenni e superare i cento metri in altezza. In vero, i reperti fossili europei dell’Eocene ci parlano di estese foreste di sequoie che, per le glaciazioni, si ridussero vieppiù fino a scomparire. Oggi, ammiriamo gli individui ottocenteschi tornati a noi come trofei di parchi nobiliari e giardini botanici, benché nei nostri areali difficilmente s’innalzino oltre i cinquanta metri.

Molti i caratteri che le accomunano: ciascuna fa genere a sé ma appartengono all’ordine delle Coniferales, famiglia delle Taxodiaceae, sono monoiche, cioè con strutture riproduttive maschili e femminili separate ma sullo stesso soggetto, producono coni terminali maschili, più piccoli, e femminili che evolvono in strobili legnosi. Prediligono terreni freschi, umidi e profondi, benché la Sequoiadendrum ben sopporti i climi rigidi (nel suo habitat naturale vive ad alte quote) non amate dalla sempervirens. Adulte, hanno portamento conico-piramidale, tronco dritto e di notevole circonferenza, scorza color cannella, spessa, fibrosa percorsa da fessure che col passare del tempo si fanno costolute, e chioma persistente. A distinguerle all’occhio sono gli aghi fogliari: nella sempervirens sono lunghi circa 20 millimetri, piatti ma non pungenti, a inserimento distico (cioè non perfettamente opposti), verdi nella pagina superiore argentati nella inferiore; nella gigantea sono molto più corti (4-8 mm.), squamiformi a sezione triangolare, rigidi, con apice rivolto verso l’esterno, inseriti sui rametti in verticilli spiralati, le fronde appaiono d’un verde intenso con sfumature glauche.
I Sequoia & Kings Canyon National Parks tutelano le ultime foreste di questi alberi arcaici sopravvissuti al disboscamento dissennato. Si trovano qui alcuni degli esemplari monumentali come i famosi “General Grant” e “General Sherman”, dall’età stimata attorno ai 2.500 anni. Nella contea di Mendocino con i suoi 113 metri svetta sul manto verde degli alberi normodotati una sempervirens a lungo considerata la più alta, salvo poi scoprirne altre con qualche metro in più. Salire lassù dev’essere un po’ come scalare le montagne e raggiungere il tetto del mondo.
Sembrano sfidare l’eterno ma basta una calamità naturale o un fiammifero gettato da mano incauta per metterle a repentaglio, com’è accaduto lo scorso settembre quando un fulmine ha innescato l’incendio che ha minacciato anche il “Generale Sherman”. È stato salvato dai pompieri grazie anche a grandi teli ignifughi avvolti attorno alla base del tronco (11 m. di diametro).

Della battaglia per la salvaguardia di uno di questi giganti verdi scrive Richard Powell nel bel romanzo Il sussurro del mondo, premio Pulitzer 2019, tradotto da Licia Vighi per i tipi della milanese Nave di Teseo. Qui gli alberi hanno la stessa dignità narrativa dei personaggi. È romanzo arboreo fin nella struttura, organizzato com’è in quattro sezioni – radici, tronco, chioma, semi – con vicende che ramificano e si intrecciano tra loro. Otto le storie radicali da cui prende avvio, ciascuna con un protagonista umano, eccetto il caso di una coppia, e altrettanti alberi di riferimento: castagno, gelso, acero, quercia e tiglio, abete di Douglas, leccio, faggio, ginkgo. C’è chi si rende conto di quanto la sua vita abbia ruotato attorno all’ultimo castagno – il vero patriarca della famiglia – che il padre, con un rituale di devozione, ha fotografato ogni mese per catturarlo, vederne il vero aspetto; chi ha a che fare con l’albero della seta da cui proviene la fortuna della famiglia, messo a dimora nella nuova patria per onorare un nonno lontano; chi diviene rosso come l’acero che è stato piantato alla sua nascita; chi non sa distinguere una quercia da un tiglio e capisce che «piantare qualcosa» in giardino e guardarlo crescere regala un senso alla vita, qualsiasi essa sia; chi in guerra è stato salvato da un baniano (Ficus benghalensis) e si dedicherà a piantare piccoli abeti nell’impari tentativo di contrastarne il disboscamento; chi cadendo da un leccio, paralizzato sarà costretto su una sedia a rotelle ma diventerà un mago informatico, inventerà un gioco di ruolo ambientato in un «arboreto intergalattico»; chi, come Patty la pianta «dura-d’orecchio-e-di-favella» con la guida del padre, amante dei faggi, gli alberi li conosce uno a uno fin da bambina e da botanica scoprirà quanto in una foresta essi siano una comunità, socializzino, si sincronizzino, si parlino, emettano segnali. E c’è chi, come una cieca, non vede l’albero bizzarro e giurassico che vive davanti a casa.
Le loro esistenze finiranno per convergere, come la linfa verso la cima, e si troveranno a combattere insieme nel movimento di rivolta in difesa delle millenarie sequoie vittime degli interessi del capitale.
Davanti e dentro a Mimas, il gigante su cui saliranno nell’ultimo tentativo di salvarlo dalle lame assassine, ecco la reazione di Guardiano e Capelvenere, i soprannomi di Nick del castagno e di Olivia la fulminata, che ora, dopo la cecità che le impediva di vedere il gingko persino nello splendore della dorata livrea autunnale, sa vedere. Così, il primo e l’ultima dei protagonisti delle storie si chiudono a cerchio intorno al tronco di Mimas:

«Alcuni suoni fuoriescono dalla bocca di Nick, sillabe che significano vagamente, Oh, Gesù benedetto. Ha visto alberi giganteschi per settimane, ma mai uno come quello. Mimas: più vasto in larghezza della fattoria del trisavolo di suo padre. Lì, mentre il tramonto li ammanta, l’atmosfera è primitiva, darshan, un faccia a faccia con la divinità. L’albero si innalza dritto come una montagna isolata dalle pareti ripide a forma di camino, e sembra dimenticare di fermarsi. Da sotto, potrebbe essere Yggdrasil, l’albero cosmico, con le sue radici nel mondo sotterraneo e la chioma nel mondo in alto. A poco meno di otto metri da terra, un tronco secondario sbuca dall’estensione del fianco, un ramo più grosso del Castagno degli Hoel. Altri due tronchi si allargano più in alto lungo il fusto principale. Nell’insieme assomiglia a un esercizio di cladistica, l’Albero Filogenetico della Vita – un grande idea che si frantuma in un’intera nuova famiglia di rami, lassù nel corso di molto tempo
[…]
Guardarono insieme: agrimensori funamboleschi di una terra appena scoperta. Lo spettacolo gli scioglie il cuore. Nuvola, montagna, l’Albero Cosmico, e la foschia – tutta la ricca e complessa solidità della creazione che, per prima cosa, ha dato origine alle parole – lo lascia intontito e muto. Tronchi reiterati si sviluppano dal ceppo principale di Mimas, balzano in alto paralleli come le dita di una mano alzata del Buddha, recuperando l’albero madre su scale più piccole, ripetendo di continuo la forma congenita, i loro rami che confluiscono l’uno nell’altro, troppo intricati e uniti per riuscire a seguirli. La nebbia ammanta la canopia. Da un varco nella chioma di Mimas, i pinnacoli ornati di ciuffi di tronchi vicini sono avvolti a spirale nella foschia di un paesaggio cinese. C’è più sostanza negli sbuffi grigiastri che nelle guglie verde-marroni che spuntano tra di essi. Tutt’intorno si dipana una favola fantasmagorica ordoviciana. È mattina come la mattina in cui la vita è comparsa la prima volta sulla terraferma».
Ce lo insegna magistralmente Mircea Eliade, che le leggende nordiche e i riferimenti alla spiritualità indiana citati da Powell ha studiato: gli alberi giganti manifestano il sacro insito nella loro verticalità, nella loro potenza, nella forza che si rigenera. Il grande albero riassume e ripete il Cosmo, è teofania cosmica, e in esso abitano gli dei. In molte e diverse tradizioni e mitologie il cosmo è rappresentato come un albero maestoso, oppure ne è l’asse, il sostegno piantato al centro della terra che la collega al cielo, tant’è che gli sciamani nel loro viaggio mistico scalano un albero (o un palo che lo rappresenta).
Ma il divino sta anche nel piccolo, nel comune filo d’erba che calpestiamo senza badarci: «Ciechi davanti alle piante. È la maledizione di Adamo. Vediamo soltanto le cose che ci somigliano. Una storia triste, non credi ragazzina?» dice il padre a Patty.
Impariamo a guardare alberi, fiori ed erbe, a vederli. Staremo tutti meglio.
Buon anno.