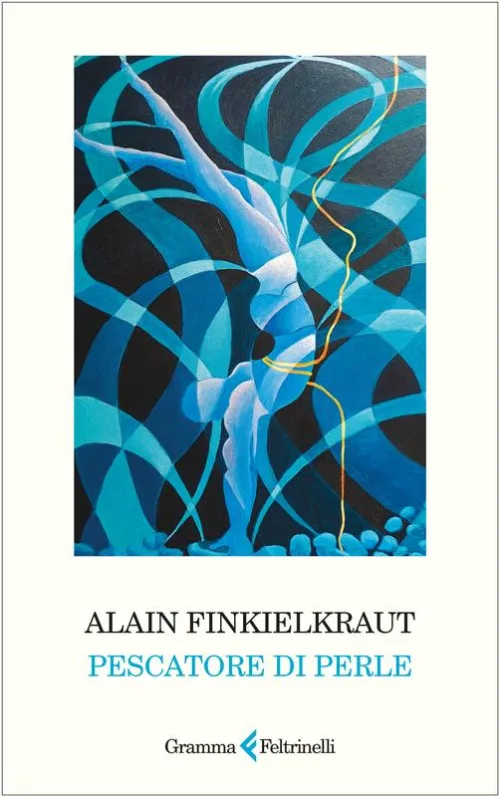Le finte perle di Finkielkraut
Il filosofo, giornalista e accademico di Francia Alain Finkielkraut è stato spesso incluso, assieme a Pascal Bruckner, Philippe Muray, Régis Debray e Michel Houellebecq (per citarne solo alcuni) fra i “nuovi reazionari”. Per gli accusatori, di sinistra, i nuovi reazionari sono quegli intellettuali occidentali che, in nome di un ritorno all’ordine, all’autorità, alla restaurazione dei valori e delle identità costituite, si schierano contro il presente e la sua religione “progressista”. Tale religione, da una decina d’anni, ha assunto una divisa che va sotto il nome di “wokismo” (da woke, termine che in inglese significa “sveglio”, “vigile”, “all’erta”), inteso come comportamento sensibile a tutte le ingiustizie sociali e politiche. Il “progressista woke” è antirazzista; attento all’identità di genere; contrario alla discriminazione etnica e alla negazione dei diritti della comunità LGBTQ; contro ogni abilismo, ovvero contro ogni discriminazione nei confronti delle persone “diversamente abili”; convintamente green; desideroso di lasciarsi alle spalle secoli di tesori linguistici al fine di proteggere, attraverso una “nuova lingua”, tutte le differenze di genere; curioso, spesso fino a farsi portavoce delle varie correnti trans-umaniste, di tutto ciò che le nuove tecnologie hanno in serbo per il futuro.
Per gli accusatori, di destra, tipo Finfkielkraut, il wokismo è una forma ipocrita di censura e di revisionismo che, mentre da una parte si attiva con grande strepito performativo contro tutte le discriminazioni che l’Occidente ha perpetrato e perpetra ai danni di donne, bambini, omosessuali, transessuali, disabili etc., dall’altra parte ritiene accettabili, di buon grado e con un certo compiacimento, forme di discriminazione come il razzismo anti-europeo, l’anti-semitismo, gli improperi e i sarcasmi verso le persone di una certa età (ageismo) e, in generale, l’odio, neppure tanto strisciante, contro i maschi bianchi (caucasici) ed eterosessuali, colpevoli di stare ancora al mondo.
Nell’ultimo capitolo del suo libro, Pescatore di perle, il filosofo francese stila un lungo e ironico elenco in cui mette alla berlina i comandamenti dei partigiani del progresso a tutti i costi. Eccone alcuni esempi: “Le mucche, le galline e i maiali vivevano meglio prima degli allevamenti intensivi!”; “La maturità era migliore quando non era uno scherzo”; “L’elitarismo per tutti era meglio dell’antielitarismo”; “ ‘Vietato vietare’ aveva molti difetti, ma era comunque meglio della cancel culture”; “la sinistra era migliore prima di sostituire la difesa della laicità con la lotta alla discriminazione”; “L’uguglianza era migliore prima della scrittura inclusiva”; “il passato era migliore quando veniva studiato e non incriminato”…
Mi verrebbe da dire: c’est trop facile Monsieur Finkielkraut! La Controriforma anti-wokista, che si vuole liberale e conservatrice dei valori culturali e politici dell’Occidente non esisterebbe senza l’eterna Riforma progressista che pensa che l’unico modo per accedere a un mondo migliore sia quello di un costante cambiamento delle istituzioni e delle leggi. Sono le due facce della stessa medaglia. Una medaglia ideologica che gli uni e gli altri desiderano apporsi al petto nella speranza di avere l’ultima parola.
La sinistra, dopo la fine del comunismo in Unione Sovietica, riposta la bandiera antitotalitaria, ha messo sotto processo l’Occidente colonialista, razzista e sessista. I riformatori si sono trasformati in inquisitori. Ma mi chiedo: si può davvero erigere un tribunale alla propria Storia, al punto di leggere le opere del passato non per imparare ma per eliminare i pregiudizi che i nostri classici, avendo vissuto colpevolmente nel XIII o XVI secolo, non sono riusciti a superare? E una volta identificato il massimo colpevole nel maschio bianco europeo e americano, il rapporto tra dominati e dominanti avrà finalmente un lieto fine? Sostituendo il proletariato con le minoranze e la critica al capitalismo con la critica all’uomo bianco, l’antioccidentalismo di una gran parte della sinistra occidentale sta facendo davvero gli interessi delle moltitudini?
Il tribunale che la sinistra “wokista” ha eretto per giudicare una volta per tutte le discriminazioni che nel corso della sua storia plurimillenaria l’Occidente ha compiuto ai danni delle minoranze, trova il suo naturale contrappeso nella difesa delle origini religiose ed etniche da parte della destra, per la quale in Occidente, e in particolare in Europa, una seconda società, estranea ai valori della nostra tradizione, sta cercando di imporsi al suo interno, puntando al separatismo, o addirittura alla secessione, il tutto con la nostra complicità attiva o passiva. Per la sinistra, questo nuovo popolo, afferma la destra, è anche un nuovo elettorato. Per Finkielkraut, ebreo di origine polacca, ad esempio, il rifiuto dell’integrazione in nome dell’antirazzismo, in Francia, si spinge fino ad abbracciare la giudeofobia che dilaga nei quartieri popolari da quando i più anziani li hanno lasciati. La sinistra, un tempo laica e repubblicana, continua il filosofo francese, punta su questa trasformazione. “Spera che, grazie al nuovo popolo, potrà un giorno andare al potere in una Francia libera dalla Francia e libera dall’Europa”.

Leszek Kolakowski (1927-2009), pensatore e storico polacco, fatto fuori dalla nomenklatura comunista del suo paese per aver dichiarato che lo stalinismo non era un’aberrazione, ma la logica conclusione dei precetti marxisti, in un suo saggio intitolato Come essere socialista-conservatore-liberale (1978), riportato da Finkielkraut, affermava che l’unico modo, dopo l’epoca dei grandi totalitarismi, per tentare di vivere in un “mondo comune”, era quello di voltarsi verso il passato e di procedere con esso: “Avanzate all’indietro, per favore!”.
Oggi, ovvero da almeno tre decenni, ciò è impossibile. Per ecologisti, femministe, intellettuali liberal-libertari e progressisti di ogni risma il passato è per definizione il Male, essendo il Bene, infatti, racchiuso, anzi murato, nel presente. Ma per gli anti-wokisti alla Finkielkraut il Male è il presente, essendo il Bene racchiuso, anzi murato nel passato! Nessuno “mondo comune” all’orizzonte. “Mondo comune”: dove la frontiera tra passato e presente è errante, indefinibile, continuamente attraversabile, priva di doganieri di destra e di sinistra.
Che cosa succede? Da una parte, l’Occidente, preso da una smania autolesionista rifiuta in blocco la propria eredità culturale, dall’altra si rifugia in una pratica altrettanto autolesionista, rifiutando le altre civiltà e riproponendo un ideale di purezza che ha già funestato in lungo e in largo il XX secolo. Da una parte, sembra che ci sia ancora molto da conservare e trasmettere alle generazioni future, mentre dall’altra, il presente è così smisurato da non poter essere comparato con altre epoche della Storia. Da una parte, le opere del passato non sono più in grado di emancipare gli individui e di renderli intellettualmente autonomi, dall’altra si attende una rivoluzionaria dimensione conoscitiva dalla relazione tra individuo e Intelligenza Artificiale. Con chi essere d’accordo?
Non so. Quel che so è che l’Occidente, che viene dal latino “occidere”, che significa “tramontare”, ha smesso di rinascere. In una recente intervista Finkielkraut, riprendendo un pensatore tedesco di origine ebraiche, Éric Weil, ha affermato che, sin dalle origini della nostra civiltà, “i filosofi greci e i profeti ebrei si sono domandati che cosa fosse la giustizia e non se i costumi del loro tempo fossero i più giusti”. La nostra tradizione è, che lo vogliamo o no, universalista e “se vuole mantenere il suo vero valore e non solo la sua forza materiale”, non potrà fare altro che domandarsi che cosa sia giusto, al di là del suo modo di praticare la giustizia. “La nostra tradizione è la tradizione che mette costantemente in discussione i propri valori e che in ogni momento del suo destino storico ha dovuto decidere e continuerà a dover decidere cosa dobbiamo fare per avvicinarci alla verità, alla giustizia e alla saggezza. La tradizione che non si accontenta della tradizione”. Ecco cosa intendo quando dico che un “mondo comune” è possibile solo se tra passato e presente la frontiera resta aperta, solo se i partigiani del passato e i partigiani del presente si incontreranno alla frontiera sempre errante della “tradizione che non si accontenta della tradizione”, di una tradizione, cioè, che conserva l’autorità del passato nella misura in cui il presente non ritiene irreparabile la sua perdita e scopre sempre nuovi modi di mettersi con esso in relazione.
Il titolo del libro di Finkielkraut, come l’autore ricorda nel prologo, rimanda al saggio di Hannah Arendt su Walter Benjamin che amava collezionare citazioni. Affascinato dall’immagine, il pensatore francese ha costruito la sua opera a partire da alcune citazioni che, come scrive, gli hanno aperto la via alla riflessione: sull’amore, la morte, il pensiero filosofico, l’Europa, l’istruzione, la cancellazione del passato, l’ebraismo, il ruolo della donna, il riso, la democrazia…
Vi si sono possono trovare molti spunti interessanti, soprattutto per comprendere come il risentimento di sinistra che fa a pezzi chiunque si sia macchiato di una colpa nei confronti di qualsiasi minoranza etnica, politica o sessuale, trovi il suo corrispettivo nel risentimento di chi, come l’autore, vorrebbe farla finita con la vendetta del presente nei confronti del passato e si proclami per una rinnovata “gratitudine fondamentale per le poche cose elementari che ci sono invariabilmente date” (Arendt).
Ma di perle benjaminiane non ne ho trovate. Finkelkraut, come tutti i pensatori, usa i concetti. Benjamin, che non era un pensatore, ma uno scrittore, era un pescatore di parole. Del resto, Benjamin viene da Goethe e Baudelaire, dalle “affinità elettive” dell’uno e dalle “correspondances” del secondo: ogni fenomeno dello spirito, per lui, era connesso alla sua manifestazione materiale. Gli interessava la relazione che esiste tra un qualsiasi fenomeno, per quanto irrilevante, e il filo nascosto che li tiene uniti e che ci consente di dare i contorni a un momento storico. Come scrive bene la Arendt: “senza essere un poeta, egli pensava poeticamente e dunque finiva per considerare la metafora la più alta dote del linguaggio”. Da qui le sue perle.
Aveva qualcosa che alla maggior parte dei pensatori manca, soprattutto ai nostri giorni, ovvero una percezione acuta della messa in scena estetica del mondo e una comprensione sensuale dell’oggetto di indagine. Era consapevole, infatti, che il principio di non contraddizione la può far da padrone finché vuole, ma una società umana non si regge e non si governa senza le arti.