USA: Uomini e fucili
Il cow boy e lo sceriffo. L'agente segreto, il detective. Il killer. Gli eroi dell'immaginario americano hanno un tratto inconfondibile. Sono solitari, individualisti, di poche parole. Gente abituata a cavarsela con le proprie forze in un mondo ostile. Uomini con la pistola. È l'orizzonte culturale che racconta, più di tanti numeri e statistiche, la secolare fascinazione dell'America per la violenza e le armi da fuoco.
Due libri, a cinquant'anni di distanza, esplorano quest’orizzonte e la mitologia di cui si nutre: La Repubblica dei fucili di Richard Hofstadter (trad. Paolo Bassotti, Luiss University Press, pp. 190) e Una nazione bagnata di sangue di Paul Auster (trad. Cristiana Mennella, Einaudi, 128 pp.).
Storico e sociologo, Hofstadter scrive fra la metà degli anni Cinquanta e i primi Settanta, in uno dei periodi più tempestosi della storia moderna degli Stati Uniti: la guerra del Vietnam, le proteste, la nascita delle Black Panthers, gli assassinii di John Fitzgerald Kennedy, Malcolm X e Harvey Milk. Lo scrittore Paul Auster intreccia invece ricordi, storia familiare e memoria collettiva per riflettere su un'America dove i massacri nelle scuole sono diventati routine e la violenza politica registra un'impennata senza precedenti. Cinquant'anni separano questi due sguardi ed è abbastanza per misurare quanto poco sia cambiato in una nazione che fatica a fare i conti con se stessa.
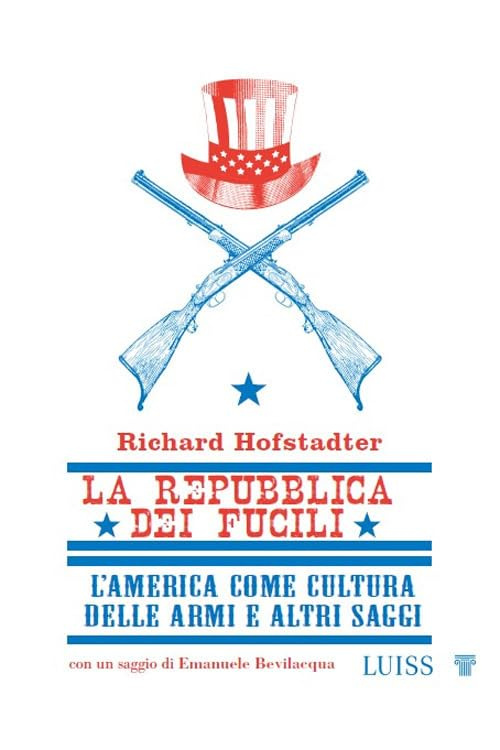
“Per due o tre anni, una volta smessi i pannolini, ho girato con una rivoltella a sei colpi appesa al fianco,” ricorda Auster, nato nel 1947. “Ero un texano, anche se vivevo nella periferia di Newark, New Jersey, perché nei primi anni Cinquanta il Selvaggio West era ovunque, e infinite schiere di bambini americani sfoggiavano un cappello da cowboy e una comune pistola giocattolo.”
È la nascita di quell’immaginario che Hofstadter identifica come la chiave di volta della cultura americana delle armi. I film western che scandiscono l'infanzia di Auster – fra i suoi favoriti Hopalong Cassidy e Il cavaliere solitario – declinano nell’intrattenimento popolare la narrativa in cui lo storico individua le radici culturali della violenza in America: il pioniere armato, l’epica del West, la lotta per l’Indipendenza.
È il mito di fondazione del Paese. Una tradizione che, in una lettura discutibile della storia, attribuisce la vittoria sull’Inghilterra e la conquista della libertà non alle truppe regolari ma all’eroismo delle milizie popolari. Un modello che nella libertà di armarsi e organizzarsi in gruppi armati vede al tempo stesso un diritto personale e il necessario contrappeso democratico alla tirannia e al potere centrale. È il dettato del Secondo emendamento della Costituzione (l’unico che tutti conoscono a memoria) che nella pratica diventa un via libera alle armi da fuoco.
La portata del fenomeno è impressionante. "Gli Stati Uniti sono la sola nazione industriale dove la legge consente a un gran numero di abitanti di possedere fucili e pistole," scrive Hofstadter negli anni Settanta. Cinquant'anni dopo, Auster aggiorna il conteggio. “Secondo una recente stima dell’Istituto di ricerca del Children’s Hospital di Filadelfia, le armi attualmente possedute dagli abitanti degli Stati Uniti ammontano a trecentonovantatre milioni – piú di una per ciascun uomo, donna e bambino del Paese”.
Oltre metà degli americani dichiara di possedere o aver posseduto un’arma. I controlli sono limitati, le leggi caotiche e i conflitti di competenze fra stati e livello federale regalano infinite scappatoie. La facilità d’acquisto e un fiorente mercato clandestino fanno il resto. Intanto, la possibilità di stampare in 3D i componenti mette in discussione la stessa possibilità di regolare le vendite. Hofstadter già notava l'anomalia: "In America è più facile comprarsi una pistola che un'automobile". Mezzo secolo dopo, nulla è cambiato e casomai va peggio.

Le armi sono un accessorio scontato e un oggetto di consumo. In farmacia e in ospedale, al supermercato e in biblioteca, un cartello all’ingresso ricorda che è vietato introdurre armi da fuoco. Nei fine settimana d’estate, i Gun Show attraversano l’immensa provincia americana con il loro campionario di pistole, fucili, munizioni e gadget. Nel Sudovest, dove la cultura delle armi è spiccata, sono un appuntamento atteso – un colpo d'occhio sulle novità e l'occasione per toccare con mano gli ultimi modelli.
Il risultato, scrive Auster, è che “ogni anno, circa quarantamila americani muoiono in seguito a ferite d’arma da fuoco, cifra che corrisponde grosso modo al tasso annuale di decessi sulle strade e autostrade americane. Oltre la metà delle suddette quarantamila vittime di armi da fuoco sono suicidi, che rappresentano a loro volta la metà di tutti i suicidi in un anno”.
Dalle mie parti, in Louisiana, le sparatorie al venerdì sera sono un'abitudine – è il giorno in cui si fa festa, bastano uno sgarbo o una parola di troppo e la situazione precipita. Il lunedì mattina si contano i morti e i feriti. Si piange, si prega. Poi si ricomincia da capo.
La violenza politica sembra avviata nella medesima direzione. Oggi, come negli anni Settanta, le cronache grondano sangue e si fatica a tenere il passo – i tentativi di assassinio contro Donald Trump, l’uccisione a metà giugno in Minnesota della deputata Melissa Hortman e suo marito. Senza dimenticare, a fine 2024, l’assassinio di Brian Thompson, CEO di United Healthcare, per mano di Luigi Mangione, che ha scoperchiato una rabbia sociale profonda. In fatto di armi, il segnale più eloquente arriva però da Kamala Harris che in piena campagna elettorale ha annunciato di possedere una pistola. A noi italiani fa impressione ma qui è un messaggio rassicurante. Sono una come voi, una capace di proteggersi. Una che mai vi toglierà le armi.
Poi ci sono americani come Paul Auster, che non ha mai posseduto una pistola. Come tanti bambini, a dieci anni ha imparato a sparare al campo estivo. È un tiratore nato e non dimenticherà mai quella sensazione. “Sentivo un legame tra me e qualcuno o qualcosa a grande distanza da me, e lanciare una palla o sparare un proiettile e colpire il bersaglio in nome di un obiettivo predeterminato [...] produceva un profondo e ardente senso di soddisfazione e di trionfo. Ciò che contava era il legame, e che lo strumento di quel legame fosse una palla o un proiettile, la sensazione era la stessa”.
Ma poi tutto finisce lì. Vive in città, nessuno dei suoi va a caccia, nessuno parla di comprare una pistola o un fucile per autodifesa. A vent’anni scoprirà che la reticenza dei suoi cela una storia dolorosa. Sua nonna ha ucciso il marito, suo nonno, con due colpi di pistola. “Mio padre aveva sei anni e mezzo, e mio zio, il bambino che aveva assistito all’omicidio con la candela in mano, nove”. È un episodio di inspiegabile violenza che distrugge una famiglia e lascia una traccia indelebile nei figli e nei nipoti.
A partire da questa consapevolezza, Auster cerca risposta alla medesima domanda che mezzo secolo prima ossessionava Hofstadter. Perché l’America è ossessionata dalla violenza? E come si può definire un fenomeno così sfuggente e pervasivo? Negli Stati Uniti, scrive Hofstadter, la violenza “manca di un centro ideologico e geografico; manca di coesione: è stata troppo multiforme, diffusa e spontanea da poter scaturire in un solo odio duraturo e radicato, condiviso da intere classi sociali”. È violenza privata, abuso di cittadini contro altri cittadini. Da secoli, spiega, coesiste con una cornice di sostanziale stabilità e anche per questo la si tollera e si fatica a mettere un freno.
La violenza è così ingranata nel sistema da essere diventata invisibile. “Quando si tratta di violenza, tendiamo a perdere la memoria, e gran parte dei nostri eccessi passati li abbiamo sepolti nella storia”, scrive Hofstadter. Le morti, le stragi e gli attentati si dipanano in una sorta di eterno presente. A ogni massacro si invocano nuove leggi. E ogni volta la questione finisce nel dimenticatoio – come se non fosse un’emergenza nazionale. Una minaccia che ogni giorno pesa sulla testa di tutti gli americani.
Negli anni Settanta, la Commissione nazionale sulla violenza denunciava “l’amnesia storica” degli americani sul tema. Mezzo secolo dopo, Paul Auster conferma la diagnosi. E le foto in bianco e nero di Spencer Ostrander che accompagnano il suo racconto dicono il resto. Sono scuole, supermercati, parcheggi. I luoghi anonimi di oltre trenta sparatorie di massa che mostrano come la violenza sia diventata parte del paesaggio quotidiano.

Il cinema e la letteratura rifrangono quest’oscillazione costante fra amnesia e denuncia. “Il tema della violenza, e anche la sua rimozione, è sempre stato molto presente nei lavori degli autori, cineasti e artisti americani, con effetti contrastanti: hanno contribuito a rafforzare l’amnesia o al contrario sono diventati un appello a non dimenticare gli atti di prevaricazione provocati o subiti nel corso della storia del Paese”, scrive Emanuele Bevilacqua nel saggio introduttivo a La repubblica dei fucili. Il retaggio di film come Nascita di una nazione (1915) e Via col vento (1939), con i loro stereotipi razzisti, ancora pesa sulla coscienza collettiva. La storia recente, ricorda, è però ricca di lavori che esplorano il tema in chiave ben diversa: da Forrest Gump a Comma 22 a La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead.
Lo spirito dei tempi viaggia però in direzione opposta. Il discorso pubblico diventa sempre più crudele, i social rimandano ogni attacco su scala planetaria creando nuovi fenomeni di emulazione. Intanto, la nuova popolarità del genere New Western – a partire dalla serie Yellowstone (2018 – 2024) – segnala un deciso ritorno al mito di fondazione. Dallo schermo al boom della musica country alla moda, gli Stati Uniti sembrano oggi aspirare a un impossibile recupero del passato. La conquista della frontiera, la sfida tra l’uomo e la natura, l’individualismo. È il sogno di una vita tradizionale che ormai resiste solo ai margini del paese o nei ranch dei miliardari. Il segno di una riscossa conservatrice che recupera miti ed eroi radicati nel profondo dell’anima americana.







